
1.
In quello che molti considerano l’ultimo quadro di Brueghel, si vede una navicella sul mare in tempesta, dove dei marinai stanno gettando una botte a una balena che ha l’aria di attaccarli. In quella che alcuni considerano la più straordinaria opera di Jonathan Swift, A Tale of a Tub (nella mia traduzione Favola della botte), troviamo la stessa immagine presentata in apertura e offerta come spiegazione del titolo. Quando i marinai sono attaccati da una balena, ci viene detto, le lanciano una botte per distrarla e così evitare il cozzo. Può darsi che l’immagine di Brueghel e il titolo di Swift fossero associati in qualche vecchia stampa, avendo lo stesso sottinteso morale, e forse anche con simili riferimenti politici. Nel quadro di Brueghel, a quanto pare, la botte per distrarre la balena sarebbe un emblema della follia umana – della comune propensione a farsi catturare da attrazioni immediate, così come in un altro quadro di Brueghel c’è una scimmietta che si è lasciata catturare con una nocciolina. Il titolo di Swift allude a qualcosa del genere, perché la vecchia espressione tale of a tub corrispondeva a ciò che noi diremmo “frottola”, “panzana”, “fola”: un racconto per attirare e gabbare i gonzi.
La prefazione del libro dice che un alto comitato britannico si è riunito per discutere sui pericoli che vengono dai begl’ingegni o intellettuali d’epoca, i quali con le loro critiche minacciano di recare gravi danni alla Chiesa e allo Stato. Ed ecco cosa sarebbe la balena, simbolicamente interpretata: sarebbe quel pericolo incombente, ma soprattutto sarebbe il libro di Thomas Hobbes, Leviathan ( del 1651), da cui gli intellettuali d’epoca ricavavano le loro armi critiche. Quel libro viene indicato come un mostro che sconvolge ogni tradizionale idea politica, perché propone una teoria materialistica dello Stato, e indica la morale come una pura regola di convenienza. La nave sarebbe qui l’antica nave del consorzio umano-cristiano, minacciata dalla balena mitica dell’Antico Testamento – il Leviatano del titolo di Hobbes. Ma cos’è la botte lanciata alla balena? Sarebbe il libro che stiamo leggendo, scritto per essere gettato in pasto ai begl’ingegni o intellettuali d’epoca, per distrarli e incantarli con le parole, in attesa di altri e più seri provvedimenti per stornare il loro assalto alla Chiesa e allo Stato. Questo dovrebbe spiegare il titolo. Il che porta subito a farci un’idea del libro, come una fola o panzana sulla politica, sulle diatribe religiose, sulla cultura d’epoca, ma anche sul trattatismo modernista che serve a svagarsi a forza di fatuità e nuovi concetti, con libri come questo (Tale of a Tub = panzana) infarciti di panegirici e divagazioni erudite che non portano da nessuna parte. Il nostro libro infatti è presentato come l’opera d’uno di quei pennaioli d’epoca, autori di compilazioni di brani scelti o di volumi scritti per sfruttare una voga; ed è un compendio di richiami all’attualità, un elogio delle attrattive del nuovo, una dichiarata imitazione di autori modernisti, scritta per “l’universale progresso dell’umanità”. È la parodia di tanti libri futuri che vorranno salvare il mondo con una frottola, e anche un profetico trattato sull’epoca moderna come epoca dell’informe, del disordine assoluto nello stato delle cose.
2.
La Favola della botte è il primo libro di Jonathan Swift, pubblicato nel 1704, anonimamente come tutti i testi di Swft e come la massa di trattati e libelli politici o religiosi, stampati in Inghilterra dai tempi della rivoluzione puritana. Non soltanto per l’attribuzione a un anonimo pennaiolo, anche per l’accumulo di luoghi comuni e fiori di eloquenza libresca nelle sue pagine, questo sembra un libro che vuol confondersi con la massa di inutili chiacchiere della carta stampata, che vuol sprofondare nel calderone delle vanità letterarie, dei trattati che nessuno leggerà, delle scimmiottature di discorsi sapienziali, dei centoni senza capo né coda. C’è qualcosa di speciale e unico in questo trattato: come il progetto di parlare assolutamente a vuoto, di mostrare fino in fondo la propria inconcludenza, con nugoli di discorsi che girano intorno a un buco, dove non si scorge il famoso Nulla, bensì il Caos. Si scorge l’informe trambusto di un’epoca che già si vanta d’essere moderna per partito preso.
Questo è un libro che ha avuto una fama europea, con traduzioni settecentesche in francese, olandese e tedesco, ma rimasto ignoto in Italia fino ai nostri giorni. Io l’ho scoperto ai tempi dell’università, attraverso un’antologia di testi swiftiani che includeva alcuni suoi capitoli, e subito mi è venuta voglia di tradurlo tutto in italiano, dal momento che nessuno l’aveva fatto. Anche in Inghilterra ha vissuto nell’ombra, perché considerato dai critici troppo violento e contrario ai principi della morale e della religione. Incluso nella miscellanea di opere swiftiane del 1720, ha avuto un’onorevole ristampa nelle opere complete di Swift pubblicate nel 1814 a cura di Walter Scott; poi nel 1920 un’edizione critica, e soltanto nel 1986 un’edizione a prezzi popolari, per la Oxford University Press. Dopo l’università ho azzardato la prima traduzione, faticosa e mal riuscita; ma ancora trovavo il libro solo nelle biblioteche, nell’edizione Scott; e le antologie swiftiane che ero riuscito a procurarmi lo escludevano del tutto o quasi.
Ricordo l’impressione che mi faceva allora: uno sbandamento davanti al suo radicalismo che non lascia in piedi nessun appiglio per mettersi a posto la coscienza; un’ammirazione per la sua vivacità serio-comica; una continua sorpresa per il suo modo d’installarsi nel disordine senza vederlo più dall’esterno. Cito una frase dall’introduzione all’antologia swiftiana di W.A. Eddy: “Se Swift è stato ammirato e temuto più che amato, è perché non scrive una lingua del cuore”. Era questo aspetto inamabile, anti-seduttivo, inconciliabile con le finzioni di bontà, con ogni vernice romanzesca e umanizzante, che mi attirava e colpiva più di tutto. Swift scrive come un alieno che vede l’umanità come una specie votata al falso, presa all’amo da tutti gli inganni. Il suo è un tono così innaturalmente distante che lascia di stucco; ma anche con improvvise invettive o sarcasmi che mettono a disagio il lettore in cerca di conforti nella carta stampata. Swift “non scrive una lingua del cuore”. Ma l’effetto delle sue pagine che rimane in mente è quello d’un discorso nitido e inconfondibile, dove le parole perdono la loro qualità discorsiva e prosastica, facendo volare l’immaginazione. Non è il volo dell’immaginazione romanzesca, ma quello del puro stile che ci sposta frase per frase in un altro spazio, uno spazio indecidibile, dove le nostre opinioni e valutazioni non contano più niente.
3.
Facendo un vaglio di tutto quello che Swift ha scritto, ci si accorge che quasi tutto è ricalcato su modelli di smercio dalla carta stampata ai suoi tempi; ad esempio: almanacchi popolari, predizioni astrologiche, lettere pubbliche sui giornali, proposte di riforme politiche, trattati sulle nuove scoperte, manuali di buone maniere, etc. Se si leggono le sue opere di fila, si attraversa un’enciclopedia di generi ovvi e poco prestigiosi, imitati con grande precisione. Non solo generi ameni, anche scritture di pedanti, e soprattutto produzioni della celebre Grub Street, la strada londinese popolata da pennaioli al servizio dell’industria tipografica – tribù a cui appartiene il supposto estensore della Favola della botte. Quelli sono i veri eroi swiftiani: gli scribacchini che vivevano alla giornata, in anni di boom del mercato librario, riscrivendo vecchie novelline, compilando libri di brani scelti, oppure redigendo “seconde parti” apocrife di libri di successo, come quelli di Cervantes, Boccalini, La Bruyère. A parte pochi casi, i testi di Swift si fingono scritti da pennaioli del genere, oppure da proponitori di progetti politici, da venditori di almanacchi, da artigiani che hanno deciso di impugnare la penna, e da altri personaggi coinvolti nei traffici e illusioni della carta stampata. C’è sempre in Swift un sapore di inanità stampata, di mondo tipografato come un mondo innaturale, alieno e popolato da alieni. Domanda: fin quando il mondo a stampa può essere sorprendente o perturbante come in Swift? Direi finché le parole stampate restano discorsi anonimi, non ancora intestati alla figura umanizzante dell’autore. Così formano un mondo apocrifo, come i graffiti che leggiamo sui muri o i messaggi osceni nei gabinetti pubblici. Ci appaiono come enunciati che sono diventati cose, senza un rapporto ricostruibile con chi li ha pensati, e neanche giustificati da alcuna sacralità. Sono soltanto pezzi del nostro mondo, sparsi e strani, che non si sa da dove spuntino. Questo vale anche per il libro qui tradotto, dove ci si perde tra discorsi che sembrano raccattati di qua e di là, con spesso dei puntini di sospensione per indicare che manca un pezzo. In particolare le digressioni sono dei brani sfusi, ognuno come un esercizio di stile che va per conto suo. Spesso non si vede neanche la differenza tra digressioni e argomenti portanti, e tutto sembrerebbe gettato lì a caso, con lo strascico d’altri pezzi in appendice, come se fossero stati persi per strada. Poi nelle note che svariano e tracimano a pie’ di pagina, anche il principio d’autorità diventa dubbio, perché sono note d’un anonimo curatore che cerca di decifrare cosa voglia dire il testo, o persino note di critici ostili, riprese per condimento del libro. La sua struttura generale, nella ricostruzione di Angus Ross e David Wooley (ediz. Oxford Univerrsity Press, 1986), mostra un mosaico di pezzi che stanno assieme come per miracolo: 1) Una spina dorsale del libro, dove si racconta la storia dei tre fratelli, Peter, Jack, Martin, che rappresentano il cattolicesimo, il protestantesimo, e la chiesa anglicana. È la storia dei conflitti religiosi dopo la riforma luterana. Sono cinque capitoli alternati alle digressioni, ma a loro volta con digressioni fantasiose sul cattolicesimo e il puritanesimo. La storia dei conflitti religiosi è una specie di allegoria, ma in forma d’un teatro dei burattini: burattini su una scena fantastica, che litigano, sbraitano, si prendono a calci, invasi da dottrinali manie.
2) Alternate ai capitoli burattineschi, ci sono cinque digressioni, come fiori di retorica, divaganti al massimo, genere trattatistico senza capo né coda. C’è l’acidissima “digressione sui critici”, la mirabolante “digressione alla maniera dei moderni”, la svagante “digressione in lode della digressione”, la folle digressione in lode della follia, e l’altra detta “un’altra digressione”.
3) Il libro si apre con un elenco dei trattati attribuiti al nostro pennaiolo, che è un catalogo di stravaganze. Poi viene una “Apologia” del libro, poi la dedica al protettore, poi la nota del libraio-editore, poi una straordinaria “Epistola al Principe Posterità” (affinché renda immortale questo povero libretto), poi la prefazione in cui si spiega il titolo, e infine l’introduzione vera e propria. Tranne la “Apologia ” e la dedica, sono tutti contorni che prendono in giro le interminabili prefazioni dei libri più reputati e l’eloquenza rancida dei panegirici.
Questo coacervo di pezzi non potrebbe reggersi senza la finzione d’un anonimo estensore, il pennaiolo modernista. Giudicando dalle parole che scrive, costui pare un vero alieno nel mondo normale dei vivi, oppure un matto, invaso dall’illusione di scrivere un libro che verrà tradotto in tutte le lingue, compreso il cinese (dice lui). Come succede con i matti, non possiamo avere con lui nessun rapporto di umana comprensione, e le sue pagine sono parole vaganti in un iperuranio di riferimenti dotti, oppure un teatro di burattini mossi da in ignoto burattinaio, che non ha bisogno di essere originale per trascinarci nel suo universo umbratile. Tutto questo poi è un segno d’epoca: sono le ultime tracce ridicole di vecchie stranezze da trattatismo barocco, all’alba di una nuova era più scientifica e pragmatica. Dopo Swift il problema dei letterati sarà quello di trovare vernici umanizzanti, inventando la figura dell’autore come sorgente umana e originale delle parole, con finzioni realistiche sempre più complicate e spesso romanzescamente pesanti. Ma se le cose fossero rimaste come a tempi di Swift, non c’era neanche bisogno di inventare i mondi alieni della fantascienza.
4.
Prendiamo in mano qualche opera di Swift, per farci un’idea del loro contenuto. Prendiamo un suo serio discorso che propone di ridurre il cristianesimo a religione puramente nominale – il che, dice, eliminerebbe gli scrupoli di coscienza, ma mantenendo certi aspetti utili della religione, come il gusto piccante del peccato, lo sfruttamento politico dei vescovi, i fruttuosi commerci con popoli pagani. Oppure prendiamo un suo serio discorso per proporre ai signori inglesi di gustare nei loro pranzi una nuova raffinata vivanda, la carne di bambini irlandesi, fatti arrosto, in fricassea o in salmì –con spiegazioni per dimostrare come ciò sarebbe un modo nuovo e illuminato di risolvere i problemi della miseria irlandese. Oppure prendiamo un altro discorso molto serio sulla possibilità di stabilire scientificamente se le merde che si incontrano per le vie di Dublino vengano da deretani irlandesi o britannici. Oppure la Favola della botte, che alla pubblicazione ha scatenato le penne vendicative di critici, di eruditi, di filo-religiosi, e d’altri che cercavano del marcio nelle cose che non capivano.
Ci si chiede: Swift avrebbe potuto scrivere discorsi così striglianti se non fossero stati diffusi nell’anonimato delle parole tipografate? Certo, non sarebbe stato comodo autenticarli con la propria firma. Ma, come nota l’estensore della “Apologia”, l’anonimato “non è uno spiacevole diversivo, né per l’autore né per il pubblico”. Infatti Swift gioca molto con l’anonimato. Sfrutta l’effetto delle parole tipografate, che ci arrivano su un supporto anonimo, come un pezzo di muro, un foglio inchiostrato. In questo modo le parole non hanno più l’aria di qualcosa di umano e familiare che ci accomuna. Il loro senso prorompe in noi lettori come se non fosse più la traccia d’una comune enunciazione, bensì come senso assoluto, vertigine di significati incontrovertibili. Ed è la simulazione totale che s’imporrà con i giornali. Negli scrittori che verranno dopo si perderà il senso di questa vertigine, e delle mille truffe che ci vanno dietro. Il gusto di quell’inganno è ancora fresco in Rabelais, che si fa beffe di tutti gli almanacchi popolari e dei libri dotti che saccheggia. È fresco anche in Cervantes, che ne parla molto nel Don Quijote, e non per niente ha inventato un eroe che non capisce la differenza tra il mondo degli uomini e quello della carta stampata. Si può dire come si vuole: tutte le parole possibili, appena toccate dall’alienità dell’inchiostro tipografico, sembra che acquistino il diritto di pretendere da noi attenzione. Questa magia dell’inchiostro tipografico ha il suo risvolto nella Favola della botte. Se tutte le parole stampate hanno il diritto di pretendere la nostra attenzione, tutte diventano simili. Non importa se siano futili, false o plagiate, e neanche se girano a vuoto senza guidarci da nessuna parte. Infatti alla fine l’estensore dice che è questo un esperimento “per scrivere su niente, lasciando andare la penna avanti da sola”.
Nella conclusione è anche detto che un libro è come un viaggio dove ognuno può far sosta quando vuole ad ammirare il paesaggio, passeggiando e scegliendo il sentiero che più gli piace; dove però ogni compagno di viaggio che abbia fretta di arrivare alla meta è un seccatore da scaricare subito. È una parabola che porta un’aria di libertà dagli obblighi della sensatezza, di apertura al puro svago. Ma c’è dell’altro. Il libro divagante come un viaggio senza meta, scritto “su niente, lasciando andare la penna avanti da sola”, è un buco da cui viene su un turbine di parole che non hanno più un centro, nessuna ragione d’essere, nessun fondamento. Sono parole della carta stampata, dove non si capisce più se il falso e la futilità possano essere soggetti a imputazioni, o se siano invece l’elemento mercuriale a cui devono affidarsi tutti i nostri concetti. In questo universo ciarliero e volatile, non si sa più dove stia di casa una verità moralmente garantita, nei libri o altrove. Swift era un lettore di Cervantes, e questo mi fa venire in mente un episodio del Don Quijote (parte seconda, cap. LVIII), con una strana discesa agli inferi, in cui si vedono dei diavoli che giocano a palla con libri moderni pieni di stoppa e di vento. È un’immagine che potrebbe essere l’emblema dello scenario swiftiano, dove il sociale è un gran teatro di falsificazioni, e dove tutti i libri stampati, in quanto tramiti del sociale, non possono essere che palloni pieni di stoppa e di vento.
5.
La Favola della botte è la serio-comica esaltazione d’una nuova epoca della vita sociale: l’epoca delle parole volatili, che non possono enunciare più nulla se non l’istantanea falsificazione che spandono. In apertura c’è un discorso sulle macchine oratorie che diffondono nell’aria parole in competizione, nella guerra delle opinioni politiche o giornalistiche. Queste sono parole che non hanno senso ma soltanto peso, perché è secondo il peso della produzione di carta stampata che si valutano i meriti delle diverse fazioni politiche. Nella “Epistola al Principe Posterità”, si dice che le parole sono ormai come nuvole inafferrabili d’un giorno ventoso, già sostituite da nubi a forma diversa dopo un minuto, tutte destinate a fluttuare un attimo e perdersi nel nulla. Ormai esiste solo la parola volatile, l’arguzia che vale soltanto un attimo, l’aneddoto che ha senso per un giorno, il libro che domani nessuno ricorderà più. In questa visione, la carta stampata è il veicolo dell’informe senza più contorni; è in sé creazione del mondo, d’un mondo virtuale fatto di ventosità momentanee che si perdono nel niente, dove è chiaro che le parole non possono più diffondere messaggi credibili.
Ma occorre approfondire lo scenario che Swift ci racconta. Un pamphlet swiftiano, L’arte della menzogna politica, pubblicato nel 1710, narra il grande sconvolgimento avvenuto nel mondo con l’entrata in scena della Fama, intesa come il trionfo dei giornali. Questa diventa l’arma fondamentale, non più del Diavolo ma della figura modernissima del Mentitore Politico. Il Mentitore Politico è il rappresentante del regime parlamentare, che parla solo secondo gli interessi del suo partito; e combinando menzogne e informazioni della carta stampata può sempre “trasformare un ateo in santo, un nero in bianco, o un farabutto in rappresentante dell’onestà”. Ma, aggiunge l’autore, il Mentitore Politico deve avere la dote della memoria corta: ossia deve saper dimenticare istantaneamente ogni menzogna che ha detto, ritenendo ogni volta di avere detto la verità, e mentendo di nuovo quando dovrà ridirla, con una menzogna che a sua volta diventerà una verità su cui mentire. Così potrà sempre giurare su entrambi i corni d’una contraddizione, mentendo in ogni caso, ma in più mettendo fuori gioco ogni criterio per distinguere il vero dal falso. Se poi, dice il pamphlet, si abbandona la logica e si accusano i politici di spergiuro, perché invocano sempre Dio e la morale, si sbaglia di nuovo. Infatti loro non credono né all’una né all’altra cosa, dunque non sono neanche spergiuri. E nel caso in cui una menzogna venga pubblicamente smascherata? Se è stata detta al momento opportuno ha già svolto la sua funzione, perché ha un puro valore strategico secondo il luogo e l’attimo in cui è diffusa. La Menzogna vola come il Tempo, mentre la Verità zoppica arrancando per raggiungerla, e quando sta per raggiungerla, quella è già altrove a spandere le sue falsificazioni. Il vecchio motto, secondo cui la Verità trionfa sempre, è passato di moda.
6.
Riassumendo: nello scenario che Swift racconta è sorto un “deficit di verità”. Inutile voler vedere se questo corrisponde al vero, appunto perché si parla del suo deficit, il Deficit del Vero. Siamo lontanissimi dagli autori satirici che condannano i vizi del mondo come se li guardassero dall’alto d’una collina, con un manuale di precetti morali sottobraccio. Leggendo i testi di Swift, non si riesce più a mettersi la coscienza in pace con quel trucco. Nei suoi discorsi, si è subito in balia delle parole volatili, subito nell’effimero, dentro al “deficit di verità”, nelle formule canoniche della carta stampata. Il lettore si trova senza più il salvagente d’una verità morale a portata di mano, perché tutto fluisce nei moti mercuriali del linguaggio.
Fissato questo punto, posso tentare uno schizzo del teatro swiftiano, il suo theatrum mundi. Intanto: che tipi di spettacoli si recitano? Swift doveva essere un appassionato di manicomi, perché in quegli anni entra a far parte del comitato di gestione del manicomio di Londra, poi avrà un incarico nella workhouse di Dublino, con funzioni simili a quelle d’un manicomio; e infine lascerà una parte dei suoi beni per costruire il manicomio di Dublino. Ma la cosa che qui interessa è un’abitudine di quei tempi, quando la buona società andava a guardare i matti nelle loro celle, come spettacolo a pagamento. Nel Diario a Stella (13 dicembre 1710), Swift annota che lui e un gruppo di amici, in un pomeriggio d’inverno, sono andati a vedere i leoni della London Tower, poi i matti del manicomio, poi le sale della società scientifica detta Royal Society, e infine un teatrino di marionette. Mi colpisce che quei quattro tipi di spettacolo siano presentati insieme nel giro d’una frase, come svaghi simili. Il teatrino swiftiano si ispira a questi generi di svago, che sono altrettanti aspetti d’un teatro del mondo: gli spettacoli da zoo, la Wunderkammer scientifica, il teatro delle marionette, e infine quello dei matti.
In particolare l’associazione tra spettacolo dei matti e quello degli scienziati della Royal Society, mi pare il fulcro di questa veduta. Perché il sapere è visto come un gonfiamento, ed è rappresentato da personaggi in preda a una follia orgogliosa galoppante: scienziati, astrologi, filosofi, pennaioli, progettisti di riforme. Di qui scatta la proposta più provocatoria del suo theatrum mundi, di vedere tutte le istituzioni basate sullo stesso tipo di gonfiamento orgoglioso come attività manicomiali. È l’idea del IX capitolo nella Favola della botte, dove si caldeggia l’uso di matti del manicomio per assolvere a compiti amministrativi, politici, scientifici. E per mostrare quali vantaggi porterebbero i matti alla società, il nostro pennaiolo cita casi di monarchi, predicatori, filosofi che hanno compiuto grandi imprese perché avevano il cervello bacato. Il capitolo termina con una descrizione del manicomio, certamente ispirata allo spettacolo dei pazzi nel manicomio di Londra: ognuno nella sua cella a fare gesti strani, a parlarsi da solo, a strabuzzare gli occhi, a pascolare nelle proprie feci. È un’immagine che pare l’emblema del teatrino swiftiano – questo enigma nell’uomo che è la pazzia, che lo riduce a uno spettacolo di puri fatti corporei, tic, fetori, agitazioni, feci e urina – ecco l’uomo al suo terminal naturale. Ma è proprio il linguaggio “senza cuore” di Swift, a farne lo spettacolo estremo di tutti i gonfiamenti orgogliosi, e insieme l’allegoria di qualcosa che sta dietro a tutti gli addobbi sociali: il disordine e l’informe del corpo bruto. E questo è lo sfondo ultimo d’un theatrum mundi affetto da un “deficit di verità”, dove non si può porsi al di fuori e giudicarlo. Si può solo entrarci e guardarlo dall’interno attraverso la recita di uno stile implacabile.
7.
È sintomatico che una delle cose più prese di mira nella Favola della botte, sia l’idea di ispirazione dei puritani o calvinisti, data come un’altra novità modernista. I calvinisti rivendicano un contatto individuale con la divinità, senza mediazioni d’una burocrazia religiosa come quella cattolica. Swift presenta questa nuova idea come invenzione del fratello Jack, figura del fanatismo calvinista, a cui ha dato di volta il cervello per esser stato cacciato a calci dal fratello Peter – che rappresenta il dogmatismo cattolico. Nell’esporre l’invenzione del fratello Jack, Swift elabora una mirabolante teoria del linguaggio ispirato, dove il sapere e l’ispirazione calvinisti sono figurati come ventosità intestinali o altre ventosità corporee.
La dottrina della setta di Jack si appoggia su un sillogismo: “Le parole non sono che aria; il Sapere non è che parole; ergo, il Sapere non è che aria” (cap. VIII). È grazie a questo presupposto che l’ispirazione diventa una comodità moderna accessibile a tutti; perché basta portarsi dietro un vescica d’aria da immettere nel proprio corpo, per via rettale o altre vie, e il Sapere che un tempo scese sugli Apostoli entrerà in qualsiasi fanatico. Inoltre le parole ispirate potranno essere valutate e misurate secondo la ventosità con cui erompono, per via posteriore o anteriore come rutti (sacri nella setta di Jack). Ma la teoria dell’ispirazione calvinista va anche pensata in rapporto a nozioni come “profondità soggettiva”, “ispirazione individuale”, senza le quali non potrebbe esistere l’idea moderna di “invenzione originale”. Questa fa supporre che gli autori traggano dal loro cervello individuale, o da qualche indimostrabile profondità, le parole che scrivono. Swift riduce anche l’ispirazione a un fenomeno aeriforme, come quello delle parole volatili: stati di turbolenze negli intestini dell’uomo ispirato, nel suo stomaco, o anche come turgore della sua verga (altro segno d’ispirazione nella setta di Jack).
La “parola giusta” che discendeva da Dio, nei moderni diventa “invenzione individuale”, e si tratta di impulsi meccanici sorti da vapori nel corpo bruto. Qui si nota, nel teatrino swiftiano, uno sguardo su quest’altra stranezza che è l’individuo, invenzione tipicamente moderna: l’individuo che rivendica una propria originalità di pensieri, ma poi segue ricette in voga e buone per chiunque. Tipico è il modo moderno di acquisizione rapida del sapere, esposto in una digressione (cap.V), dove il sapere sembra già una comodità di massa. Il nucleo della spiegazione swiftiana è questo: i moderni credono sia possibile estrarre i contenuti dei vari discorsi del sapere, per concentrare in qualche volumetto tutte le conoscenze dell’umanità, cioè la loro sostanza ultima divenuta alla portata di tutti. Una delle ricette suggerite nel brillante capitolo quinto, è questa: 1) distillare a bagno maria “tutti i moderni trattati artistici e scientifici, in qualsiasi lingua”, facendo evaporare i loro elementi volatili; 2) ridistillare la condensazione ottenuta per diciassette volte, riducendola a un elisir da conservare in una fiala; 3) bere una fiala di questo elisir a digiuno, e subito il sapere si espanderà nel cervello, permettendo di comporre tutti i libri che si vuole, su qualsiasi argomento. Cosa comprovata dal fatto che il libro che stiamo leggendo è nato proprio così, ci assicura l’estensore.
8.
Lo spettacolo centrale del theatrum mundi swiftiano resta quello delle mode vestimentarie, con cui si avvia la favola dei tre fratelli, Peter, Jack, Martin. La favola dice che quei rappresentanti dei tre rami del cristianesimo si sono traviati perché non hanno potuto fare a meno di seguire le mode. Ma il tema si espande in una allegoria che si richiama a una vecchia teoria cabalistica secondo cui le cose nel mondo sarebbero indumenti della divinità. E il nostro estensore spiega che l’orizzonte mondano va inteso come un universo felicemente popolato soltanto da “capi di vestiario”, dove anche l’anima è un capo di vestiario, e anche la religione non è fatta che di capi di vestiario. E il sindaco di Londra? Nient’altro che una rossa zimarra con un bastone bianco. C’è in questo brano un movimento di espansione stilistica sorprendente, quasi estatico, che va notato: “Osservate il globo terraqueo, troverete che esso è un vestito complessivo e puranco di moda. E cos’è mai che chiamano campagna, se non una bella giubba con verdi risvolti? O il mare, se non un panciotto di seta marezzata? Osservate quale elegantissima parrucca adorni il capo del faggio, e quale splendido farsetto di raso bianco indossi la betulla” (cap.II). Ma l’uomo? L’uomo non è che un vestito con tante guarnizioni: E le conquiste della sua mente? Sono un abito completo per coprire le sue vergogne – “non è forse la religione un mantello e la coscienza un paio di brache, le quali, sebbene nascondano la libidine e la perfidia, facilmente si calano al servizio dell’una o dell’altra?”.
Queste ultime battute illustrano un diverso movimento stilistico nella prosa swiftiana: non più di elevazione, ma come in picchiata su quello che c’è dietro al paravento della religione o dentro le brache della libidine. Il primo movimento simula una allegoresi, di tono alto; il secondo punta su esempi specifici, spesso con tremendi sarcasmi, figurazioni repulsive, strage di buoni sentimenti. Mi pare sia ben riassunto in un esempio spesso citato, che ci porta dritti al cuore dello spettacolo dei vestiti alla moda: “Ieri, avendo dato l’ordine che il cadavere d’un damerino venisse spogliato in mia presenza, fummo tutti meravigliati di trovar tanti insospettati difetti sotto un completo di vestiario. Indi mi posi ad aprire il suo cranio, il suo cuore e la sua milza; ma chiaramente ad ogni operazione m’accorsi che, più si procedeva, più vedevamo i difetti accresciuti per numero e per grandezza” (cap. IX). Qui è la stringatezza che conta più di tutto. Non c’è svelamento drammatico dell’informe massa di ventricoli e nervi, nascosta dietro l’addobbo sociale. C’è soltanto la crudele constatazione d’una incongruenza tra un fuori e un dentro: tra questa “oscurità imbottita d’organi” che è il corpo umano, e una messa in scena esterna che ci rimanda a tutte le voghe mondane. La crudeltà sta nella stringata constatazione: ed è un effetto stilistico che in pochi tratti riassume tutto quel coprimento di vergogne del corpo che è il è vestiario. Questa è l’arte insuperata di Swift: un raptus stilistico con una rapidità e con un’intensità che disturbano molti. Lo squartamento del damerino si direbbe uno smembramento nel corpo vivo delle simulazioni sociali, e fa balenare un’associazione di idee imprevedibile: tra l’effimero delle mode e la sostanza morta del cadavere.
9.
L’ultimo pamphlet di Swift è del 1733, e porta il titolo di Un ospedale per gli incurabili (A serious and useful Scheme to make a Hospital for incurable). Qui l’estensore calcola le spese per accogliere in un manicomio tutti i pazzi in circolazione, e fa un elenco precisissimo dei vari tipi da ammettervi: 1) i semplici stolti incurabili; 2) le canaglie incurabili; 3) i brontoloni incurabili; 4) gli incurabili pennaioli; 5) i damerini incurabili; 6) i bugiardi incurabili; 7) gli invidiosi incurabili; 8) i vanesi, 9) gli affettati; 10) senza parlare dei primi ministri e dei governatori, che – data la loro carica – accumulano qualifiche plurime per l’ammissione tra i matti. Ma la cosa più notevole è che lo stesso estensore chiede d’essere accolto nel suo sognato manicomio: “Il mio motivo privato per sollecitare così anzi tempo l’ammissione, è questo: si è osservato che gli estensori di piani e progetti generalmente si riducono a fare gli accattoni; ma con il mio ricovero ospedaliero, vuoi come incurabile stolto o come scribacchino, tale scoraggiante previsione sarà pubblicamente smentita”.
Nei testi swiftiani non c’è mai qualcuno che resti fuori dal novero delle follie; tutti vi sono inclusi democraticamente – e anche l’estensore della Favola della botte alla fine chiede di avere quel privilegio, d’essere accolto in manicomio. Stranamente il manicomio prende l’aria d’un paradiso a cui si ascende, sottratti ai pericoli del mondo: ognuno nella propria cella, da solo con le proprie follie. Tutto il rigurgito delle mode passeggere va a finire qui, in modo pacifico e sensato. Il modo swiftiano di accostarsi alle menzogne sociali non è quello della condanna pomposa, ma quello di chi ascolta le voci della piazza pubblica, e sente che tutte sono parole al vento, parole che tra un attimo non vorranno più dire niente, ma sono anche l’unico teatro del mondo – un mondo dove tutto, essendo volatile come le parole, è sempre sul punto di perdere significato e svanire all’orizzonte come le nubi in un giorno d’estate .
In questo senso, tutto quello che Swift ha scritto compone la veduta d’un mondo di rovine, su cui trionfa la falce del Tempo. Nella “Epistola al Principe Posterità”, l’estensore parla della figura mitica del Tempo, munita d’una falce sotto cui cadono le opere moderne come la sua. E dice: “Supplico Vostra Altezza di notare quella grande e orrenda falce che ostenta di portarsi sempre appresso… si chieda se, a qualsiasi prodotto mortale di carta e inchiostro della nostra generazione, sia possibile opporgli un’adeguata resistenza… L’inveterato suo malanimo contro le opere della nostra epoca è tale che, dei settemila scritti ora prodotti in questa rinomata città, prima che il sole abbia compiuto la prossima rivoluzione non resterà l’eco di alcuno”. In questa parodia allegorica, l’epoca moderna si configura come un’epoca in cui il nuovo e le rovine del tempo sono la stessa cosa. E il proliferare di sempre nuove parole volatili non segna altro che l’incombenza quotidiana della morte, un panorama di mortalità accelerata dal giro rapido delle mode. (Faccio notare la coincidenza di vedute con il dialogo tra la Morte e la Moda nelle Operette morali. Ma Leopardi non aveva letto Swift, a quanto mi risulta).
Questo testo è una versione aggiornata della Introduzione a Favola della botte di Jonathan Swift – Traduzione e cura di Gianni Celati, Einaudi, Torino, 1990

 La forza dell’amicizia e la gioia di scrivere nell’opera di Massimo Rizzante - Antonio Devicienti
La forza dell’amicizia e la gioia di scrivere nell’opera di Massimo Rizzante - Antonio Devicienti Devo dirglielo a Enrico De Vivo - Gianni Celati
Devo dirglielo a Enrico De Vivo - Gianni Celati Saggi Inventati - Enrico De Vivo
Saggi Inventati - Enrico De Vivo Ricordando Pascal Gabellone - Antonio Prete
Ricordando Pascal Gabellone - Antonio Prete Tsunami
Tsunami Dove pare a te
Dove pare a te Dialogo sulla fantasia
Dialogo sulla fantasia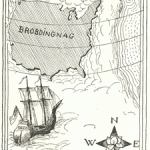 Il viaggio
Il viaggio





















