
Immagine di Luigi Latino
“Bene dixisti de me, Thoma”: l’ironico calco tomistico, messo in bocca alla Luna e rivolto all’autore, seguito da un secondo esergo che cita Novalis, indicano già, ad apertura de La pietra lunare, le due forme di una presenza nella scrittura: da una parte la luna osservata nella sua ambivalenza – divina e familiare, lontanissima e prossima, enigmatica e domestica, sovrana e intima -, dall’altra la luna come figurazione attiva, e in certo senso emblema stesso, del notturno romantico, genere ripreso nella sua componente abissale, ctonia, perturbante, e sottoposto a un trattamento ironico.
La luna di Landolfi non è la luna leopardiana. Non riprende quasi mai gli attributi con i quali il recanatese ha corteggiato, evocato e interrogato la luna (candida, amica, ignuda, rugiadosa, tacita, muta, silenziosa, cadente, peregrina, quieta, placida, cara, pensosa, graziosa, vergine, intatta, immortale, benigna, eterna, dominatrice, de le notti reina, ecc., per non dire degli attributi che accompagnano il raggio lunare o che definiscono la luce lunare). Non è, come in Leopardi il pulchra ut luna del Cantico dei Cantici a improntare la relazione tra il lunare e il femminile. L’apparizione della luna non annuncia, come accade nella poesia leopardiana, il teatro di un’interiorità turbata da cui muove, quasi sempre, la ricordanza, e neppure dispiega l’interrogazione dell’oltrelimite, dell’infinito, oltrelimite e infinito che hanno nella luna, sfinge e tuttavia confidente, la loro abbagliante soglia.
Eppure un costante dialogo con la luna leopardiana anima la scrittura “lunare” di Landolfi: esegesi leopardiana in forma narrante, controcanto, commento e replica. E la tessitura poetica della narrazione – di cui ha detto Zanzotto introducendo La pietra lunare – deve a questo dialogo con Leopardi i colori del suo ventaglio: tra affabulazione e parodia, tra modi fantastici e ansia metafisica (per questo il giudizio del Signor Giacomo Leopardi è messo in scena, con una splendida e filosofica mimesi di scrittura, in appendice al racconto del ’37).
La sovranità pensosa e amicale e enigmatica della luna leopardiana nella Pietra lunare è per così dire umanizzata e insieme animalizzata, cioè è portata sulla terra, nella terrestrità corporea dell’amore. Gurù non è soltanto una creatura lunare, che si muove in relazione costante con il sorgere e tramontare della luna. È, come in un teatro gnostico, emanazione corporea della divinità lunare, quasi suo eone o angelo, ma è anche figura della compresenza di luce e oscurità che è propria della luna. Come la luce lunare, la sua apparizione avviene in una “lenta oscurità luminosa”. Il suo discorrere, come la maschera lunare, è seduttivo, imperioso; rivela, mostra le cose nella notte, nomina forre e erbe, piante e dirupi, cespugli e grotte portando ogni cosa verso la luce, e allo stesso tempo quel che nomina lo nasconde nell’impenetrabile, nell’onirico, nell’impossibile. Il suo dire, accompagnando Giovancarlo sul monte e nella tempesta, svaria di intensità perdendosi nell’indecifrabile. Così i suoi gesti. Il suo viso pare riflettere quella luce nell’ombra e quell’ombra nella luce di cui dice Leonardo nel Trattato della pittura, a proposito dei visi che stanno sull’uscio, sulla soglia delle case. E sulla soglia dell’insondabile, dell’oscuro, è sempre Gurù, ma offerta allo stesso tempo alla vista, al piacere della vista. Gurù appare in un’ora lunare che è il corrispettivo rovesciato dell’ora meridiana: abolire il confine tra luce e ombra comporta nell’ora meridiana (si pensi al Fauno di Mallarmé) il vacillare del confine tra realtà e illusione, e comporta, nella notte lunare di Landolfi, lo sconfinamento del visibile nell’enigma, del luminoso nell’oscuro, del dicibile nell’inesplicabile. La scrittura del fantastico, da Poe a Hoffmann a Gautier a Dostoevskij a Maupassant, per citare un angolo della biblioteca landolfiana, s’è sempre mossa in questa regione dove una costante metamorfosi è in atto: l’incredibile si mostra come credibile, l’estraneo come familiare, il misterioso come quotidiano. Il freudiano Unheimliche ne può raccontare il movimento interiore, ma il complesso arabesco che tesse la scrittura non si consegna tutto all’indagine analitica, affonda nella singolarità dello scrittore, nel suo stile, nella sua invenzione.
La sovranità della luce lunare, quando si impone su lontane fantastiche regioni – L’impero della luna nel Principe infelice – avvolge le cose, prive dei contorni, in un bagliore di diamanti che è come nebbia: l’acqua pare d’alabastro, ogni scintillio è irreale, i vestiti sono ghiacci, inzuppati della vitrea luce lunare, malinconici sono gli abitanti, malati di chiardiluna. Se la luce lunare è, come i fiori del male, “maladive”, mortale può invece essere un’altra luce, quella del sole che, fugando nel giorno ogni residuo “fuoco d’ombra”, confondendo anch’esso i contorni delle cose, acceca col suo fulgore l’uccello della notte, la civetta, che via via lungo il dilagare della luce s’è chiusa in sé, sbigottita. È il bellissimo racconto Colpo di sole, in cui l’avvento del giorno, il suo dispiegarsi che dissipa velature e accende falde e addensa barbagli è descritto dal punto di “vista” – e di sopravvenuta cecità – della civetta, la quale dalla nausea e dalla malinconia muove verso una dolente, abbagliata oscurità, finché non “sprofonda nella luce bianca della morte”.
La luna, di volta in volta gelida, ingenua, beffarda, spettrale, sbocconcellata, rugginosa, sorgente di un’ indecifrata luminosità, ha un legame sotterraneo, analogico, con il volto femminile. Dalla Pietra lunare fino a uno degli elzeviri pubblicati sul “Corriere della sera” (La luna, le piene), questo rapporto oscilla tra la metamorfosi e l’incarnazione. Gli occhi di Gurù, luminosi nella notte, e la fanciulla “bianca di Luna” di cui si racconta nel succitato elzeviro hanno il subitaneo fulgore e il legame tra familiare e misterioso proprio di un’apparizione che agita la memoria e discopre l’onda increspata di un rammemorare torbido. Nel secondo racconto è proprio la terra obliosa dell’infanzia ad essere smossa dalla notturna apparizione femminile e lunare.
Il volto visibile, e splendente, della luna, s’irraggia sulla superficie del mondo, incarnandosi nella sua bellezza, con tutto il tremore e l’incantamento che la bellezza provoca, ma il volto nascosto della luna presiede invece al “rovescio delle cose”, a ciò che, inatteso, contraddice i nostri pensieri, intorbida le nostre attese. L’altra faccia della luna scompiglia l’ordine temporale delle cose, la scansione ordinata delle ore e degli eventi. Dar di volta alla luna: l’espressione risale, dice Landolfi, all'”avviso di quell’antico astronomo che stimava essere la faccia della luna cava (egli anzi inferiva che ciò sarebbe servito un giorno alle potenze celesti per incenerirci, rivolgendosi l’astro su se stesso e ardendo a mo’ di specchio ustorio l’intero nostro globo)”. Il lato fantastico dell’analogia qui prende campo assorbendo nel titolo – Voltaluna – l’intero svolgersi dell’altro quotidiano lato.
Se l’altra faccia della luna, stando all’antico astronomo, è cava, la faccia esposta alla terra può mostrarsi offuscata, imbrattata, annerita. Ecco un passaggio de La piccola Apocalisse: “Una luna scema, pallida fra la nebbia, si copriva spesso di nuvole fuligginose; l’aria n’era allora spaventevolmente cupa: quello che vorrei chiamare, appunto, nerodiluna“. Il potere del sole nero che talvolta solcava il cielo degli antichi, la sua terrestre proiezione nell’umor nero, nella classica melancholia, sono trasferiti alla luna. La traslazione non è solo d’atmosfera. Eppure la luna nera di Landolfi non indugia nei cieli dell’anima, non attrae a sé, alla sua cifra, simbolicamente, la condizione umana. È piuttosto, leopardianamente, affabulazione del lontano, trattamento ironico dell’incanto, che s’accampa nelle pagine del narratore secondo un procedimento teatrale: e si tratta, si capisce, di un teatro su cui s’affaccia, di tra le quinte, il tumultuante enigma dell’esistenza. L’esempio leopardiano qui è attivo.
Nel leopardiano Frammento (già Il sogno, poi Lo spavento notturno) Alceta racconta a Melisso un sogno da cui s’è svegliato in preda a un fortissimo turbamento: la luna si stacca dal cielo e cade sul prato vomitando nebbia e scintille e sfrigola come carbone vivo che s’immerga nell’acqua, poi si spegne e si annera levando tutt’intorno un gran fumo, lasciando nel cielo “come un barlume o un’orma, anzi una nicchia”. Incantamento rovesciato e frantumato, miniaturizzazione grottesca dell’elemento cosmico, ma anche tremore per l’assenza, per la privazione. La caduta della luna come figura onirica e poetica del vuoto, della mancanza. Inoltre il Dialogo della terra e della luna, nelle Operette, dove agisce il modello di Luciano, fa della familiarizzazione e dell’addomesticamento parodistico del mito lo spazio scenico per una critica dell’antropocentrismo. Oltre all’esempio leopardiano, in Landolfi sono attivi altri esempi di seleniti che hanno avvicinato la luna con la lente parodica e allo stesso tempo malinconica, sia che seguendo Astolfo abbiano viaggiato verso il satellite sia che abbiano danzato, funambolescamente, e poeticamente, nella luce lunare, sul filo teso tra finitudine e leggerezza: dal Baudelaire dei due poèmes dedicati alla luna, Tristesses de la lune e La lune offensée fino alle lune familiari e “provinciali” di Laforgue e dei suoi Pierrot.
In particolare alla leopardiana luna che sfrigola sul prato fa pensare il racconto landolfiano del lupo mannaro, che comincia esponendo il conflitto lunare dei due personaggi: “L’amico ed io non possiamo patire la luna: al suo lume escono i morti sfigurati dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi sudari…”. La luna, acchiappata dall’amico è “un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante”, pulsa, versa un liquido ialino, è percorsa da deboli correnti sottopelle. Chiusa nel camino sale verso la cappa e sparisce nella gola, s’annera tutta, poi si libera e si leva in cielo fuligginosa, infine lentamente si schiarisce con i venti e torna al suo primitivo splendore, a sconforto e pena dei due lupi mannari. La caduta della luna, il suo immiserimento nella domesticità, è un episodio di illusorio dominio dell’uomo, l’abbagliante biancore della luna e la sua lontananza tornano a trionfare nel cielo.
Se il lupo mannaro è descritto nel risibile tentativo della cancellazione lunare, la capramannara Gurù è descritta nella sua relazione eroticamente sacrale con la luna, con la natura e il mondo animale, nella sua doppia appartenenza alla luce e all’oscuro, alla bellezza e al sotterraneo mondo di una storia fattasi coro di volti e voci e alterchi e sfide. Il lunare della Pietra lunare ha la sua essenza nella terra, nelle sue cavità, che accolgono fantasmi e revenants, mentre il lunare di Cancroregina ha il suo elemento nell’aria, nella sospensione aerea, nella lontananza che la macchina volante non può più accorciare.
Il paesaggio della Pietra lunare, mentre è penetrato da una luce lunare per così dire mineralizzata – argento, giada, topazio, alabastro, opale sono le pietre che prestano gli attributi più frequenti – espone il suo aspetto rupestre, scomposto. La terra, flagellata dalla tempesta di vento e di pioggia, va preparando il teatro per l’evento metamorfico. La luce lunare attraversa la tempesta, la bellezza di Gurù ne è esaltata: “le lunghe ciglia brillavano di minute goccioline, che a momenti la luna accendeva di luce violenta”. Corrono nuvole di pece contro la faccia della luna quando appare la capra bianca e nera e si fa prossimo il congiungimento, che è metamorfosi, scambio dell’umano e dell’animale. Si apre il tempo della discesa nella caverna, tra i briganti, dove le parole nel buio possono però essere di luce. Nella notte della battaglia e del convito, è mostrata la pietra lunare: “Era una scheggia opalescente con vaghi riflessi azzurrognoli, e magari giallognoli o verdastri, come delle creature disformi contro la luna”. La luminosa Gurù nella caverna e tra i briganti ricorda la bellezza abbagliante di Esmeralda in Notre Dame de Paris, i suoi legami col mondo umano sotterraneo. Dopo la discesa nel profondo, ecco, ancora nella notte, l’apparizione delle Madri (le faustiane Madri), “immobili d’orrida immobilità”, messaggere di un gelido mondo, gli occhi “assorti, argentati come canapa” che fissano la luna. Uno sguardo d’ombra, della stessa natura dell’ombra lunare che copre nell’eclisse il sole, uno sguardo che impietra cose e creature. Lo sguardo lunare di una delle Madri sospinge Giovancarlo verso la soglia, ancora corporea e sensibile, dell’ibridazione panica, dell’esperienza suprema di un passaggio sul confine tra corpo e natura, tra percezione e sogno. Poi il tramonto della luna, e le creature diafane si ritirano dalla scena. “Cade la luna; e si scolora il mondo”: il verso leopardiano sembra qui commentato in chiave parossistica, espressionista, sulfurea. Il racconto di Landolfi può essere letto come una splendida variazione del notturno lunare romantico, che dà forma e presenza ai fantasmi del sentire. Il giovane Giovancarlo è il poeta che fa esperienza della descensio di là dalla soglia diurna della percezione, sospingendosi in quella regione dove la bellezza mostra il suo fondamento oscuro (il fiore del male), la parola rivela la sua radice, cioè la fisica creaturalità vegetale e animale, il sentimento mostra la sua contiguità con l’onirico, con l’immemoriale, con l’invisibile.
In Cancroregina, il racconto del 1950, la luna, che la tecnica vuole mostrare prossima, transitabile, è chiusa, severamente, nella sua irraggiungibilità. Anche se a un certo punto l’autore del diario estremo vede (o sogna?) i suoi abitanti, la loro stravagante ibrida composizione. La distanza della luna è la distanza della terra. In questa doppia, disperata e folle distanza, si dischiude il pensiero della finitudine, e della vuota appartenenza all’umano. Visti dallo spazio il sole ha il colore del ferro arroventato, la luna e la terra hanno “una violenta, aggressiva, eppur gessosa luminosità”. Se in Pietra lunare la luna scende sulla terra con i suoi misteriosi poteri, in Cancroregina ogni sogno di ascensione – di viaggio letterario nell’oltremondo – è bruciato. Neppure la parodia è più possibile. L’elevazione propria della poesia, lo sguardo dall’alto – degli angeli, degli uccelli, dei poeti – appare nella sua illusorietà. E tuttavia una passione cosmologica spinge la scrittura verso il racconto della lontananza. Come la cosmologia leopardiana cerca una lontananza da cui osservare l’esile confine tra il vivente e il nulla, così la cosmologia landolfiana cerca un punto di lontananza da cui osservare il vuoto delle illusioni, il bizzarro capriccio della tecnica, l’inanità dei sogni, la casualità e inconsistenza degli eventi che designiamo col nome di vita. È davvero l’individuo – la sua ragionevole follia, la sua irragionevole saggezza – l’universo ancora inesplorato.

 Giardino, sera - Antonio Prete
Giardino, sera - Antonio Prete Sartre, la passione della critica - Antonio Prete
Sartre, la passione della critica - Antonio Prete Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete
Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete Un racconto per Cécile - Antonio Prete
Un racconto per Cécile - Antonio Prete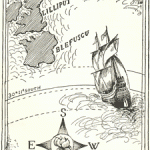 Le Voyage
Le Voyage Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione
Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio
Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio





















