
L'immagine è di Davide Racca
A sprofondare nel pozzo della natura sembra chiaro che gli uomini scompaiono. Parlando di quella grande storia del mondo naturale che sono le Georgiche di Virgilio, il poeta Iosif Brodsckij osserva che per raccontare una storia di questo tipo Virgilio ha dovuto omettere gli uomini, non ci sono “personaggi” in quest’opera. “Se il tempo”, ha scritto Brodskij, “avesse una penna e decidesse di scrivere una poesia, i suoi versi parlerebbero di foglie, erba, terra, vento, pecore, cavalli, alberi, mucche, api. Ma non di noi. Al massimo delle nostre anime”.
E forse è stato l’impulso a cercare le ragioni di un’anima che ci ha spinto verso Fontane-de-Vaucluse, dove Francesco Petrarca andava spesso a rifugiarsi, anche per lunghi periodi, tra il 1337 e il 53. Lì Petrarca ha composto molti dei suoi sonetti, e ha scritto anche un trattato d’elogio della vita appartata e contemplativa, il De vita solitaria, che avevamo portato con noi come compagno di viaggio per proseguire quell’indefinibile ricerca che nel Giura ci aveva condotto verso Courbet, a cercare i colori e le configurazioni di un paesaggio terrestre. Andare verso Petrarca era anche un modo per uscire dalla pittura, dal “visibile”. Più che qualcosa da vedere si trattava d’individuare un’attitudine contemplativa, e i modi per coltivarla. In fondo, come ha detto Merleau-Ponty in un bel saggio sulla pittura, “luce, illuminazione, ombre, riflessi, colore, tutti questi oggetti della ricerca non sono esseri propriamente reali; hanno solo un’esistenza visiva, come i fantasmi”.
Ho sempre creduto che la fotografia, che vuol rendere permanente, duratura, anche la parvenza più momentanea del visibile, sia proprio per questo da considerarsi un’arte eminentemente fantasmatica, ancor più della pittura, che passa dal corpo. Forse per questo alcune popolazioni, come si sa, rifiutano di farsi fotografare perché dicono che la fotografia gli toglie l’anima, e loro non vogliono essere dei fantasmi. Ma in fondo è attribuendo alla fotografia lo stesso potere, anche se in questo caso per cercarla, l’anima, cioè qualcosa che raccolga, contenga la propria vita, è per questo che la gente da noi va in giro a fotografarsi durante i viaggi, nelle ricorrenze più importanti, nel trascorrere degli anniversari. Ci si prepara l’album di famiglia per opporsi al tempo che rende invisibili.
A un paio di chilometri da Fontaine-de-Vaucluse, si sono fermate lungo la strada tre turiste brasiliane che mi hanno chiesto di fotografarle, con lo sfondo di un vecchio acquedotto di pietra. E’ probabile che non si sarebbero neppure fermate se non avessero visto Vittore che stava scattando delle fotografie, attratto dal rudere di una vecchia fabbrica in rovina. Ma fotografare qualcosa è sempre un modo per indicare che quella cosa val la pena di vederla, ricordarla, e le tre brasiliane non volevano lasciarsi scappare niente di quel viaggio in Europa. Finita la foto son poi subito ripartite in macchina.
Nel suo trattato sulla vita solitaria, Petrarca se la prende con l’uomo indaffarato, “infelice abitatore della città”, che è sempre preso dalla frenesia, dalla “triste attività”. All’uomo indaffarato contrappone la condotta di vita dell’uomo solitario, libero dagli affari e dagli affanni, che “ama guardare il cielo, non l’oro, calpestare la terra, non la porpora”.
Per coltivare un’attitudine contemplativa, che liberi dagli affanni, Petrarca consiglia una dimora appartata nella natura. Questo luogo “ideale” nella storia personale di Petrarca è stato Fontaine-de- Vaucluse, un minuscolo villaggio non lontano da Avignone, formato da poche case raccolte in un pianoro incassato fra le rocce. E’ qui che nel 1337 Petrarca ha acquistato una casa a cui periodicamente tornava, ed è qui che ha composto il De vita solitaria, il suo elogio della vita contemplativa.
Ma va subito detto che il luogo ideale può essere ovunque, non ha coordinate geografiche. “La nostra immaginazione si costruisca un luogo appartato tra la folla, in viaggio, persino durante i banchetti”, dice Petrarca citando Quintiliano. Perché un luogo appartato è innanzi tutto una disposizione mentale; fra l’altro nell’originale di Quintiliano, qui citato in una traduzione italiana corrente, “luogo appartato” diventa “secretum”, che dà più l’idea di uno spazio interiore, invisibile, che non traspare.
La casa di Petrarca non c’è più, ma nell’area in cui si trovava c’è un museo Petrarca con una collezione delle sue opere e stampe originali sul villaggio. Il museo apre solo con la bella stagione, d’inverno è chiuso. È lì intorno, andando verso la Sorgente della Sorge, principale attrattiva della zona, ci sono altri piccoli musei e negozietti, in una passeggiata che si snoda fra merci per turisti, una vecchia cartiera, un museo speleologico, uno sulla pena capitale e la tortura, un altro sulla Resistenza. Si sarà voluto approfittare dei turisti che vanno a vedere la sorgente del fiume, trattenerli perché non ripartano subito, e allora si è creata quest’oasi di souvenir e proposte culturali, al riparo delle rocce che fanno da corona a Fontaine-de-Vaucluse.
Ma quando siamo arrivati noi era inverno, il Museo Petrarca era chiuso e non c’erano tanti turisti in giro. Se ne vedevano le tracce però, e Vittore non riusciva mai ad allargare un’inquadratura che subito apparivano cartacce e bottiglie di plastica. Per il resto, a parte lo scrosciare dell’acqua, c’era un gran silenzio e non faceva nemmeno tanto freddo. La conca di rocce oscurava il sole, ma non faceva passare neanche il vento.
“La solitudine”. Così la definisce Petrarca, “è felice e serena sotto ogni riguardo: è, per dirla con esattezza, una rocca fortificata, un porto sicuro da ogni tempesta”. E a dimenticare cartacce e souvenir, a vedere il paese incassato fra le rocce, la metafora poteva diventare visibile, almeno nell’immaginazione.
Petrarca insiste spesso che bisogna diffidare della bellezza del mondo, che non ci si deve legare troppo ai luoghi. D’altronde nella sua vita è stato un nomade inquieto, che aveva eletto Vaucluse a suo rifugio ma si era creato pure altri sporadici rifugi, da altre parti. Anche nella mia provincia c’è un luogo frequentato da Petrarca, dove nell’Ottocento hanno eretto un monumento dedicato a lui, chiamato il Tempietto del Petrarca. Si trova nella vallata dell’Enza, il confine opposto della provincia rispetto alla valle del Secchia che avevo incontrato a Villa Minozzo.
“I luoghi appartati e deserti e il silenzio”, scrive Petrarca nel suo trattato, “non mi piacciono tanto quanto la libertà di disporre serenamente del proprio tempo che in essi alberga”. Fra le due coordinate è sempre il tempo che si deve cambiare, prima ancora del luogo, dello spazio. La vita contemplativa ha un tempo interiore, che solo in parte può essere nutrito da un luogo favorevole.
Non tanto distante da dove sorge il Tempietto del Petrarca, ero andato da ragazzo, verso i tredici anni, a fare per qualche giorno degli esercizi spirituali condotti da un prete allora molto conosciuto in zona, che alcuni dicevano fosse in odore di santità.
Lo ricordo come una persona silenziosa e severa, che portava una lunga veste nera quando già allora molti preti mettevano la giacca. Ricordo anche che neppure nel refettorio si poteva parlare, e il silenzio suonava come una condanna. Credo sia stato anche quel silenzio a farmi poi uscire dalla Chiesa, da cui mi sentivo soffocare.
La solitudine di cui parla Petrarca non è mai claustrofobia, è una solitudine e un silenzio che apre, non chiude. “Un luogo deserto non ha alcun portiere, alcun custode”, dice Petrarca, che poi confessa che “sono le folle e le preoccupazioni che mi spaventano come fossero sbarre e chiavistelli”. Perché la solitudine, la vita contemplativa, è apertura verso il mondo, non espiazione di qualcosa.
Se penso, nella mia storia personale, alla scoperta di un luogo segreto, appartato, da cui contemplare il mondo, mi viene in mente quando, poco dopo essere tornato dagli esercizi spirituali, ho iniziato a fumare di nascosto su una panchina del piazzale della stazione, insieme a un paio di amici. Ci mettevamo a sedere sullo schienale della panchina, e visto che lì davanti c’erano pure tante macchine parcheggiate, eravamo sicuri di non essere visti da nessuno. Le famiglie erano lontane, potevamo fumare, guardare gli alberi o i passanti tranquillamente.
La solitudine non è solo una condizione fisica, dello spazio. È molto bello quello che dice Petrarca, cioè che “bisogna fuggire la folla, non gli amici”, perché nella costruzione di questo mio luogo appartato, segreto, erano complici pure i miei due amici di allora, da cui mi sentivo protetto ancor più che dalle macchine parchegghiate. Per tutti e tre quel posto non doveva essere violato da nessuno, e infatti la panchina, il nostro luogo “segreto”, aveva un nome segreto che conoscevamo solo noi, e quand’eravamo là ci chiamavamo perfino con dei soprannomi, che gli altri amici non conoscevano.
Appena passati i piccoli musei e i negozi per turisti, il sentiero che va alla sorgente si restringe e in un anfratto tra le rocce c’è una lapide che ricorda Petrarca. Dice che veniva lì a meditare, fedele al culto di Laura e agli studi degli antichi. E’ certo che lì abbia scritto molte delle sue poesie, con ogni probabilità anche “chiare, fresche et dolci acque” che quasi tutti hanno imparato a scuola. Perché il sentiero si stringe nella roccia seguendo il corso della Sorge, e l’acqua impone subito la sua presenza, a volte impetuosa, quando salta dai pendii, altre volte più calma e riflessiva, quando si adagia nei miroir perché c’è una chiusa, come al mulino della vecchia cartiera.
“L’acqua è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita”, ha scritto Melville all’inizio del suo Moby Dick parlando dell’attrazione, a volte dell’ossessione, dei miraggi che gli uomini hanno sempre visto nell’acqua. E l’acqua è il fantasma della vita per almeno due buone ragioni: quando scorre è energia, flusso, ciclo biologico; quando si placa è la misteriosa duplicazione del mondo, conosciuta dagli uomini ben prima che s’inventasse la fotografia o lo specchio stesso, tanto che Narciso ci ha rimesso la vita per voler afferrare quel fantasma. E d’altronde lo stesso riflettere, meditare, ha senz’altro a che fare con l’acqua.
Anche nel De Vita solitaria Petrarca sembra attribuire all’acqua un benefico influsso immaginativo, quando ad esempio dice che non c’è niente di più caro alle Muse che “I luoghi verdeggianti e in riva a un gorgogliante ruscello”. E nello scenario di Fontane-de-Vaucluse non è difficile immaginare a quale posto potesse riferirsi.
Ma anche dalle mie parti, in Val d’Enza, il Tempietto del Petrarca sorge su un colle da cui si domina un bel pezzo del fiume che scorre in lontananza. Anche quel luogo ha avuto su di lui un influsso benefico, sbloccandolo nella composizione dell’Africa, un poema in esametri latini iniziato fra l’altro a Vaucluse, e che poi non era più riuscito a proseguire nelle sue peregrinazioni per il mondo. “Un giorno,” ha scritto Petrarca in una lettera, “salendo per caso una collina al di là del fiume Enza, nel territorio di Reggio, giunto nel luogo che è chiamato Selvapiana, preso dalla sua bellezza, volsi di nuovo la penna verso l’Africa che avevo interrotto”.
Io comunque m’immagino che quand’era a Vaucluse Petrarca non volesse stare troppo lontano da sé. Il fiume scorre incassato fra le rocce, e non c’è tanto da spaziare con gli occhi. Allora poteva diventare più facile raggiungere quella concentrazione necessaria per dedicarsi al culto di Laura, alla poesia, e allo studio dei suoi amati antichi, come diceva la lapide all’inizio del sentiero.
“In una valle chiusa d’ogni ‘ntorno,/ ch’è refrigerio de’ sospir’ miei lassi”, recitano due versi di un suo sonetto. Perché la valle si chiude contro la rupe da cui sgorga il fiume e diventa “stanza”, dimora e ricettacolo più che spazio esterno. In un certo senso il luogo si avvicina di più a una natura morta che alla natura vivente, perché si trasforma anche visivamente in luogo di raccoglimento, di rimemorazione intima: “Ivi non donne, non fontane et sassi / et l’immagine trovo di quel giorno / che ‘l pensier mio figura, ovunque io sguardo”.
Era fra queste pareti di roccia che Petrarca rivedeva Laura, il suo fantasma d’amore. Qui poteva perfino rievocare, attraverso la parola, l’immagine del giorno che l’aveva incontrata ad Avignone. Ciò che infatti Petrarca cercava, nel suo rifugio solitario, era anche l’immagine di un’assenza che da sempre la poesia, nella sua attività mnemonico-immaginativa, ha tentato di raggiungere, afferrare, specie la poesia provenzale e stilnovista da cui Petrarca stesso proveniva.
Questa particolare sensibilità s’inscrive fra l’altro in quella teoria della sensazione elaborata dalla psicologia e filosofia medievale cui Petrarca attivamente attingeva. “Secondo questa teoria”, ha riassunto Giorgio Agamben in un suo libro, “gli oggetti sensibili imprimono nei sensi la loro forma e quest’impressione sensibile, o immagine, o fantasma (come preferiscono chiamarla i filosofi medievali sulle tracce di Aristotele) è poi ricevuta dalla fantasia, o virtù immaginativa, che la conserva anche in assenza dell’oggetto che l’ha prodotta”.
Il luogo appartato, solitario, è perciò uno spazio dell’anima, una topologia dell’interiorità più che un luogo fisico, tangibile. Ma questa fuga nell’interiorità non è un semplice rifugiarsi in se stessi, è soprattutto ricerca di un’immagine interiore, di una vibrazione amorosa che però conservi il suo statuto d’immagine, e come tale non può ovviamente prescindere dai sensi. Le “chiare , fresche et dolci acque” sono quelle “ove le belle membra / pose colei che sola a me par donna”, così come “herba et fior’ che la gonna / leggiadra ricoperse / co l’angelico seno” diventano il luogo che la poesia può nominare, evocare, tanto che “da indi in qua mi piace / quest’erba sì, ch’altrove non ò pace”.
In un certo senso anche la trasfigurazione poetica non può che situarsi nell’immanenza, diventando canto in lode di Dio che la vita solitaria “rinnova non soltanto ogni giorno, ma ogni ora,” ricorda Petrarca nel suo trattato, “con l’esercizio instancabile nella lingua e la pia devozione dell’animo”.
Per Petrarca, come hanno già detto in tanti, Laura non è solo una donna ma anche l’aura, cioè un’emanazione del visibile, oppure il lauro, la pianta sacra alla poesia. Perché nell’estasi contemplativa, e anche col “lavoro instancabile nella lingua” che la vita solitaria favorisce, si realizza una trasfigurazione del visibile, non il suo annullamento.
Il De vita solitaria l’ha indirizzato all’amico Philippe de Cabassole, vescovo di Cavaillon, che è una cittadina non molto distante da Fontane-de-Vaucluse. Verso la fine del trattato, rivolgendosi all’amico, Petrarca tesse l’elogio della sorgente della Sorge e, citando Seneca, dice che “se un antro aprendosi in rocce profondamente corrose, tiene come sospesa una montagna (un antro non scavato artificialmente, ma da cause naturali in così grande vastità) un senso di religiosa trepidazione colpirà il tuo animo”.
Sono convinto che in molti casi anche la geologia possa aiutare la poesia, specie una poesia che voglia scrutare l’insondabile, l’inafferrabile. Perché il luogo della sorgente si configura davvero come una specie di mistero geologico. Infatti, andando avanti, il sentierio a un certo punto si arresta ai margini di una grotta, dal cui fondo emerge una pozza d’acqua color smeraldo. A volte, nelle stagioni più piovose, l’acqua irrompe dal fondo della grotta, mentre di solito esce da altre quattro sorgenti situate ad altezze diverse, lungo il pendio che scende verso il villaggio. L’acqua della fonte proviene da un’enorme vasca sotterranea che raccoglie l’acqua piovana dell’altipiano di Vaucluse attraverso un’infinità di foibe, anche molto profonde.
A tutt’oggi il baratro che emerge dalla grotta è il più profondo abisso inondato che si conosca al mondo. Per immergersi nelle profondità dell’abisso è stato addirittura inventato un apparecchio denominato “Sorgonauta”, dal fiume che sgorga dal baratro. L’apparecchio è un piccolo sottomarino filo-guidato che può anche trasmettere le immagini delle immersioni su degli schermi televisivi, a beneficio dei turisti e della scienza.
(I – continua)

 Non è ancora buio - Giorgio Messori
Non è ancora buio - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori La letteratura, il gioco, i bambini - Enrico De Vivo
La letteratura, il gioco, i bambini - Enrico De Vivo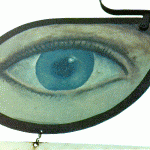 Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo Finestre in Engadina
Finestre in Engadina





















