
L'immagine è di Davide Racca.
È chiaro che ai tempi di Petrarca non c’erano le odierne tecnologie. Ma credo che una certa disposizione spirituale, che Petrarca delinea nel suo trattato sulla vita solitaria, abbia comunque maggior familiarità con l’insondabile degli apparecchi che si possono spedire oggi per esplorare le profondità di quest’abisso.
Sempre nel suo trattato sulla vita solitaria, all’amico vescovo di Cavaillon Petrarca dice: “Conosco invero fiumi assai più grandi per lunghezza di corso e per portata d’acqua, ma di sorgenti nessuna. E infine, se anche questo è vero, che – come dice Seneca – “l’improvviso sgorgare di un fiume dai visceri della terra fa sorgere altari, quale luogo, domando, sarebbe più degno di altari?”
A questo proposito mi viene in mente che Franz Kafka diceva più o meno, lo cito a memoria, che scrivere è come pregare, che ogni scrittura dovrebbe tendere alla preghiera, perché la scrittura, la poesia, il canto, professano sempre, almeno nei momenti più alti, una profonda devozione al mistero, che come tale rimane sempre insondabile, inafferrabile, anche se mai lo si è sentito così vicino. Ed è anche vero, come diceva un altro poeta, che bisogna avere sempre molto rispetto per il mistero, quando si ha la fortuna d’incontrarlo.
“Vedrai una fonte a nessuno seconda,” scrive Petrarca al cardinale Colonna per illustrargli la sua sorgente, “scaturigine di quel limpidissimo fiume, e sopra di essa un’altissima rupe, oltre la quale non è possibile andare; né ve n’è bisogno”.
Tornando alla sorgente della Sorge abbiamo preso una stanza in un vecchio albergo di Pernes-les-Fontaines, il primo paesino che s’incontra andando verso Carpentras. È un piccolo paese circondato da mura e disseminato di fontane, con tante piazzette e vecchie case in pietra ben tenute. In quei giorno eravamo sotto le feste di Natale e gli alberi spogli dei viali, o nella piazzetta dove si affacciava l’albergo, erano ornati da lumini bianchi che seguivano tronchi e rami disegnando arabeschi luminoso che ingentilivano la notte, creando ancor di più un’atmosfera da presepe.
Se nella vita solitaria l’esterno diventa un interno, allora il carattere profondamente domestico del presepe ne potrebbe essere un emblema. Giorgio Agamben, in un suo breve saggio, dice che il presepe “ci mostra precisamente il mondo della fiaba nell’istante in cui si desta dall’incanto per entrare nella storia”, e in questo passaggio gli oggetti e gli animali, che nella fiaba si erano animati o avevano preso la parola, tornano silenziosi e disponibili all’uomo, che li racchiude in miniatura nel suo universo domestico. “Gli oggetti,” scrive Agamben, “che l’incanto aveva straniato e animato, sono ora restituiti all’innocenza dell’inorganico e stanno accanto all’uomo come docili arnesi e utensili familiari”.
Nell’albergo non c’era quasi nessuno, e l’unico rumore che si sentiva era quello dell’acqua che sgorgava dalla fontana della piazzetta su cui s’affacciava la nostra stanza. Ci avevano dato una camera d’angolo, con una finestra che dava su una stradina che poi usciva dalle mura, e l’altra su una piazzetta con una chiesa e una grande scuola comunale, costruita più di un secolo fa.
Il silenzio era così perfetto, addolcito dal suono della fontana, e lo spazio così raccolto, che quando Vittore si è appisolato e mi son trovato a leggere qualcosa prima di addormentarmi, non riuscivo più a capire bene se un rumore, che a un certo punto ho sentito, fosse un gorgoglio del mio stomaco o il cigolìo di una trave nel soffitto della stanza. Perché il silenzio, a cui non siamo più abituati, favorisce sempre il passaggio da un esterno a un interno, o viceversa, e nel raccoglimento che lo custodisce può accadere di dover interpretare delle allucinazioni acustiche, come in un dormiveglia da cui ci si desta per un sogno fugace e improvviso.
Il giorno dopo volevamo raggiungere il Mont Ventoux e abbiamo chiesto la strada alla signora che ci aveva servito la colazione in albergo. Prima ci ha spiegato quali cartelli seguire, poi è voluta uscire sulla piazzetta per indicarci la montagna che compariva in una fuga prospettica fra le case. Si vedeva una sagoma azzurra e massiccia, in lontananza, che però non corrispondeva certo alle immagini che ricordavo di aver già visto tante volte alla televisione, quando al Tour de France i corridori raggiungono la vetta del monte arrampicandosi per dei tornanti e pendii ripidissimi, tanto ripidi da sembrare disegnati dalla mano di un bambino. Su per quei tornanti, diversi anni fa, era morto anche un ciclista inglese a cui per lo sforzo era scoppiato il cuore.
Comunque per raggiungere la montagna non abbiamo voluto seguire subito la strada più diretta, che ci aveva indicato la signora dell’albergo. Cercavamo una visione d’insieme, da lontano, che ci aiutasse a immaginare come Petrarca potesse aver visto quella montagna inserita in un paesaggio abituale, visto che fin da bambino aveva abitato da quelle parti. E si sa che il Mont Ventoux, dopo averlo visto tante volte in vita sua, Petrarca l’ha poi voluto scalare per vedere come si vedeva il mondo dall’alto, come ha racconto lui stesso in una celebre lettera indirizzata al teologo Dionigi da Borgo San sepolcro. “Per quel destino che regola le vicende degli uomini,” scrive Petrarca, “ho abitato in questi luoghi sin dall’infanzia, e questo monte, che è visibile da ogni parte, mi stava quasi sempre davanti agli occhi”.
A Venasque, poco lontano da Pernes-les-Fonatines, una vecchia torre in pietra ci ha riportato al silenzio che doveva regnare da quelle parti ai tempi di Petrarca, quando non c’era mai nessuna macchina in giro, e neanche strade asfaltate. Inoltre, come ci ha insegnato la pittura romantica, le rovine e i ruderi disseminati nella natura diventano sempre evocazioni di un tempo oscuro, remoto, sposando l’infinito dello spazio a un tempo che scorre inesorabile, in un altro infinito.
In effetti la forma quasi piramidale della montagna si vedeva meglio verso Malaucen, oltre Carpentras. Da lì era partito Petrarca e la cuspide è apparsa subito nitidissima, una sommità disegnata così bene da poter invogliare a salirvi per guardare il mondo dall’alto.
Petrarca aveva intrapreso la sua scalata insieme a due servitori e il fratello Gherardo, più giovane di lui, che spesso lo lasciavano arrancare in basso: “mentre i miei compagni erano già in alto, io vagavo tra le valli, senza scorgere da nessuna parte un sentiero più dolce; la via invece cresceva, e l’inutile fatica mi stancava”.
In questa lettera scritta a caldo, in un rifugio dove aveva pernottato subito dopo la scalata, Petrarca è preso da mille dubbi, pensieri che lo tirano da una parte e dall’altra. Alla fine arriva a considerarla un’ “inutile fatica”, ma non può neanche tacere lo slancio che lo aveva spinto all’impresa. Si può anzi dire che l’urgenza di questa lettera stia proprio nelle contraddizioni che lo stanno lacerando. “Non volevo che, differendola,” scrive alla fine di questa lunga lettera, “mutandosi con i luoghi anche i pensieri, mi si spegnesse il desiderio di scriverti”.
Il filosofo Joachim Ritter fa risalire a questa lettera l’origine dell’attenzione per la natura in quanto paesaggio, cioè l’origine della scissione fra uomo e natura che ha portato l’uomo a considerare la natura come qualcosa di esterno, da contemplare e da godere esteticamente. E Ritter giustamente nota che “l’immenso significato universale che spetta a questo scritto di Petrarca riposa tutto nella riflessione sui motivi della scalata”.
Petrarca dice infatti di essere stato “spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza” e di essersi fatto forza, nella scalata, pensando di compiere col corpo, in modo perciò visibile, un’ascensione che nei moti invisibili dell’anima conduce alla vita beata. Riecheggiando un passa del Vangelo, si dice per rincuorarsi che “la vita che noi chiamiamo beata è posta in alto e stretta è la strada che vi conduce”.
E come arriva in cima si ritrova in effetti in uno stato di strana beatitudine, confessa di esser “rimasto come inebetito da quell’aria insolitamente leggera e da quel vasto spettacolo”, tanto che vedendo le nuvole ai suoi piedi anche “l’Athos e l’Olimpo divennero meno incredibili”. Poi, volgendosi verso le Alpi, rimpiange il cielo dell’Italia e vorrebbe rivedere la patria, anche se poi dichiara di provare “un poco di vergogna per questo doppio desiderio non ancora virile” che lo ricaccia nel passato, negli errori giovanili da cui vorrebbe liberarsi. Ma Petrarca è sempre dilaniato fra l’attaccamento alle cose materiali, la cosiddetta seduzione delle apparenze, e l’aspirazione salvifica all’ascesi spirituale. “Amo, ma ciò che amare non vorrei, ciò che vorrei odiare,” scrive all’amico teologo, a cui confessa pure che “s’intreccia una battaglia ancor oggi durissima per il possesso di quel doppio uomo che è in me”.
Su questa scissione si fonda la sensibilità per il paesaggio. Perché dopo aver ammirato ancora una volta il panorama, Petrarca pensa di nutrire la sua anima aprendo a caso le Confessioni di Agostino, che aveva con sé, e legge un passo in cui Agostino rimprovera quegli uomini che vanno a contemplare la bellezza del mondo trascurando se stessi. “Chiusi il libro,” scrive Petrarca, “sdegnato con me stesso dell’ammirazione che ancora provavo per delle cose terrene quando già da tempo, dagli stessi filosofi pagani, avrei dovuto imparare che niente è d’ammirare tranne l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di grande”.
Joachim Ritter dice che in effetti nell’antichità non c’è l’idea che ciò che è percepibile “fuori” non possa già essere percepibile “dentro”, nell’anima, “non c’è alcuna ragione perché lo spirito sviluppi un organo particolare per la rappresentazione e l’intuizione della natura visibile diversificato rispetto alla conoscenza concettuale”. E così Ritter sostiene che Petrarca non è stato cosciente dell’importanza del movimento che aveva compiuto, perché è rimasto concettualmente invischiato in quella teoria, ricordatagli da Agostino, che riconosceva, o se vogliamo riduceva, la percezione “vera” della natura, della natura come totalità, a una conoscenza “interna”. Mentre Petrarca è voluto “uscire” dalla natura, ha sentito il bisogno di rendere visibile un’ascesi spirituale, immaginandosi la difficile scalata alla vetta come un percorso mistico, una via alla beatitudine. Tant’è vero che all’inizio della salita lui e il fratello avevano incontrato un vecchio pastore che aveva cercato di dissuaderli dall’inutile fatica, che per lui non poteva portare a niente. “Ma mentre ci gridava queste cose,” scrive Petrarca, “a noi -così sono i giovani, restii ad ogni consiglio – il desiderio cresceva per il divieto”.
Evidentemente il pastore, già dentro alla natura, non era in quel processo di conoscenza che sembra affascinare Petrarca che pure avverte, anche con dolore, la scissione che è all’origine di questo suo desiderio. Infatti non riesce a reggere l’intensità del desiderio, e dopo la lettura di Agostino inizia a “riflettere in silenzio quanta fosse la stoltezza degli uomini i quali, trascurando la loro parte più nobile, si disperdono in mille strade e si perdono in vani spettacoli, cercando all’esterno quello che si potrebbe trovare all’interno”. E quando scendendo si gira a riguardare la cima del monte, che poco prima gli ricordava l’Olimpo, adesso gli “pare alta appena un cubito a paragone dell’altezza del pensiero umano”.
Nel De vita solitaria, scritto qualche anno dopo questa scalata, pur avvertendo continuamente che la contemplazione non è riducibile a un luogo, e che è sempre uno spazio mentale, Petrarca però non fa altro che elencare luoghi che favoriscono l’attività contemplativa, ed esempi ben “situati” di vite contemplative che hanno prediletto un certo tipo di luoghi e situazioni. Inoltre c’è sempre un richiamo alla visione “presente” di una natura “vivente”. “Che cosa infatti potrebbe essere più stolto”, avverte, “che trascurare il presente che, solo, ci appartiene”.
Quando poi, a un certo punto, Petrarca parla dei poeti, dice che “essi traggono lo slancio dalla lettura che è passata e dal loro ingegno che invece è vivo e presente. Naturalmente bisogna che siano trasportati al di là degli umani confini, se vogliono parlare un linguaggio sovrumano: per parte mia ho notato che talvolta ciò si verifica con maggiore facilità e prontezza nei luoghi più aperti. Così mi è capitato spesso di vedere una poesia composta sui monti come fosse il capretto più grasso e più scelto dell’intero gregge e, messo a parte dell’origine della sua naturale bellezza, di dir a me stesso: hai sapore d’erbe alpina, vieni dall’alto”.
Petrarca insomma sembra essere già consapevole del valore conoscitivo della percezione estetica, e cioè che “la natura, in quanto paesaggio,” dice ancora Ritter, “non viene rappresentata nel concetto, ma nel sentire estetico, non nella scienza, ma nell’arte e nella poesia, non nel transcensus del concetto, ma nel piacere “dell’uscire” dalla natura”.
Quando siamo arrivati a Mont Serein, prima dell’ultima rampa che dovrebbe condurre alla sommità del Ventoux, c’era un cartello che avvertiva che l’accesso al colle era chiuso per la neve. Fra l’altro anche la sommità del monte non era più visibile, coperta da una coltre di nuvole.
Anche provando dall’altra parte, al lato sud della montagna, la strada era chiusa per la neve. Allora ci siamo incamminati per un po’, finché non ci siamo infilati nelle nuvole e non si vedeva davvero più niente. Era tutto bianco, solo le impronte sulla neve, e ci siamo trovati immersi e inebetiti dall’invisibilità luminosa delle nuvole.
(II – fine)

 Sguardo lenta esplorazione - Antonio Devicienti
Sguardo lenta esplorazione - Antonio Devicienti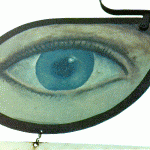 Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori L’Esordio - Enrico De Vivo
L’Esordio - Enrico De Vivo Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori Finestre in Engadina
Finestre in Engadina Non è ancora buio
Non è ancora buio





















