
L’immagine è di Tano D’Amico
Tu che mi leggi, non t’è mai successo di stare davanti ai tuoi ricordi come davanti a un sogno che vorresti raccontare e non sai però quali sono le cose da dire e quelle da non dire, perché queste ultime forse appartengono non proprio al sogno com’era ma ai suoi contorni, o al pensiero del sogno che t’è venuto dopo?
Sentir raccontare di quell’epoca, delle sue notti e dei suoi giorni, dovrebbe essere come ascoltare un blues delle origini, un blues, per esempio, di Big Joe Williams, con le parole distinte che stanno nella musica come nella sola casa possibile, e la chitarra che le accarezza le parole, e le protegge, e il grande fiume, con le sue storie di donne e di alcol, che sta anch’esso dentro le parole e dentro la musica.
E invece ha gli argini indistinti il fiume di quell’epoca, e non sai bene dov’era la sorgente, non sai bene dov’è andato a sfociare, in quali vallate s’è fatto il suo letto, lo vedi scorrere nella nebbia, anche se ogni tanto riconosci qualche imbarcazione che passa sotto i ponti, e sulle rive riesci a risentire un suono familiare, forse ritrovi anche una faccia che proprio non sei riuscito, in tutto questo tempo, a tenerla chiusa nel buio della dimenticanza. Ti metti a seguirla, quella faccia, la segui nelle strade che tante volte hai attraversato, e dopo un poco state camminando insieme, tu e lui, o anche tu e lei, lei che adesso mostra bene il suo profilo di ragazza ventenne, il suo nome non lo vuoi sperdere nell’aria, lo conservi dentro di te, vestiva spesso con i jeans e il maglione peruviano, nelle manifestazioni i lunghi capelli, correndo tutti al grido di Ho-Chi-Min, facevano una bella scia, al vento della sera, lungo corso Buenos Aires e in corso Venezia, ai lati ragazzi con l’eskimo volantinavano, altri col megafono trasmettevano slogans, e altre frasi rimate e gioiose nascevano spontanee nel corpo leggero del corteo, rabbia e sogno mescolati, e il mondo convocato lì, in mezzo a quei passi e a quelle grida, il mondo con le sue miserie, con le sue lotte per altri mondi, ridendo tutti di speranza. O tossendo e correndo in mezzo al fumo dei lacrimogeni, che annebbiavano le guglie del Duomo, passandosi l’un l’altro i limoni da aspirare, defluendo dispersi nelle stradine, o finendo qualche volta proprio sulla linea di un plotone, e da lì sulle camionette verso la questura e il fermo.
Il sorriso la faceva riconoscere tra mille, ma anche la chitarra, che portava sempre con sé, tranne che nelle manifestazioni, chissà dove la posava in quelle ore, perché dopo l’aveva ancora con sé, e la sera sotto un portico o in una casa la suonava, la testa inclinata sulle corde e sugli accordi, gli occhi sulla danza delle dita, la voce che cresceva, si faceva rotonda e fresca, e tutti intorno ad ascoltare, ad accompagnare in sordina, We shall overcome apriva il repertorio di Joan Baez.
Grandi aule affollate di parole-sfida, tribuni di un’ora si succedevano, ragazzi salivano dall’ombra, gli accenti del Sud sovrapposti a quelli del Nord, e carte con analisi e rivolte srotolate la notte dal ciclostile, scambi di progetti e di frasi incontrandosi la domenica con quelli che giungevano dalla Senna, parigi berlino milano torino pisa roma erano nella mente un solo cerchio, poi corse nelle strade e sui tram a portare i comunicati stampa ai giornali, non era, in tanto agire, l’autorità avversata a smuoversi o incrinarsi, ma il modo di guardare chi t’era accanto, il modo di guardare il mondo, una ferita s’apriva nei pensieri, in essa c’erano tutte le ferite, c’erano gli oltraggi perpetrati nel mondo, in lontananze che divenivano prossime e ti facevano gridare di rabbia, o di sdegno, quel gridare non era il costume di una generazione, era l’apprendimento di un amore.
Fu lei una volta a prendere la parola, tra parole severe di altri che disegnavano lo stato del movimento dinanzi allo scontro in atto, così si diceva, tra parole che mostravano, negli occhi di quelli che le dicevano, il lampo d’una sicurezza nitida e autorevole che li avrebbe presto assimilati ai politici, fu lei una volta, lasciata la chitarra sul banco, a levarsi nella grande aula piena di fumo, allora disse che la rivolta più profonda non è violenta, è una rivolta che sa unire l’indignazione e il sorriso, o almeno così ti pare di ricordare ora, o forse quella frase abbreviata e un po’ solenne è il commento che t’è rimasto di quel suo intervento, che aveva una lingua diversa, ed era anche quella una lingua del movimento, seppure non da molti condivisa.
Una sera in una casa che era già una specie di comune, con la sala che dava sul giardino malmesso e fané, e tanti poster alle pareti, aveva cantato, i capelli sulla chitarra, e la voce dolce e sicura, canzoni di Carmen Miranda e Victor Jara e Fabrizio De André, ma forse anche qualcuno dei blues rurali, magari di Lightnin’ Hopkins, o di Brownie McGhee o di Sonny Terry , amava molto il blues delle origini, dopo, a piedi, l’avevi accompagnata fino alla casa dei suoi genitori, che in quei giorni erano in riviera, vi fermaste sotto il portone, su uno di quei grandi marciapiedi con i platani, dietro cui si levano palazzi di inizio Novecento, con facciate dai balconi austeri, e portoni alti, bruniti, che portano tra liste di marmi scuri verso piccole corti con ficus soffocati, fu un gran trascorrere di parole nella notte, il suo gatto e il tuo paese, le conversazioni difficili con i suoi e le letture, le serate al Conservatorio e le storie degli amici comuni. Avevate ripreso a passeggiare sul marciapiede, ma poi decideste di prendere un tram notturno e raggiungere il Naviglio pavese, appoggiati su un ponte aspettaste l’alba, scommettendo su chi dei due avrebbe scorto laggiù il primo chiarore, lei tolse la chitarra dalla custodia e la tentò con poche note, lì nel silenzio della notte che fuggiva, poi piano, a voce bassa, intonò una canzone di Joan Baez, mentre intorno una vaga chiarìa faceva sbalzare i caseggiati a ringhiera e l’acqua, grigia e melmosa, usciva dal buio che l’aveva fatta somigliare a un vero fiume, e due occhi ti guardavano con lo stesso stupore del giorno che saliva, con la stessa grazia.
Quel mattino, perduto tra altri mattini, ora si adombra, e scurisce, si confonde nella selva dei giorni che vennero, e anche lei e la sua chitarra, ostinate nel cantare il cono d’ombra della rivolta e la sua dolcezza, navigano ora sull’acqua persa dei ricordi, e tutt’intorno s’affacciano mille volti, anche i volti di quelli che presto trasformarono la scommessa in strategia, la speranza in calcolo.

 Un racconto per Cécile - Antonio Prete
Un racconto per Cécile - Antonio Prete Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete
Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete Il respiro della materia vivente - Leonardo Bonetti
Il respiro della materia vivente - Leonardo Bonetti Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio
Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio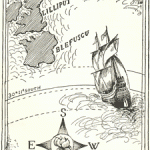 Le Voyage
Le Voyage Calvino, la passione del visibile
Calvino, la passione del visibile I classici e la barbarie
I classici e la barbarie Giacomo Leopardi e la luna salentina
Giacomo Leopardi e la luna salentina





















