
Quando ho fatto un concorso a Roma per insegnare all’estero, un concorso che per certi versi è stato perfino umiliante, almeno per quel che riguarda l’esame orale che è stato davvero ridicolo, agli occhi di un osservatore esterno, e per me appunto umiliante perché mi son trovato ad essere trattato come neanche mi era mai successo alle scuole elementari, con delle domande astruse dove dovevo indovinare delle risposte, più che domande fatte per chiedere qualcosa o conoscere qualcuno, allora solo perché avevo fatto un esame scritto molto buono sono riuscito a passare il concorso, ma in virtù di quell’esame orale mi sono trovato in fondo alla graduatoria di quelli che dovevano essere mandati a insegnare all’estero, così, quando mi è finalmente arrivato un telegramma con tutte le sedi in cui potevo essere mandato, io di risposta ho compilato un elenco di circa una cinquantina di città mettendole in ordine di preferenza, e al penultimo posto ho messo Tashkent, in Uzbekistan, appena prima di una città africana di cui non ricordo neppure il nome. E poi è successo, dopo un paio di mesi che avevo spedito il mio elenco con le città, che mi telefonassero dal ministero a scuola, nella scuola dove insegnavo, e mi proponessero appunto Tashkent, di andare a Tashkent, in Uzbekistan, e che avevo solo qualche giorno per decidere se accettare ed io, già sul momento, pur non prendendo formalmente alcun impegno mi son detto dentro di me che sì, che la risposta doveva essere sì, anche se in quel posto non avrei mai pensato di andarci, né tantomeno lo avrei immaginato per dare una svolta alla mia vita, che in quel momento ritenevo comunque fosse la cosa più urgente e importante da fare perché ero davvero a un punto morto, e avevo pure un tale disgusto per la scuola italiana e le sue soffocanti riforme che avrei accettato qualsiasi proposta pur di cambiare aria.
Così è successo che sono arrivato a Tashkent, in Uzbekistan, dove ormai vivo da più di un anno, e se ripenso agli strani giochi del destino, allora devo proprio convenire che spesso nella vita è meglio non decidere niente e affidarsi al caso, che quasi sempre sceglie meglio di noi e con molta più saggezza e leggerezza, perché a differenza delle scelte ponderate, delle cose volute, in quello che capita per caso non c’è mai il fardello di alcuna aspettativa e allora tutto arriva con la freschezza della sorpresa e una sana curiosità dell’ignoto, di ciò che prima appunto non si conosceva e non si prevedeva affatto. Io infatti dell’Uzbekistan prima non sapevo praticamente niente, se non il suono e le vaghe suggestioni che mi poteva evocare il nome della mitica Samarcanda, o Bukhara perché con quel nome vengono reclamizzati tappeti che si vendono in tutto il mondo. Ma già il nome di Tashkent non mi diceva niente, e anche chiedendo a qualcuno in giro, prima di partire, non ero riuscito a sapere praticamente niente, se non da un’amica che diversi anni prima era stata per qualche mese a Mosca ad organizzare viaggi per turisti italiani e le era capitato di accompagnare una comitiva a Tashkent, dove s’era fermata un paio di giorni ma della città si ricordava poco, solo che c’erano molti alberi e grandi vialoni e parchi e che allora, quando c’era stata lei, c’erano pure molti soldati sovietici che da lì partivano per l’Afghanistan e l’aeroporto era invaso dai soldati che partivano per la guerra.
Quando invece ci sono arrivato io, all’aeroporto di Tashkent, la guerra sovietica con l’Afghanistan era già finita da un pezzo, perciò così tanti soldati ovviamente non c’erano e non c’era più nemmeno l’Armata Rossa perché anche l’Unione Sovietica si era ormai dissolta e da quasi dieci anni Tashkent era diventata la capitale di uno stato indipendente, l’Uzbekistan, non più federato ad alcuna grande madre Russia. Anche se devo dire che di russi a Tashkent ce ne sono rimasti parecchi, e fin da subito mi sono trovato in un ambiente di russi, tanto che mi sembra di essere diventato quasi russofilo, pur balbettando ancora malamente la loro lingua e non andando molto oltre i saluti e le domande che si possono fare al mercato. Però l’autista che mi porta in giro per la città, la donna che mi viene a fare le pulizie in casa, e soprattutto la ragazza che vive con me già da un po’, tutti loro sono russi, tanto che quando sono arrivati degli amici a trovarmi dall’Italia, molti di loro mi dicevano di essere contenti di stare per la prima volta nella loro vita in Russia, anche se ovviamente questo non corrispondeva ad alcuna realtà geografica. Ma perfino una cantante napoletana venuta per fare un recital a un teatro di Tashkent ha finito per ringraziare pubblicamente il calore tipico degli spettatori russi, e presa dall’entusiasmo ha perfino evocato le stesse emozioni provate in altri concerti che aveva tenuto a Mosca e Leningrado, senza rendersi conto di non essere affatto in Russia e che neppure Leningrado si chiama più così. Scherzi dell’emozione, se vogliamo, forse di un eccessivo entusiasmo napoletano, ma in effetti la cantante cantava al teatro russo d’arte drammatica che c’è in città.
Ma allora che cos’è l’Uzbekistan? Che cos’è questa parte di quello sconfinato mondo che una volta semplificavamo col nome di Unione Sovietica? Cosa sopravvive ancora di quel mondo?
Tutte queste sono domande che nascono spontanee se si vive a Tashkent, perché in effetti l’Uzbekistan rimane un’idea piuttosto vaga se non si esce mai dalla sua capitale. Ma ricordo che una volta, a Bukhara, uno studente di origini tagike mi aveva detto che loro, quelli dell’Asia centrale, dai sovietici erano di fatto considerati dei negri, perché come i neri americani pure qui raccolgono il cotone, e anche quando c’erano le guerre in prima linea venivano sempre piazzati gli uzbeki, i tagiki, i turkmeni, i kirghisi, i kazaki, i negri di turno, appunto, la carne da macello da sacrificare agli ideali sovietici.
Ora questo atteggiamento discriminatorio si è praticamente rovesciato, come forse è normale che sia. Allora i russi sono spesso diventati a loro volta i negri sacrificati alla retorica del paese libero e indipendente, dell’Uzbekistan dal futuro radioso della propaganda di regime, e degli ancor più sottili risentimenti delle popolazioni autoctone. Perfino il passaporto che qui rilasciano ha un’ambiguità che rispecchia questo risentimento, perché il passaporto è stranamente double face, con una parte scritta in caratteri latini e in lingua inglese dove il cittadino che qui è nato e risiede viene giustamente riconosciuto come cittadino uzbeko, mentre sopra, nella pagina speculare scritta in carattere cirillico, della persona viene invece indicata la provenienza etnica, perciò ci sono cittadini uzbeki “uzbeki”, e altri invece che sono uzbeki russi, tagiki o coreani. Perciò, quando prima parlavo della mia russofilia, non era solo un’affermazione dettata da sentimenti privati, personali, ma anche da una realtà che mi spinge spontaneamente a solidarizzare coi russi che sono rimasti (e una buona metà se n’è già andata) perché quelli che ancora rimangono devono per forza subire l’inevitabile uzbekizzazione dello stato, perciò, solo per fare un esempio, se solo volessero aprire una qualsiasi impresa commerciale dovrebbero trovarsi per forza un titolare uzbeko “uzbeko”, perché a loro non è consentito farlo in quanto uzbeki “russi”. Questi sono i giochi crudeli della storia, in cui le persone diventano ancor più formichine di quanto non possano supporlo le asettiche tabelle di una qualsiasi statistica.
E, devo ammetterlo, con queste formichine russe qui a Tashkent mi sono sentito presto a casa. Una strana solidarietà fra europei, anche se per molti russi di qua l’Europa è solo un’idea astratta, culturale, perché qui è proprio il centro dell’Asia anche se si possono incontrare persone che hanno letto tutto Dostoevskij, Cechov, e non sapere invece niente di Budda e Maometto e Confucio. Dunque un’Asia strana, una specie terra di nessuno che ancora la gente può pensare di riempire come gli pare, almeno finché ciò gli sarà possibile, e che Dio o Allah o chi per loro possa concedere ancora a lungo a loro e anche a me, che ora ci vivo, questo incomparabile privilegio, la possibilità di abitare la terra che ognuno si è scelto per mentalità, cultura, non semplicemente il posto che ci è stato assegnato per trascorrere i giorni della vita. A me, finché sarà possibile, piace comunque immaginare l’Uzbekistan come questa terra vaga e incerta, un’astrazione culturale sospesa fra una Russia immaginata e un Oriente più lontano e indecifrabile, misterioso.
Naturalmente tutto quel che fin qui ho detto sono cose del tutto impalpabili, non descrivono niente, non raccontano niente di quel che ho visto e vissuto abitando qui. Sono soltanto il mio humus, l’umore che mi ha accompagnato in alcuni viaggi fatti fuori da Tashkent, ma soprattutto le sensazioni vissute nella mia vita di tutti i giorni per andare a insegnare in quella che qui viene chiamata l’Università delle Lingue Mondiali, il luogo dove mi reco quasi quotidianamente in virtù di quell’ormai lontano concorso fatto a Roma, quando mi sono sentito umiliato dalle domande astruse degli esaminatori che mi hanno spinto di forza fin qui a Tashkent, in Uzbekistan, dove non avrei mai immaginato di andare. E di ciò, paradossalmente, ora devo ringraziare proprio loro, quegli esaminatori ministeriali, perché se fosse stato per me, sicuramente, ora mi troverei a languire in qualche dotta città dell’Europa dove forse avrei ancora paura ad andare in giro e mostrarmi agli altri, come mi succedeva anche in Italia, nella mia città, nella scuola dove insegnavo, nel bar dove facevo colazione la mattina con gli occhi fissi sul giornale, perfino nelle veloci passeggiate in cui cercavo deliberatamente di sfuggire gli sguardi degli altri e camminavo sempre insaccato nelle spalle, preso da un’atrofia che ad ogni modo mi sembrava di leggere ovunque, non solo in me, quando per caso incontravo gli altri nella cabina di un ascensore, oppure viaggiando nella carrozza di un treno dove quasi tutti stavano rannicchiati sopra il loro telefonino.
Invece qui ci sono facce e persone che si possono ancora incontrare facilmente e senza imbarazzi, ed è una cosa che mi ha espresso con molta chiarezza e stupore Carlo, quando è venuto a trovarmi e mi diceva della sua felicità d’incrociare sguardi che non scappavano, di vedere facce che non avevano paura di mostrarsi per quel che erano perché non erano ancora prese da sospetti e giochi di simulazioni che ormai, per noi, sono diventati un paesaggio consueto e quotidiano, il teatro della vita che subito percepiamo appena usciti di casa.
Quando Carlo mi parlava della sua felicità a guardare le facce, facce che ancora rispecchiavano persone e non volevano invece imitare personaggi, lui, Carlo, era arrivato solo da un paio di giorni e paradossalmente eravamo andati a fare un giro proprio sulla cosiddetta Broadway, come qui viene chiamato il massimo che c’è della simulazione occidentale, la zona dei divertimenti dove si va a passeggio a prendersi un gelato, oppure ci si siede in qualche baretto all’aperto per bersi una bibita o mangiare uno shashlyk, lo spiedino di carne. A Broadway, lungo la strada, ci sono i venditori di artigianato locale e di quadri con le vedute delle città storiche dell’Uzbekistan, i ritrattisti estemporanei come a Piazza Navona, che in pochi minuti schizzano un volto, e anche dei curiosi sgabbiottini dove i ragazzi si cimentano nel karaoke delle canzoni più in voga, così il passeggio è spesso accompagnato da urletti e gorgheggi sgraziati, che conferiscono ancor di più a questa zona l’aria festosa ma anche malinconica, provvisoria, che forse si può ancora sentire nelle nostre sagre di paese. Pure la denominazione “Broadway” sembra più consona a quel gusto ironico e maldestro con cui vengono chiamati i padiglioni di un luna park, più che la designazione della zona di una città.
In effetti qui a Tashkent, pure una certa monumentalità ha comunque in sé qualcosa di provvisorio e molto poco monumentale, forse per via dell’aria d’abbandono che si respira un po’ dappertutto, anche nella grande Piazza dell’Indipendenza un tempo intitolata a Lenin e che ora dovrebbe simboleggiare l’orgoglio della nuova nazione. È vero, una certa grandiosità la si percepisce se la piazza la si vede da lontano, col palazzo del parlamento, la biblioteca, le fontane che creano un’affascinante cortina d’acqua spumeggiante. Ma basta avvicinarsi, passeggiare sul selciato sconnesso coi ciuffi d’erba che s’intrufolano in mille spacchi e fessure, e allora ci si ritrova immersi in un abbandono e un vuoto desolanti, come se si passeggiasse senza meta per una periferia, o si attraversassero quei piazzali deserti dove di notte vanno a parcheggiare i camion.
Bisogna comunque dire che a Tashkent il disorientamento non lo si vive solo nelle grandi piazze spopolate, visitando una certa monumentalità in sfacelo. Si può dire che il disorientamento sia la misura stessa della città, perché si passa facilmente da grandi bazar pieni zeppi di gente, cose, colori, agli spazi immensi e grigi di grandi vialoni scanditi da alti casermoni e incroci con prospettive a perdita d’occhio, dietro cui però si nascondono i segreti e i labirinti delle tante mahallà. E queste mahallà, devo ammetterlo, sono davvero un’inesauribile fonte di scoperte, perché sono dei veri e propri quartieri-villaggio disseminati di casupole circondate da muri che custodiscono giardini inaccessibili, a volte sorprendenti, in quanto le case sono costruite secondo quelle antiche tradizioni che vorrebbero che all’esterno non s’affacci neppure una finestra, ma che l’aria e la luce arrivino in casa appunto solo da un giardino interno, invisibile agli occhi degli altri. Adesso inoltre capita che sempre più spesso, dentro questi giardini, molti uzbeki ci tengano pure capre e galline e un pezzo d’orto, perché in tempi di penuria anche un piccolo giardino si può trasformare in una micro-campagna da sfruttare per la propria economia domestica. E così l’intero tessuto urbano è costellato da queste minuscole e invisibili campagne, tanto che molto spesso può capitare di andare a passeggio e udire improvvisamente il canto di un gallo, belati di pecore e capre, a volte persino i muggiti di una mucca. Sono presenze a volte invisibili, altre volte invece ben visibili quando le bestie escono dai giardini per spingersi a pascolare fin dentro i vialoni da parata, sotto i casermoni grigi.
Naturalmente, usciti dalla città, c’è anche la vera campagna, i bei frutteti nei paraggi di Tashkent e Samarcanda, poi gli sterminati campi di riso e di cotone e dopo Bukhara, andando verso Khiva, chilometri e chilometri di deserto pietroso e sbuffi di cespugli inargentati dalla polvere e dal sale, spazi immensi senza niente e nessuno, dove però una volta mi è capitato di vedere un pastore che cavalcava un somarello e proprio lì, in mezzo al deserto, stava portando a brucare il suo gregge, le pecore tutte sparpagliate a pizzicare i cespugli impolverati. Insomma la visione di una vita misera, arcaica, proprio come la poteva immaginare Leopardi nel suo canto del pastore errante: un vagabondare aspro e duro, «fra sassi acuti, ed alta rena», come si dice in quella celebre poesia e come si pensa per una vita fuori dalla storia, o almeno fuori da ciò che noi pensiamo debba essere un’esistenza civile, civilizzata.
Eppure, con ogni probabilità, quel pastore sarà stato anche lui un cittadino sovietico, e come tutti gli altri pure lui avrà versato un copeco all’anno per la tassa sul cosmo, il contributo simbolico che veniva richiesto a tutti i sovietici per farli sentire partecipi del lancio degli sputnik e le gloriose imprese nello spazio. E allora chissà se il cielo poteva esser per lui ancora quello immaginato da Leopardi, se la luna gli appariva ancora così «intatta» e «muta in sul deserto piano»? O anche il cosmo e le stelle si erano popolate di altre fantasie, altre avventure?
A viaggiare per l’Uzbekistan, nel paese profondo, come si dice, sembrerebbe di no, che le imprese dello spazio appartenessero appunto a un altro mondo e un’altra vita. E indubbiamente per capire questo paese è perciò indispensabile uscire dalla sua capitale, dove ancora troneggia il monumento ai cosmonauti e il gusto per una certa monumentalità celebrativa di una trascorsa, e a volte solo immaginata, potenza planetaria: fino a poco fa l’Unione Sovietica, e ancor prima l’immenso impero del tremendo Tamerlano, la cui effigie sta rapidamente sostituendosi al culto di Lenin, il padre della patria sovietica che qui un tempo aveva la statua più alta e imponente che di lui ci fosse al mondo, un colosso che s’innalzava impettito sull’attuale Piazza dell’Indipendenza. Ora a sorvegliare la città ci pensa l’arcigno Tamerlano, che forse vorrebbe indicare un altro grande futuro dall’alto del suo monumentale e muscolosissimo cavallo, al centro di una piazza da cui s’irradiano le principali strade di Tashkent.
Basta però immettersi nell’antico tracciato della Via della Seta, lungo il cui percorso sono sorte le millenarie città di Samarcanda, Bukhara, Khiva, che subito ci si rende conto che percorrere questa strada è già un’esperienza ben diversa che viaggiare su una qualsiasi autostrada, pur essendo ancora la strada più larga e importante che attraversa il paese. Perché qui la strada non ha ancora autogrill e anche i distributori sono pochissimi, mentre invece ci s’inoltra in un mondo pastorale assai poco tecnologico e imperiale, un mondo certo più piccolo e rassicurante dove si può incontrare di tutto: somari e cavalli, biciclette e funerali, greggi e mandrie che passano incuranti delle macchine, una volta perfino un cammello che ciondolava tranquillo sullo spartitraffico della strada che da Samarcanda porta a Bukhara. E poi, nelle pianure più sconfinate, quando l’orizzonte è segnato dagli sterminati campi di cotone e anche le bestie non saprebbero più dove andare a pascolare, capita allora d’incontrare solamente piccoli gruppi o uomini solitari che stanno ore immobili, accovacciati sui talloni, a contemplare il niente e le poche macchine che passano, uomini che si direbbero ancora immersi in quel «tacito, infinito andar del tempo» che governava pure sulle fatiche del pastore errante immaginato da Leopardi. Insomma un mondo bloccato in un tempo senza tempo.
Naturalmente lungo la strada s’incontrano pure mondi più vivaci e spensierati, quando ad esempio appaiono villaggi o piccoli mercati dove anche il camminare avanti e indietro, sul ciglio della strada, assume perciò un aspetto più sensato perché diventa un andare o tornare da un posto, non un semplice vagabondare o sostare aspettando chissà cosa. L’apparizione di un villaggio o di un mercato può animare viaggi per campagne altrimenti desolate, e scandire pure il tempo che si misura per arrivare alla prossima città, magari in una di quelle stesse città che ancor prima di arrivare in Uzbekistan mi promettevano insondabili lontananze: Samarcanda, Bukhara, Khiva, tre città di cui avevo visto pure alcune foto su un depliant turistico sfogliato prima di partire, un opuscoletto di poche pagine trovato in un’agenzia di viaggi. È stato in quell’occasione che ai nomi vagamente noti di Samarcanda e Bukhara se n’è aggiunto un terzo, Khiva, che ancor più degli altri sembrava adattarsi a qualche mitica divinità, forse perché il più breve dei tre (un dio difficilmente supera le due sillabe) o piuttosto per un’assonanza con una delle tre divinità indiane per cui, d’allora in poi, Samarcanda, Bukhara e Khiva sono diventate una mia personale Trimurti nell’immaginazione del mio imminente viaggio. Ma è stato soprattutto su quel depliant turistico che per la prima volta ho visto foto dell’Uzbekistan, immagini certo molto leccate e patinate, ma che però mi facevano fantasticare un mondo di cupole azzurre e minareti, non certo i casermoni grigi fra i vialoni di Tashkent.
Comunque la prima di queste antiche città che mi è capitato di vedere è stata proprio Khiva, la mitica dea e certo la meno nota delle tre e pure la più lontana da Tashkent, ma anche quella che forse mi aveva più impressionato, sul depliant turistico, perché oltre alla scoperta della sua esistenza mi avevano colpito la luce chiara e gli spazi che m’erano sembrati da città metafisica, con torri e cupole turchesi che svettavano da edifici color sabbia: uno scenario che non avevo mai visto prima, solo immaginato in qualche racconto da mille e una notte.
In effetti, anche in realtà, Khiva è una città abbastanza immaginaria, astratta: più che un centro abitato un museo all’aria aperta, tanto che quando scende il buio per strada non s’incontra quasi più nessuno, almeno nell’area circondata dalle alte mura d’argilla. Una specie di città morta cresciuta attorno a un cimitero, perché di fatto le mura che la cingono sono un enorme cimitero, con alcune tombe anonime ben visibili che mi hanno raccontato essere quelle dei martiri della città che avevano tentato di resistere all’assedio di Gengis Khan, e innumerevoli altri loculi segnalati da aste di legno piantate nell’argilla, su cui sventolano bandierine colorate per indicare i luoghi delle sepolture. E ancora adesso, passeggiando sulle mura, si possono trovare qua e là ossa umane come teschi, o femori, e altre di animali che sono andati là a morire oppure li hanno portati a tener compagnia ai loro cari o agli avi più remoti. In un certo senso un cimitero molto democratico, dove non si fanno tante distinzioni fra chi ha avuto una vita su questa terra. Un cimitero dove non s’incontrano nomi e date, solo indicazioni di sepolture, che lì sotto è stato seppellito un corpo. Ma chi fosse, di chi fosse, se uomo o bestia questo non importa, perché tanto tutto diventa ossa disseccate nell’argilla.
Ovviamente queste mura cimiteriali sono solo un luogo privilegiato e un punto d’osservazione ideale per ammirare la città, la veduta “metafisica”, a volo d’uccello, che già mi aveva impressionato sul depliant sfogliato in agenzia prima di partire. La città però ha anche altre cose che non si potrebbero ammirare se non si scendesse e ci s’incamminasse fra le rovine dell’antica fortezza, col labirintico palazzo dell’harem e i suoi cortili nascosti, e poi dentro una delle moschee più belle che abbia mai visto, una vera e propria foresta di colonne di legno intarsiato, con la luce che piove solamente da due lucernari e così dentro c’è sempre quella fresca oscurità che si può incontrare anche nei boschi, perché lì sembra davvero di essere dentro un bosco sacro, pietrificato.
Ma le mura sono spesso anche un luogo di pace e di tranquillità, visto che di giorno Khiva è spesso animata da comitive di turisti, coppie di freschi sposi che la scelgono come sfondo per le fotografie da mettere nell’album. E con tutta la gente che arriva a visitarla c’è per forza anche un mercato di bancarelle dove vendono ceramiche e oggetti di legno intagliato, altre che propongono gli enormi copricapi in lana grezza che si portano da queste parti, e agli angoli delle strade le donne che vendono semi di girasoli e sigarette come un po’ dappertutto in Uzbekistan, dove si fuma ancora parecchio e la gente va spesso in giro biascicando semi di girasole che poi sputacchia dove capita.
Ma tutta quest’animazione poi scompare, col calar del sole, quando venditori e turisti partono e la città si svuota. Pure le cameriere che servivano all’Hotel Arkanchi, dove m’ero fermato a dormire, sembravano avere un’aria spaventata, quasi che con le tenebre si diventasse degli intrusi, dei profanatori che entrano di soppiatto in un cimitero.
(1 – continua)

 Non è ancora buio - Giorgio Messori
Non è ancora buio - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori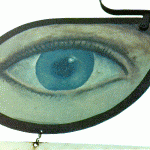 Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 1
La via di Petrarca/ 1





















