
Insomma non so ancora dire se amare Khiva oppure no, perché una certa rigidità funeraria ti entra comunque nelle ossa e nel cervello. E certo che se poi da Khiva si arriva a Bukhara sembra proprio di passare da un medio evo lugubre, barbarico, a un rinascimento dolce e luminoso, perché si rimane immediatamente colpiti dalla vivibilità e vivacità di Bukhara, dal piacere di passeggiare in una città dove anche di sera molti girano in bicicletta, come in un antico borgo italiano. E ricordo che questa dolcezza l’ho percepita fin da subito, fin dalla prima volta che c’ero andato ch’era piena estate, e dopo cena m’ero seduto a cercare il fresco sui gradini della moschea Kalan e stavo guardando il cielo stellato, la luna che illuminava d’argento il grande minareto, quando a un certo punto mi si è avvicinato un ragazzo che veniva da fuori, dalla valle di Fergana, che rapito anche lui dalla bellezza del posto ha voluto espormi con molta delicatezza, e in beata semplicità, alcune norme del vivere giusto secondo la dottrina del Corano. Perché a Bukhara è normale incontrare gente che ti rivolga spontaneamente la parola: allora era un pellegrino venuto a visitare quella città santa, di solito sono invece i mercanti che stazionano nei mercati sotto le cupole o nelle tante moschee e madrase trasformate in bazar.
A rivolgerti la parola, a Bukhara, sono però soprattutto i bambini, che sembrano i veri padroni della città e appena t’incontrano spiattellano tutte le lingue che conoscono, e che imparano velocemente intrufolandosi fra le comitive dei turisti. E anche questi bambini vorrebbero venderti qualcosa come un cappellino, un pettine, borsette e astucci fatti a uncinetto, ma non insistono mai tanto perché per loro vendere sembra ancora un gioco, un’imitazione degli adulti che invece vendono le cose molto più costose come i tappeti e i suzané, i tessuti ricamati a mano per la dote delle spose. In un certo senso pare che i bambini siano appagati dalla loro recita, così anche la vendita assume una valenza quasi simbolica. Insomma sembrerebbe che a Bukhara i bambini giochino ai mercanti come da altre parti si divertono a fare i dottori, o le bambine le mamme che cucinano e vanno a far la spesa e poi accudiscono le loro bambole.
Una sera dai bambini di Bukhara sono stato anche a cena, dopo che gli avevo già comprato un pettine e un paio di cappellini da regalare ai nipoti. Quella volta ero con Ljuda e Maurizio e per strada avevamo contrattato un prezzo di pochi sum, la moneta locale, e loro, i bambini, ci avevano portato a casa loro a mangiare. Tra fratelli e cugini saranno stati una decina, tutti contenti di farci vedere la loro casa e di avere combinato un affare.
Ricordo che era una sera di luglio, faceva caldo, così ci hanno fatto accomodare sui cuscini e apparecchiato all’aperto, stendendo una tovaglia per terra. Nella casa oltre i bambini c’erano una mamma, la nonna, una sorella più grande e solo l’ombra di un uomo, che ha attraversato rapidamente il cortile per rientrare in casa a guardare la tivù. Alla fine abbiamo anche ballato e Maurizio era felice come un ragazzino e subito affascinato dalla sorella più grande, una ragazza dolce e malinconica che stava sempre in casa perché ormai in età da marito e non poteva far chiacchierare la gente andando in giro, e allora per rendersi utile e ammazzare il tempo sferruzzava tutto il giorno per fare cappellini astucci e borsette, che poi i bambini andavano a vendere in strada.
Questo naturalmente non è l’unico ricordo di una familiarità spontanea e immediata, perché a Bukhara in effetti non mi sono mai sentito un intruso o profanatore di enigmatici silenzi, e quando ad esempio da Khiva, e dalle cameriere spaventate dall’Arkanchi, ho riattraversato il deserto e sono arrivato a Bukhara ch’era sera e stanco morto sono andato da Akbar, ho subito sentito il piacere d’essere accolto in una casa che mi appariva appunto rinascimentale, una lussuosa casa del secolo scorso appartenuta un tempo a ricchi ebrei e dove la padrona è sempre allegra, vitale, ciarliera, e a cena, fra una portata e l’altra, quella sera raccontava ad esempio di aver salvato da un’intossicazione una turista americana che le era svenuta in bagno, e poi anche l’ambasciatore francese, venuto là in viaggio di nozze, che aveva mangiato degli shashlyk in qualche ristorantino lì attorno. Da lei invece il cibo era sicuro, nessuno era mai stato male per aver mangiato e bevuto qualcosa di cattivo. Perché, è vero, a Bukhara ci si sente ancora dentro un’antica civiltà mercantile, una civiltà che abbiamo ben conosciuto anche in Italia e che fa sì che gli stranieri siano sempre i benvenuti e tutto ciò che viene proposto è sempre naturalmente il meglio che c’è, secondo quello spirito che impone pure che ogni transizione, per quanto piccola, debba essere condita di belle parole per darti la sensazione di aver fatto un buon affare ad arrivare fin là.
Quella che è una vocazione e tradizione di queste terre, fin dai tempi dell’antica Via della Seta, cioè essere luogo d’incontro e commerci d’ogni tipo, sembra trovare una sua piena realizzazione proprio a Bukhara. In un certo senso anche quel che uno si aspetterebbe di trovare a Samarcanda lo trova a Bukhara, in quanto a scenografie incantate e quella mescolanza di furbizia e cortesia che contraddistingue le antiche civiltà mercantili. Perché a Samarcanda ci sono sì luoghi memorabili e anche lì tanti mercati, ma nel complesso la città è fin troppo sovietizzata, con casoni e grandi viali che l’attraversano. Mentre a Bukhara si entra subito in una chiara monocromia color sabbia, da grande oasi del deserto e crocevia di millenari percorsi carovanieri. Niente a che vedere con la “vera” Samarcanda, che non è quasi mai quella immaginata o che il suo nome potrebbe suggerire, perché perfino la celebre spianata del Registan, con le antiche madrase rivestite di maioliche lucenti, ha però qualcosa di fin troppo sgargiante da sembrare quasi un’islamica Disneyland, con le lucine colorate che s’accendono sotto le volte azzurre quando scende il buio.
In fondo, per immaginare ancora Samarcanda, a Samarcanda non è rimasto più granché. Forse Shahi-Zinda, l’antica strada funeraria dove si dice sia sepolto anche un cugino di Maometto che avrebbe introdotto l’Islam in Asia centrale, e dove ci sono soprattutto i mausolei con le tombe dei parenti e i favoriti di Tamerlano e Ulugbek, che di Tamerlano era nipote ed è stato senz’altro il tiranno più amabile che abbia governato su queste terre, un importantissimo astronomo interessato certo più ai misteri dell’universo che all’esercizio del potere su questa terra, tanto che finì poi decapitato in una congiura orchestrata dal figlio che invece al trono evidentemente ci teneva. Ed è sempre strano perché, a leggere la storia di questo paese, ci s’imbatte spessissimo in eventi straordinariamente cruenti, con faide continue e continue conquiste sanguinarie. Mentre a viverci, in Uzbekistan, si rimane spesso colpiti dalla mitezza e amabilità della gente, a parte quelli che portano la divisa che hanno un’aria più prepotente e minacciosa, anche se a volte più goffa che incattivita. Ma nella gente che ho conosciuto, nelle facce che vedo al mercato, fra gli studenti della mia università, sembrano non sussistere quasi tracce di aggressività. Non so, forse una certa stagnazione e i rimescolamenti avvenuti in epoca sovietica sono riusciti a sbollire spiriti altrimenti bellicosi. Oppure è sempre stato così, e quel che si può leggere nei trattati di storia sono le solite e infinite lotte per il potere, coi soliti poveracci massacrati dall’orda di turno.
Ovviamente più che teorie queste sono sensazioni, dovute forse a una maggior lentezza e pigrizia nei ritmi di vita, certo meno frenetici che dalle nostre parti. Insomma un’impressione che nascerebbe da un contrasto, perché chi vive qui da sempre mi ha invece detto più volte che la gente sta diventando molto più egoista e prepotente, e che anche qui la prepotenza sta diventando un valore da esibire, come da tempo succede ormai da noi, nel nostro bel mondo dei ricchi. E forse la differenza sta proprio nel fatto che qui in molti riconoscono la valenza negativa di questa evoluzione, mentre da noi una certa mentalità e i suoi conseguenti comportamenti vengono per lo più considerati un dato di fatto.
E un’altra cosa che mi ha colpito vivendo qui in Uzbekistan, anche questa un’impressione che nasce da un contrasto, è che qui gli esseri umani vengono meno classificati e catalogati nella loro fascia d’età, e questo fa sì che non si discuta tanto di problemi giovanili o degli anziani o di crisi della mezza età. Me ne sono accorto soprattutto quand’è venuto a trovarmi un ex-studente italiano, che insisteva nel voler comprendere e chiedere ai suoi coetanei come fossero i giovani di qua, ed io avevo la netta sensazione che parlasse per loro una lingua quasi incomprensibile, forse perché presupponeva che l’esser giovani dovesse essere per forza un’identità, come ci viene continuamente inculcato dall’informazione e dalla pubblicità, così quando lui parlava di giovani spesso dai giovani non veniva capito, non capivano cosa volesse sapere, che cosa si dovesse dire, quale fosse il problema. Perché qui c’è sicuramente una vita più nuda dove certe categorie paiono del tutto superflue, perciò è naturale che i bambini mercanteggino per le strade di Bukhara o appena si reggono sulle gambe accudiscano e portino a spasso i fratellini più piccoli per i viottoli delle mahallà. E a nessuno verrebbe in mente di vedere i vecchi dentro una categoria sociale, “gli anziani”, come se diventar vecchi fosse un problema da risolvere.
Quando sono stato alla festa per gli 85 anni del nonno di Ljuda, che ha fatto la guerra e con l’Armata Rossa è poi rimasto ancora per degli anni a Vienna, a casa sua c’era un’atmosfera allegra e contenta che mi contagiava, coi parenti a festeggiare con molta semplicità attorno a una tavola imbandita, accomunati soprattutto dalla gratitudine di trovarsi ancora assieme attorno a un tavolo, senza troppe cerimonie e sentimentalismi e foto di rito davanti a torte e candeline. Poi è arrivata anche una giovane coppia di coreani, vicini di casa, che dicevano che erano contenti d’esser lì perché non avevano mai incontrato una persona così buona come lui, come il nonno che compiva 85 anni. Che sono appunto frasi semplici, dette col cuore, come si dice.
Perché poi un’altra cosa che succede da queste parti, dimenticavo di dire, è che qui sembrano esistere perfino i vicini di casa, con le case e i quartieri che somigliano ancora a comunità, come quand’ero bambino che mi capitava di trovare la mattina, appena sveglio, il benzinaio ch’era sotto casa che si divertiva a strimpellare sul pianoforte di mia madre perché tanto aveva le chiavi e poteva entrare anche quando tutti dormivano. Insomma niente a che fare con gli sguardi sfuggenti e le frasi a mezza bocca che ci si scambia normalmente nella cabina di un ascensore, quando trovarsi di fronte a un vicino di casa sembra spesso un’irreparabile disgrazia. Da queste parti, quando qualcuno nel quartiere si sposa o c’è un’altra festa, la mattina prestissimo si batte su una latta e tutti i vicini indistintamente sono invitati a mangiare il plov, il riso pilaf con la carne di montone e a volte anche l’uva passita; poi magari si va a lavorare, oppure ci si abbuffa e ubriaca e si balla fino a sfinirsi.
«Nella vecchia città suono di latta/ che si addossa alle gobbe e si disperde» recitano un paio di versi di Aleksandr Volkov, un poeta-pittore che ha vagabondato a lungo per queste terre e che doveva conoscere bene l’ebbrezza e la sensualità delle feste che si fanno, «quando ardon le guance come melograni» e «morbide stuoie, sguardo di fiore,/ girano in vortice ben cento gambe/ e urla il tamburo, ballo e tamburo», in una miscela di suoni, voci, canti che a volte posso udire anch’io a notte fonda, se mi trattengo in giardino e da qualche parte, in qualche cortile della mahallà, si festeggiano delle nozze o altre ricorrenze come l’arrivo della primavera, “i nuovi giorni”, come viene ancora chiamato l’equinozio di primavera ricordando celebrazioni che si facevano ben prima dell’Islam, ai tempi forse felici e luminosi di Zoroastro, l’antico dio del sole e della danza.
Ma senza voler soggiacere a remote fantasie d’Oriente, agli echi che arrivano dai giardini segreti delle mahallà, perché il mio habitat come dicevo è invece abbastanza russificato, se vogliamo ancora un po’ sovietizzato, mi ricordo anche che, sempre il nonno di Ljuda, l’ex-ufficiale dell’Armata Rossa ultraottantenne, una volta che sono stato lì con Fabrizio che voleva fotografare la sua casa piena di libri, tutti catalogati in diverse sezioni come narrativa russa oppure straniera, poesia e teatro di tanti paesi e poi storia, filosofia, libri di memorie, e soprattutto una sezione di cui è particolarmente orgoglioso che è quella dei testi religiosi e anti-religiosi, perché lui si dichiara ancora comunista convinto anche se a dire il vero non manifesta mai eccessive nostalgie per i tempi andati; allora, dicevo, mentre eravamo lì a chiacchierare e sorseggiare il tè e Fabrizio faceva le sue foto, ad un certo punto ha suonato alla porta una bambina del caseggiato di fronte che era venuta a chiedere un libro per una ricerca che doveva fare a scuola. Perché quella casa così piena di libri ha più o meno le funzioni di una biblioteca circolante, col nonno di Ljuda che si annota diligentemente tutti i prestiti su un quadernetto, anche se poi alcuni libri, quelli a cui tiene di più, non vanno mai tanto in giro perché sono ben custoditi in un armadio chiuso, accessibile solo ai parenti più stretti. Però questa casa sostituisce di fatto quelle che da noi sono le biblioteche di quartiere, perché qui in genere tutto è molto meno istituzionalizzato (a nessuno verrebbe mai in mente di creare ad esempio un “centro anziani”) ma forse appunto per questo funziona spesso una fitta rete di passaparola e prossimità che, per rendersi tangibili, non hanno bisogno di essere codificate in alcuna istituzione. Insomma ho come l’impressione che qui il vicino non sia ancora il nemico, come succede da noi che ormai gli amici più fidati sono i volti e i corpi inodori che possiamo rapidamente scegliere con uno zapping.
Naturalmente non è mia intenzione fare un elogio di questo paese, dove pure molte ingiustizie sono ben visibili, palpabili. Volevo solo segnalare l’esistenza di vite che s’intrecciano senza tanto schivarsi, un po’ come quando ci si siede a bere un tè sotto i gelsi plurisecolari del Labi Hauz a Bukhara, ai bordi della vasca dove scivolano placidi cigni e anatre mentre le oche, con la loro aria indispettita, trotterellano fra i cani e i gatti acquattati fra i tavolini, in attesa di qualche boccone lanciato dai clienti della ciaichanà; e intanto nel cielo volano le gazze, i corvi, le rondini, in un grande movimento che però ha sempre qualcosa di solenne, come di qualcosa che si svolga fuori da un tempo storico, perché la stessa cosa t’immagini succedesse anche cento o cinquecento anni prima attorno a questo specchio d’acqua al centro di quell’antichissima città. Perfino il cinema che c’è lì di fronte, che certo non può esistere da troppi anni, eppure s’inserisce anche lui in quell’animazione senza tempo, perché per farsi pubblicità non ha alcuna locandina fuori ma diffonde con l’altoparlante i dialoghi e le musiche del film indiano che stanno proiettando in sala. Insomma un cinema dalle finestre sempre aperte, ai margini di una grande piazza che certo favorisce queste simbiosi di interno ed esterno, uomini e animali e acqua, cielo, terra, in una vita che appare sempre molto aperta, nello sfondo delle tante cupole azzurre di moschee e madrase che mimano esplicitamente la grande volta celeste.
C’è infatti anche qualcosa nel paesaggio di questo paese che difficilmente si può descrivere, raccontare, e sono i grandi cieli stellati che devono aver affascinato pure il mite Ulugbek, che aveva ereditato un regno immenso ma preferiva dedicarsi alla contemplazione degli astri, di ciò che non si può appunto possedere ma solo esplorare con l’occhio e con la mente. Sarà che io ho quasi sempre vissuto in una pianura ad altissimo tasso d’umidità, coi cieli spesso opachi, lattiginosi, allora vivere in un paese con un’umidità bassissima mi ha aperto fin da subito alla sorpresa di un cielo che quasi ogni notte è costellato da firmamenti splendenti, che sono pur sempre un naturale e spontaneo invito all’estasi, alla quiete meditativa, anche senza dover ricorrere ogni volta a Leopardi e il suo pastore.
Non so, certo quando feci quell’esame a Roma immaginavo altri scenari, d’insegnare in un posto sicuramente migliore della scalcinata Università delle Lingue Mondiali, dove imperscrutabili regolamenti impongono agli studenti d’indossare sempre la cravatta, per un senso del decoro che ha piuttosto un sapore poliziesco, anche perché in palese contrasto con l’incuria e la sciatteria con cui vengono invece mantenuti i locali dove si svolgono le lezioni. Ma l’amabilità e la cortesia degli studenti mi fanno spesso andare a lavorare volentieri, non mi sento così ingobbito come quando entravo nella mia scuola in Italia, tutta invasa dal fervore modernistico dei colleghi che credevano nella grande riforma, in una nuova epoca per la scuola italiana.
Anche qui, a parte scuole e tante altre istituzioni lasciate a se stesse, anche qui comunque si parla di nuove epoche, di un avvenire radioso per l’Uzbekistan indipendente, e così accanto ai cartelloni della solita Coca Cola ce ne sono tanti altri con l’immagine del Presidente o di qualche giovane sorridente che invita a guardare al futuro con fiducia. Ma questa si sa che è solo propaganda, che spesso è meno invadente e pericolosa della pubblicità, almeno per la coscienza individuale, perché alla propaganda nessuno sembra mai realmente crederci, soprattutto in un paese che deve avere per forza sviluppato degli anticorpi nei tanti anni del regime sovietico, regime che fra l’altro la maggioranza, e non solo i russi, sembra ora rimpiangere (al mercato la roba costava meno, c’erano le case delle vacanze, che se in famiglia non c’era nessuno che esagerava con la vodka, d’estate ci si poteva andare perché qualche rublo rimaneva sempre: questi alcuni degli argomenti che saltano fuori quando si parla di quel passato ancora così vicino).
Il poeta Iosif Brodskij, cresciuto nello stesso regime, anche se ad altre latitudini, ha saputo esprimere molto bene questa particolare vocazione al rimpianto, alla nostalgia, che anche lui ha sempre avvertito pur avendo personalmente pagato a caro prezzo la sua estraneità e ostilità al sistema sovietico, prima con la galera poi l’esilio, eppure riconosce che «tutta l’idiozia incombente non aveva influito granché sulla nostra etica», e che una più naturale predisposizione al ricordo, a coltivare la memoria, sembra essersi maggiormente sviluppata proprio in quei regimi che ideologicamente si reggevano sulla scommessa di un futuro radioso, di un sol dell’avvenire a cui nessuno in fondo credeva. «C’è più soddisfazione a guardare indietro che avanti», ha scritto Brodskij, «il domani è meno attraente dell’ieri. Per una ragione o per l’altra il passato non irradia l’immensa monotonia che il futuro promette. Di futuro ce n’è tanto, e a causa della sua abbondanza è propaganda. Come l’erba».
Ecco, credo che questa particolare tendenza al ricordo, alla vivezza della nostalgia, facoltà che forse si è potuta coltivare meglio in un certo immobilismo sovietico, ma che probabilmente era già congenita all’anima russa, riconoscere questa particolare predisposizione al ricordo, dicevo, forse è qualcosa che mi viene in mente soprattutto perché la collego ai tanti ricordi d’infanzia che ascolto così spesso da Ljuda, la ragazza che ora vive con me, incantato dalla ricchezza di dettagli con cui racconta la sua vita di bambina “sovietica”, mentre per me l’infanzia è sempre stata un buco nero, capace di mandare solo fiochi barbagli, frammenti spesso incomprensibili; e lei invece che si ricorda come fosse ieri di quando ad esempio facevano il cinema all’aperto stendendo un lenzuolo fra gli alberi del cortile, in mezzo al caseggiato dove abitava, e un ragazzo un po’ più grande mostrava ai bambini i cartoni animati, appoggiando un proiettore alla finestra del secondo piano.
In un certo senso la mia gratitudine verso questo paese è anche perché qui posso immaginarmi un’infanzia che forse non ho mai vissuto. Probabilmente qualcosa di analogo capita pure in tante altre parti del mondo, quando si esce dal mondo dei ricchi e della sovrabbondanza. E forse per me c’entra anche l’età, che ho già passato i quarant’anni, perché quand’ero più giovane amavo dirigermi in paesi anche più lustri e ordinati e ricchi del mio, da cui tornavo per raccontare perfino ai miei amici (mi vergogno quasi a dirlo) i grandi e lucenti centri commerciali visti in Francia, Germania, Olanda, quando in Italia ancora non esistevano. Insomma viaggiavo anche per buttare un occhio sul futuro, che invece adesso mi appare per lo più nell’«immensa monotonia» di cui parla Brodskij.
Non so, in effetti potevo capitare anche da un’altra parte, come ho già detto sono qua per puro caso. Ed è altrettanto chiaro che i pensieri mutano col tempo (avere più di quarant’anni) ma anche con lo spazio. Credo sia inevitabile che ogni biografia, il cammino di una vita, sia legato anche a una geografia, allo spirito di un luogo. E così (quasi) per caso, da poco più di un anno la mia vita si trova indissolubilmente intrecciata all’Uzbekistan, un paese che prima avrei fatto fatica a indicare su un atlante. Ora non posso certo dire di essere diventato un esperto di questo paese, di conoscerlo a fondo, ammesso che sia possibile e che delle cose in genere si possa avere qualcosa che somigli a una conoscenza oggettiva. L’unica cosa che posso testimoniare sono alcuni effetti che questo paese ha prodotto su di me, e anche il piacere di riconoscersi in altre abitudini, forse persino in un altro destino.
Giugno 2001

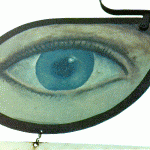 Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 2 - Giorgio Messori Finestre in Engadina
Finestre in Engadina Non è ancora buio
Non è ancora buio





















