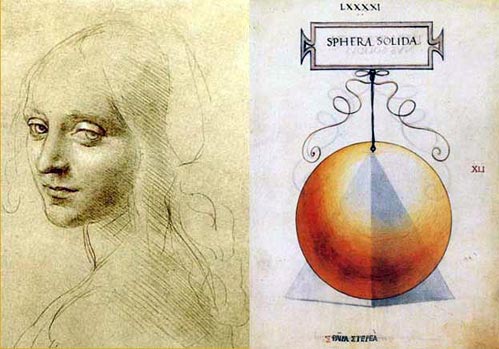
Il giorno che ho conosciuto la Katia Buraschi doveva esserci la solita sfilata coi gonfaloni comunali, i drappi delle medaglie d’oro alla resistenza, i vecchi dell’ANPI in prima fila e la banda che suona le canzoni partigiane come Bella ciao e Fischia il vento. Poteva essere una delle tante sfilate meste della memoria vagamente tristi e pervase di nostalgia per il tempo lontano della giovinezza, quando i partigiani di vent’anni imbracciavano lo Sten e andavano sul confine della linea Gotica senza sapere di entrare nell’epica. E se ci vogliono i chiarimenti basta poco, l’ANPI è l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, cantare Bella Ciao e Fischia il vento proteggeva dal freddo, lo Sten era il mitra che gli inglesi paracadutavano nelle zone di resistenza, quanto alla linea Gotica, nel 1944 il fronte andava da Forte dei Marmi fino a Rimini correndo sul crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Il giorno che ho conosciuto la Katia Buraschi poteva essere un 25 aprile in progressivo disarmo come tanti altri ma il muro dell’est era crollato da pochi anni e da quel momento in poi non s’è fatto altro che parlare di come cambiava il mondo a causa del crollo improvviso. Dicevano che il mondo non era più lo stesso, s’era aperta un’epoca di novità senza precedenti e tra le tante novità che circolavano in Italia ce n’era una che riguardava i pubblici festeggiamenti del 25 aprile. Che significato aveva una festa come quella? In fondo si continuava a commemorare una pagina della storia dove si erano opposti italiani a italiani, era stata una specie di guerra civile e siccome occorreva una riconciliazione nazionale sarebbe stato molto meglio abolire le celebrazioni unilaterali. Una festa simile poteva rinfocolare l’odio alimentando pericolose frange eversive, anziché promuovere concordia e spirito di unità.
Ai pubblici festeggiamenti del 25 aprile io ci andavo anche da zoppo. Pioggia, neve, tempesta, mio nonno Gandhi prima di morire m’aveva detto d’andarci comunque, era una condizione testamentaria che dovevo rispettare per avere diritto morale alla sua casa, condizione morale perché tanto la casa era già mia, ma se non fossi andato alla sfilata per ritorsione m’avrebbe colpito un terribile senso di colpa, mi garantiva il nonno. A me sembrava naturale andarci anche senza bisogno di scomodare il senso di colpa, ma con l’arrivo degli anni novanta, dopo la caduta del muro, parecchi che erano sempre andati alla sfilata non hanno più trovato così naturale andarci, soprattutto molti professori universitari, auspicavano un ripensamento globale, questi professori – il mondo…, la storia…, la libertà…, il mercato…, gli esisti nefasti dell’utopia…, avevano cominciato a dire.
Avevano cominciato alcuni specialisti di scienze economiche. Da certe loro accurate rilevazioni statistiche emergevano le opportunità di sviluppo connesse alla soppressione del 25 aprile. Interveniamo come tecnici, dicevano, e non volevano entrare nel merito della politica. Si limitavano a considerare esclusivamente gli indici di produzione calcolando che un giorno intero di festa nazionale implicava una flessione consistente, almeno lo 0,3%, perfino lo 0,4 del prodotto interno lordo, se si fosse aperta una fase di accelerazione tecnologica. Un dato tutt’altro che trascurabile nel mercato globale. Si fosse trattato di trascorrere un minuto di silenzio sui luoghi di lavoro, l’effetto sarebbe stato irrilevante, si poteva autorizzare anche una pausa di mezz’ora, ma in base ai loro calcoli un’intera giornata di sospensione produceva un danno economico di proporzioni impressionanti che colpiva la competizione dell’Italia sui mercati internazionali.
Poi si sono pronunciati gli studiosi di storia interessati alla formazione di una nuova coscienza civica. In base alle loro indagini sul passato occorreva ridimensionare l’effettiva portata degli eventi commemorati il 25 aprile. Sarebbe stato molto più aderente alla realtà dei fatti considerare le imprese partigiane alla stregua di ragazzate, e non solo per la scarsa incidenza bellica. Si era trattato di giovani scalmanati che in fin dei conti avevano disobbedito agli ordini, dato che la consegna non era stata quella di scappare sulle montagne. I giovani coinvolti in quei fatti lontani andavano finalmente considerati per quello che erano, cioè elementi smaniosi, soggetti inclini alla facile insubordinazione, forse non tutti ma certo la maggioranza, gruppi di sconsiderati che avevano preferito starsene tra boschi e covili. Questi storici avanzavano un sospetto preciso: cosa si nascondeva sotto quei comportamenti? Ci doveva essere una torbida passione per l’uso delle armi. Quei giovani avevano preferito nascondersi in ricoveri di fortuna anziché cercare stabile conforto vicino a un focolare di montagna, tra le braccia di una ragazza! Come mai? Quella predilezione per la vita in banda armata era un indizio eloquente, quindi era meglio lasciar perdere la retorica delle celebrazioni.
A dare appoggio a questi studiosi interessati alla coscienza nazionale, erano intervenuti alcuni specialisti di discipline sociologiche. Si trattava di professori universitari che avevano riflettuto sui cambiamenti mondiali degli ultimi tempi. Nei loro articoli si proponevano di indurre il pubblico dei lettori a riflettere sui fatti epocali appena accaduti, in particolare sul crollo del muro, un evento straordinario in grado di cambiare radicalmente il corso della storia, anche della storia passata, perché solo una concezione dogmatica si asteneva dal rimettere in questione il passato. La dimensione epocale dell’evento aveva proporzioni ciclopiche, e questi studiosi facevano dei paragoni strabilianti per colpire la fantasia del lettore, esattamente come se un ramo del fiume Nilo fosse stato deviato lungo il 25° parallelo, un ramo del fiume che fosse partito dal lago Nasser per scorrere attraverso il deserto del Sahara, a sud della Cirenaica e della Tripolitania, e che fosse sfociato nell’oceano al di sotto le montagne dell’Atlante. Sarebbero stati 5000 chilometri di deviazione, un’opera senza precedenti nella storia umana, tonnellate e tonnellate d’acqua che scorrendo nelle aridità desertiche a nord del Tibesti, poco sopra il Tropico del Cancro, erano destinate a fertilizzare il Mali e la Mauritania. La mente umana riusciva a immaginare tutte le immense conseguenze di portata climatica? E le conseguenze antropiche? E gli ulteriori sviluppi economici? Si poteva scavare un canale per collegare il Nilo col fiume Senegal, e un altro per collegarlo col fiume Niger, tutte imprese al confronto delle quali lo stesso sbarco sulla luna risultava secondario. Ecco, dicevano, come cambierebbe la geografia del genere umano con la deviazione del Nilo, e alloro stesso modo cambierà il mondo dopo il crollo del muro, cambierà l’intero corso della storia, quindi non si poteva proseguire oltre con le filastrocche sulle prodezze nostrane dei nonni partigiani.
S’erano pronunciati anche alcuni studiosi di psicologia sociale. Facevano notare che difendere le celebrazioni del 25 aprile costituiva un indizio di origine patologico. Dati i recenti mutamenti planetari, sotto la fissazione del 25 aprile si poteva ravvisare una caparbia forma di attaccamento oggettuale, una resistenza nevrotica altroché resistenza partigiana. Una negazione di massa del principio di realtà. Ma bisognava scuotere questa generazione di anziani e far loro notare che l’occupazione tedesca era lontana come l’occupazione austriaca, c’era qualcuno disposto a sospendere il lavoro per festeggiare la battaglia di Curtatone? Chi mai avrebbe voluto chiudere le attività produttive in coincidenza con le cinque giornate di Milano! I nostalgici del 25 aprile non capivano che coi loro piagnistei sembravano i reduci di Bezzecca. Erano bisognosi di cure e andavano aiutati a superare questa loro manifestazione psicotica.
Dunque dopo la caduta del muro era arrivato il momento di rinnovare il paese alleggerendolo dagli inutili fardelli della storia. Il danno per la vita…, scrivevano gli opinionisti sui giornali, l’eccesso di memoria…, l’arte del dimenticare…, e consigliavano ai nostalgici di farsi da parte con compostezza, soprattutto con dignità. Bisognava smetterla con le sfilate patetiche, ripetevano in televisione, erano ben altre le sfilate che servivano a promuovere l’immagine dell’Italia. E se proprio si voleva festeggiare si doveva farlo tutti insieme, e riconciliati, compresi quelli che stavano dall’altra parte, il 25 aprile del 1945.
Questa parentesi sulla storia potrebbe sembrare un’inutile divagazione. Eppure se il mio incontro con la Katia fosse avvenuto in circostanze a basso indice emotivo difficilmente avrei perso la testa, e per chiarire lo sfondo che faceva da cornice all’incontro bisogna sapere che la popolazione reggiana è soggetto a una tipica manifestazione oppositiva. Se in Italia si sviluppa un’idea nuova, un’idea che mai nessuno ha preso in considerazione nel territorio reggiano, allora il giorno dopo, qualcuno si alza di malumore, e man mano che trascorre la giornata il malumore cresce diventando umor nero, una contrarietà totale e inestinguibile che viene diffusa rapidamente in tutti gli interstizi sociali. E’ lo spirito contadino che prevale, uno spirito poco incline ai cambiamenti. Arriva la voce di questa idea nuova e subito se ne fa un gran parlare, qui a Reggio Emilia, il perché, il per come, il come mai, e vanno avanti all’infinito sull’esempio dei commercianti di bestiame. Dunque quest’idea di abolire il 25 aprile, correndo di bocca in bocca, provocava assembramenti e tumulti, come avessero detto di voler abolire il Consorzio del parmigiano reggiano. L’idea di abolire il 25 aprile sembrava una minaccia all’ordine costituito, e l’effetto non s’è fatto aspettare.
Ah sì? avevano iniziato a dire nei bar della periferia Sud, filastrocche e piagnistei? Ah sì? dicevano nei circoli della periferia Nord-Ovest, Bezzecca e Curtatone? Adesso ve lo facciamo vedere noi, chi è che si fa ridere dietro! E più la televisione insisteva più i reggiani si convincevano del contrario. C’erano raduni di pizza a cui i reggiani partecipavano portando i loro televisori per prenderli a martellate, e se in un primo tempo scendevano lacrime di tristezza poi si passava all’euforia del gesto liberatorio e lacrime diventavano di contentezza gioiosa, come se la distruzione del televisore avesse liberato da un maleficio che teneva tutti stregati nella mestizia del vivere.
Questa ribellione era iniziata dai circoli dei pensionati, poi erano intervenuti i figli dei pensionati, e alla fine anche i nipoti, che a scuola chiedevano chiarimenti ai professori di storia. I professori di storia neanche a dirlo quant’erano contenti di quell’interesse improvviso per la materia. Cercavano di mantenere il distacco professorale, però raccontando i fatti che accadevano dopo il 1943, descrivendo la vita di montagna, davano la sensazione che tra l’autunno del ’43 e la primavera del ’45, tra un’imboscata e una rappresaglia, uno sganciamento e un presidio, l’esistenza era trascorsa senza nemmeno un momento di noia. E a sentire che lassù tra i monti non c’era posto per la noia, la memoria del giovane studente reggiano correva alle pagine di Pascal dove la noia è indicata come il peggiore tormento della vita, spingendo l’uomo a sentire il proprio niente e gettandolo quindi nella tetraggine. L’animo giovanile s’infervorava per quel genere di vita avventurosa, ed era colmo d’ammirazione per le avventure partigiane.
In poco tempo tutta la città è stata preda di questo stesso fervore che alimentava lo spirito di ripicca verso l’idea televisiva di abolire la festa nazionale. Bastava andare in una qualche bocciofila per vedere cosa succedeva.
Io prima d’incontrare la Katia ci andavo spesso, frequentavo un circolo dove mi chiamavano a fare certe riunioni per analizzare la politica mondiale, e se arrivavo in anticipo nell’attesa scendevo la scaletta che portava ai campi da bocce. Quello era il feudo di Casotti Remo, il principe del punto, uno che era capace di far andare la boccia a parabola.
Una sera di marzo ero sceso a curiosare, e mi ricordo che Casotti Remo doveva andare a punto. C’era un gran silenzio in attesa del tiro. Lui per un po’ ha strofinato la boccia col suo pannetto di lana, poi s’è fermato e s’è piegato sulle gambe. È stato immobile a misurare l’equilibrio della posizione, ma all’improvviso s’è rialzato, come colpito da un’incertezza. Ha girato la testa verso il compagno di partita e s’è guardato intorno, ha guardato le travi del soffitto, ha guardato gli altri che giocavano con lui, poi ha allargato le braccia sconsolato lanciando un canchero fulminante a quelli là che stavano rovinando l’Italia. Diceva che non riusciva più a concentrarsi.
Il suo compagno lo incoraggiava a non pensarci, a lasciar perdere i farabutti della televisione che parlavano con l’unico scopo di portar via la pensione ai pensionati, in quel momento era meglio pensare alla partita. Allora Casotti ha ripreso a strofinare la boccia col suo pannetto. Era già lucida e sembrava d’acciaio ma lui cercava la concentrazione necessaria e continuava a ripetere il gesto. È una specie di esercizio spirituale che serve al giocatore per annullare l’interferenza del pensiero, perché quando un pensiero di qualsiasi tipo attraversa la mente del giocatore il tiro che ne risulta è immancabilmente sporco, e Casotti dava l’idea che lisciando la boccia tanto a lungo, con quel movimento ritmico, le volesse imprimere nella memoria l’informazione necessaria sul tragitto da seguire in modo che dopo non ci fosse da fare altro che lasciarla andare per conto suo. Era esperto della procedura ma dava anche l’idea di continuare a combattere contro l’intromissione di un pensiero laterale, qualcosa di molto insidioso che minacciava l’equilibrio. E in effetti s’è tornato a fermare.
Solo a pensarci …, diceva a bassa voce, un tremolio…, un prurito…, alle mani…, poi ha buttato la boccia per terra e li ha mandati a dar via il culo, ma non si capiva chi, di preciso. Tutto il pubblico degli spettatori era stupito, commentavano che era la prima volta. Uno specialista dei tornei come Casotti Remo? Uno con la collezione delle coppe? Uno che poteva trovare la freddezza necessaria per andare a pallino in mezzo a gradinate ostili? Ma ormai aveva perso la concentrazione e non era colpa degli avversari di partita, perché erano andati tutti a rincuorarlo.
Io subito non capivo, poi pian piano ho cominciato a sentire certi nomi, certe date, e allora anche le frasi si so fatte chiare, parlava di mandarli a cagare, quelli là che volevano abolire il 25 aprile e rubare la pensione ai vecchi, si meritavano qualche bella stangata sui denti. E quello era lo stesso spirito d’indignazione che serpeggiava nel territorio reggiano. Era la rivalsa contro l’idea di abolire il 25 aprile che stava raggiungendo perfino i circoli del dopolavoro ACLI.
Aveva raggiunto perfino le maestre delle scuole per l’infanzia. Me lo diceva una mia amica di nome Giulia che era venuta qualche volta con me nelle zone di golena sul grande fiume. Lavorava in un famoso asilo e diceva che non riuscivano più a trattenersi. Hai sentito? si chiedevano l’un l’altra le maestre, hai sentito che roba? Non si frenavano nemmeno davanti ai bambini, e parlavano apertamente di mandarli a cagare. Le maestre più anziane rincaravano la dose, tutte maestre specializzate nell’educazione dell’infanzia, le famose scuole di Reggio, il progetto educativo esportato in tutto il mondo per allevare bambini felici e intelligenti, un contributo alla bilancia dei pagamenti, queste maestranze educatrici, un momento parlavano di mandarli a cagare un momento dopo dicevano di mandarli a dar via il culo.
Di conseguenza, in quei giorni, ascoltando questi discorsi e sentendo ripetere tante volte culo e merda, la mia amica Giulia diceva che i bambini erano ancora più felici del solito. Facevano dei girotondi improvvisati tenendosi ordinatamente per mano l’un con l’altro, culo culo, ripetevano i bambini in girotondo, culo, culo tondo, dicevano felici, culo culo, cacca giù per terra, e ridevano fino al singhiozzo. Anche le maestre ridevano orgogliose dei risultati cognitivi evidenziati da quei girotondi. Quando poi i bambini tornavano a casa ripetevano quelle stesse parole che avevano ascoltato a scuola, e benché la conversazione fosse tutta culo e cacca i genitori non si preoccupavano, conoscendo l’origine di quel fraseggio.
L’idea di fare una gran festa a dispetto della novità italiana di abolire il 25 aprile era venuta talmente a piacere in tutto il territorio reggiano che non c’è stato neanche bisogno della pubblicità sui giornali. La voce circolava per conto suo.
Se tutti questi esponenti della cultura italiana fossero rimasti in silenzio allora ci sarebbe stato uno dei soliti festeggiamenti in progressivo disarmo, i vecchi decrepiti, là in testa, dietro la banda comunale, e quattro gatti al seguito. Ma siccome in televisione questi esponenti della cultura italiana erano andati a dire che non c’era più niente da festeggiare, le popolazioni reggiane, spinte dallo spirito caparbio della ripicca, volevano festeggiare in grande stile.
Quanto alla festa tutti assieme, era meglio che ognuno s’arrangiasse per conto suo, quelli che negli anni fra ’43 e ’45 erano stati dall’altra parte se la facevano poi da soli la loro festa, a Predappio.
Perché un’altra caratteristica qui diffusa è la pignoleria contabile, basta osservare l’accanimento nel gioco delle carte e si capisce tutto. A Reggio domina lo spirito ragionieristico: chi vince vince chi perde perde. A nessuno verrebbe mai in mente di dire che ha vinto se invece ha perso. È del tutto inutile stare a discutere davanti a una partita persa. Io non so cosa succede nelle altre contrade italiane ma qui c’è da rimetterci la faccia, a insistere. Chi insiste dicendo che in fondo è come se avesse vinto lui, o che non ha vinto nessuno, uno così lo battezzano Il Cretinetti e sarà conosciuto come tale per tutta la vita.
Allora man mano che si snodava per le vie del centro questa sfilata del 25 aprile s’ingrossava sempre più. Tutti quelli che volevano fare la festa per ripicca s’erano dati appuntamento in città e in quel clima festoso è stato naturale conoscere la Katia. Ecco come sono andati questi fatti personali inseriti nella loro cornice di fondo.
Io lo so bene che se la Katia non fosse stata spinta al festeggiamento da quello stesso dispetto che animava tutti gli altri, se fosse rimasta indifferente al fervore cittadino, non l’avrei mai conosciuta. Invece la Katia voleva essere dentro il flusso vivo emotivo di quel giorno festoso, voleva mescolarsi il più possibile in quello che succedeva per le vie del centro storico lasciando che la sua contentezza s’incontrasse con quella degli altri, compresa la mia.
Appena me l’hanno presentata ero già prontissimo a ricevere tutto di lei, tutto quello che aveva da offrire, ero in uno stato di ricezione piena e convinta, e forse è per questo che lei è rimasta a sfilare con me. Dopo un po’ parlavamo come due che si conoscono da parecchio, e vedendola muoversi allegra che espandeva nell’aria la sua commozione, io a mia volta mi sono intonato all’euforia festeggiante come non mi capitava da parecchi anni.
Quando la banda intonava Bella Ciao alla Katia le veniva perfino voglia di ballare, diceva che le tornava in mente sua nonna staffetta partigiana, e a un certo punto m’ha preso per mano – dai balla, balla anche tu, ha detto. Io in queste cose ho sempre temuto la figura dell’orso, e poi non l’ho mai compatito il ballo alle sfilate – dai, dai, insisteva, che festa è se non balli anche tu. Allora, per un momento, quando la banda ha ripetuto le prime note di fischia il vento e infuria la bufera io mi sono agitato un po’ e per la prima volta in vita mia non m’è importato di sembrare un orso siberiano. Non provavo vergogna perché lei sorrideva e sembrava felicissima.
E lì per lì non mi ero nemmeno accorto di quant’era bella. Cioè lo vedevo bene ma non mi produceva nessuno sconquasso, rimanevo tranquillo, senza la pressione di un’intenzione precisa, salvo il fatto che l’avrei presa in braccio per mettermela sulle spalle e farle fare il resto della sfilata tenendola sopra di me. Mi ero ritrovato improvvisamente questa ragazza di fianco e non ero preparato a quella felicità estrema.
Di sicuro è stato per questo se lei m’è rimasta vicina tutto il tempo della sfilata, perché non ha sentito niente d’intenzionale, però a un certo punto ha fatto come Cenerentola. Ciao, ci vediamo, ha detto all’improvviso, purtroppo devo andare.
Io non ero preparato a questa scomparsa, m’ha preso alla sprovvista. Ero lì nella piazza dove si concludono le manifestazioni cittadine, nella piazza dove il 7 luglio del 1960 la polizia aveva ucciso cinque reggiani che manifestavano contro il governo, in quella grande piazza dove la folla defluiva lentamente e mi sentivo solo senza la Katia. L’avevo appena conosciuta e di colpo tutta la soddisfazione per la festa riuscita non valeva più niente senza di lei. Non avevo nemmeno un numero di telefono, soltanto il nome, un nome che mi aveva sempre infastidito per la sua durezza invece era bastato quel pomeriggio per farmelo piacere. Katia Katienca, cominciavo a dire, sei proprio la mia Katiuscia. All’improvviso alle mie orecchie Katia suonava come cara carina caruccia.
Il primo che s’è accorto della mia condizione è stato Prampolini. Avevamo appuntamento vicino al teatro e appena m’ha visto ha detto che avevo l’aria di un cane bastonato. Allora gli ho raccontato i fatti. Lui man mano che parlavo mi guardava sorpreso e ogni tanto diceva che avevo una brutta cera – un’ora con una donna e ti sei già rincoglionito? Diceva che nel parlare avevo qualcosa d’insolito, di dolciastro e appiccicoso – andiamo a bere una birra, ha detto, che è meglio.
Ecco, questa è la storia di quel 25 aprile in cui ho conosciuto la Katia. Anch’io non l’averi mai detto che un’ora con una donna potesse causare questo improvviso cambiamento, e non avrei mai immaginato tutte le conseguenze che sono venute dopo, compresi certi effetti corporei, come una specie d’innalzamento della temperatura, un calore che mi bruciava nello stomaco e che è durato per dei giorni.
Se tutto fosse finito lì, se alla televisione questi esponenti della cultura italiana avessero porto le loro scuse – abbiamo capito, ci dispiace, a Reggio Emilia vi siete offesi e non ne parliamo più – allora in questo forse si sarebbe tutto sgonfiato e probabilmente una settimana dopo non avrei avuto l’occasione di ritrovare la Katia. Invece l’ho poi incontrata una seconda volta, una settimana dopo, ed è anche facile immaginare dove. E questa seconda volta non me la sono fatta scappar via come Cenerentola.

 Polemiche, amicizia, estraneità - Enrico De Vivo
Polemiche, amicizia, estraneità - Enrico De Vivo Racconti andranesi - Ivan Levrini
Racconti andranesi - Ivan Levrini Questo è quel mondo – introduzione - Redazione
Questo è quel mondo – introduzione - Redazione Dante Alighieri
Dante Alighieri I fratelli Saccani
I fratelli Saccani





















