
Mattoni
Davanti a Siena, trasfigurati. Stavano tutti e due muti e sgranati di meraviglia. Davanti a loro, rossa e raccolta, tutta insieme gli si parava la città con le torri e i tetti stretti, mura e pietre e mattoni.
Non si mossero per un po’. Non ci potevano credere, d’essere arrivati.
Dopo il temporale, a marce forzate perché i soldi erano finiti e c’avevano bisogno di lavorare, mangiare, riposarsi.
Avevano camminato e camminato per tutto il giorno nell’aria fresca e blu, nell’autunno finalmente arrivato, laborioso e tranquillo.
Mangiato un pane di carità a mezzogiorno, dormito in un fienile, ultima notte all’addiaccio già freddo e umido. Ultima volta a pancia vuota, sulla terra, fra i rumori della notte.
La mattina dopo, strusciato le mani sulle facce ruvide, che anche Gino cominciava a sentire i peletti giallognoli e radi bucare la pelle. Franz non si tagliava il barbone da giorni e pareva un selvaggio delle caverne.
Si guardarono e sorrisero e decisero senza dirselo che non ne potevano più.
Caricarono il carro e in fretta e furia via verso Siena la dolce, rossa città del riposo.
Ultimo sforzo, a denti strinti e grandi passi.
Poi ora che ci stavano davanti non se lo aspettavano e non si abituavano, che era finita la corsa. Era finito il pericolo, lo sforzo, la solitudine e il vuoto.
Gli tremavano un po’ le gambe e non c’avevano il coraggio di girarsi uno verso l’altro, perché era il momento di salutarsi.
Fu Gino a guardare Franz e a tirarlo per una manica.
Franz si voltò con gli occhi umidi.
Poi si buttarono l’uno addosso all’altro e Gino quasi cascò in terra.
Strinti a respirare i vestiti umidi, la fatica, la fame e le paure. L’odore che conoscevano bene, l’uno dell’altro, e i capelli sulle facce, anche quelli noti e cari.
Gino affondò la faccia sul bavero di Franz e sentì il pomo, in gola, indurirsi fin quasi a strozzarlo.
Franz tirava in su col naso e gli batteva con una mano sulla schiena.
Chissà quanto rimasero così, a passarsi odori emozioni, ricordi e pidocchi.
Si staccarono solo perché erano stanchi e si dettero la mano.
“Grazie”, disse Gino e Franz annuì.
Poi prese la cavezza, schioccò la lingua in gola e mosse il carro verso la città. Gino lo guardò camminare e ruzzolare le ruote sulla strada a lungo. Verso la stessa entrata dove doveva passare lui, ma non ancora.
Si dovevano lasciare e quello era il momento. Gino aspettò e aspettò, finché Franz fu una macchia lontana e un punto e poi sparì fra i muri.
Allora guardò il cielo azzurro, inspirò fresco e voglia di cominciare.
Scattò in avanti le gambe e fischiettando infilò le mani in tasca. Accorgendosi che c’aveva solo quelle, le tasche, e nient’altro. Le scarpe rotte, la camicia consunta, i capelli lunghi sul collo e la barbetta da capra, in cima al mento.
Ma era leggero, pulito. Nella giornata trasparente avvicinandosi alla città sentiva l’odore del legno nei camini, del cibo nelle case, i rumori della gente per le strade e le ruote sul selciato. Come un riverbero indaffarato di tanta tanta gente, mentre varcava la soglia gli arrivò un’onda di vita e smise di pensare per galleggiare sopra quell’inizio.
Ci mise poco, buttandosi subito fra le vie strette. Su e giù per scalinate di pietra tranquille, senza confusione né fretta.
Trovò una strada un po’ più trafficata delle altre, dove c’erano botteghe una accanto all’altra e senza scegliere entrò nella prima. Poi nella seconda.
“Avete bisogno di aiuto? Lavoro bene”.
Sarà stata la quarta o quinta bottega, quando gli dissero sì.
Gino rimase un momento sull’uscio, dallo stupore e la contentezza.
“Ah, bene!”.
Disse. Poi si richiuse la porta alle spalle e entrò.
Uno stanzone alto e largo, di mattoni antichissimi, impilati metri e metri sulle teste. E scaffali a perdita d’occhio su tutti i lati, con pezze di stoffa di ogni colore.
Banchi lunghi quanto tre persone distese colmi di ritagli, forbici e metri duri di legno.
Un commesso spilungone gli fece gesto di avvicinarsi.
“Il padrone cerca qualcuno, ci manca un garzone”.
Poi fece cenno a un ragazzo più giovane di andare a chiamare.
Quello sparì in una porta e Gino ci si affacciò. Dava su un’altra stanza uguale, alta e vasta e piena di stoffa. Due o tre persone indaffarate su un banco, a tastare e accarezzare una pezza srotolata per un paio di metri.
Gino si tirò indietro e a mani conserte aspettò tranquillo mentre il commesso riordinava in giro.
Gli piacevano i colori e gli odori. Forti, di tessuti diversi. Quasi si riconosceva lo spessore e la ruvidezza, dall’odore. A chiudere gli occhi Gino si lasciava arrivare il profumo di una stoffa leggera e esotica, colorata di forte e di chiaro. E spostandosi appena un tessuto pesante, tinto scuro, che sapeva d’inverno.
“Buongiorno”.
Il padrone era arrivato e gli stava davanti, con la sua mezza età un po’ curva e pensierosa, l’abito corretto, la faccia buona, la testa un po’ diradata.
Gino si ricompose e sorrise.
Venne preso in prova e cominciò subito, in quel momento stesso.
Di lena, senza fermarsi, spostò e arrotolò, impacchettò, si arrampicò su scale lunghissime a riporre le pezze pese come un uomo.
La sera non capiva più nulla dalla stanchezza, e ancora la bottega non accennava a chiudere.
Un paio di commessi dissero “buonasera”, un vecchio che doveva essere imparentato col padrone si appisolò su uno sgabello dietro un banco, il contabile faceva calcoli su un banchetto nel retro e il padrone e lo spilungone parlavano di chissà che.
Gino c’aveva da spazzare i ritagli e la polvere e ci dava dentro come sempre, da tutto il giorno.
Su e giù, chinato e dritto, spazzava con forza disperata, anche perché non mangiava per bene dalla sera di due giorni prima e gli cominciava a girare la testa.
Poi di colpo il pavimento gli ballò sotto i piedi sempre più forte su e giù come sul mare aperto, a Gino gli cascò la scopa e poi si accorse di sbattere la testa.
Si fece male e fu la sua fortuna.
Perché lo portarono al piano di sopra, in casa del padrone, e si presero cura di lui.
Venne addirittura il farmacista, a guardargli il bozzo sul capo che era già gonfio come una mela e violetto come una melanzana. Gli ci misero l’acqua fresca e una pomata.
Poi però, siccome aveva battuto forte, non gli dettero da mangiare subito. E tutta la notte Gino si strinse le mani sulla fame, che gli dava i crampi peggio dei morsi d’un cane.
L’avevano messo in uno stanzino stretto stretto, su un lettino piccolo ma pulito e fresco, dove sarebbe stato bello dormire, non fosse stato per la fame e la stanchezza cattiva.
La mattina dopo si vestì e pulì alla bell’e meglio, con una bacinella d’acqua che gli avevano lasciato in stanza.
Il peggio erano i capelli, che tutti arruffati e sporchi non gli riusciva nemmeno di districarli con le dita.
Era mattina presto, il buio appena diradato nella stradina stretta. Gino uscì cercando di non far rumore e scoprì che la casa era già tutta in piedi.
Mamma e figlie, babbo e nonno, tutti intorno a un tavolo a mangiare a bassa voce.
Sorrisero a Gino, vedendolo arrivare, e gli fecero posto.
“Va meglio?”.
La signora parlava piano piano, con voce sottile e gentile.
Gino espanto di gioia si sedette al centro di dove voleva stare: a tavola, al caldo e al sicuro.
Sorrise e ringraziò e dette il meglio in cortesia e modestia.
Col latte caldo che scivolava a benedire lo stomaco e il pane bianco velato di burro sciolto e conserva di fichi, le cose più buone del mondo.
Gino chiuse gli occhi e gli occhi gli si riempirono di lacrime di gioia. Ma le nascose subito, perché la famiglia si era subito preoccupata e lo guardava con compatimento.
C’erano il nonno rincoglionito e sdentato, vestito di tutto punto, con la cipolla d’argento appesa alla catena. Il padrone un po’ curvo sulla colazione. La moglie sottile e gentile, di mezza età e mezze dimensioni, mezza voce, i capelli mezzi bianchi, gli occhi celesti e pacati.
Tre figliole alte e magre, vestite alla moda, capelli corti, un po’ di nasone. Sembravano tre gemelle, c’avevano quasi la stessa età. Gentili e educate, mangiavano composte e gli passavano la roba, aiutavano la mamma e scherzavano e sorridevano senza disturbare.
Una vecchina che doveva essere la sguattera si strascicava qua e là e si chiamava Tina.
Nessuno gli chiedeva niente, a Gino; era imbarazzante la fame e la miseria. Non lo pressavano, non lo offendevano. Lo lasciarono mangiare e mangiare e anche dopo che ebbero finito non lo dettero a vedere, perché lui c’aveva ancora fame e continuava a inghiottire e bere e imburrare nemmeno fosse pagato. Avrebbe pure continuato, ma di colpo si vergognò e ci dette un taglio.
Finalmente, dissero gli occhi della famiglia, ma senza darlo a capire in altro modo.
Il padrone andò a prepararsi, il nonno si appisolò sulla sedia, la mamma e le figlie si misero a riassettare. Una andò in salotto a accendere la radio e la musica saltellò per casa. Le sorelle canticchiarono mentre aiutavano, mentre prendevano i libri, mentre salutavano con un bacio la mamma e con un ” arrivederci ” il nonno e Gino.
Che galleggiava nella beata ammirazione di fortuna e armonia. Ricca, serena e felice.
Non li invidiava nemmeno, li guardava come un oggetto bello e volle viverci vicino, farsi ricadere addosso un po’ della loro vita.
Infatti fu piazzato a dormire nella stanzetta. E gli venne dato da mangiare due volte il giorno, la mattina e la sera, ma non con la famiglia; insieme alla Tina che spelluzzicava appena, perché non c’aveva denti.
Si alzava a buio, mangiava, correva a bottega. Sgobbava tutto il giorno e aspettava. Aspettava la sera, in cui il padrone chiudeva il bandone e lui restava a finire di pulire. Per poi salire a mangiare in cucina mentre gli altri stavano nel salottino a sentire la radio, raccontare, canticchiare.
Non guadagnava niente ma mangiava bene e dormiva al caldo e al pulito.
Tutto il giorno fra le pezze che cominciava a conoscere. Il lino e il cotone, la lana, cotonino, nido d’ape, seta, grisaglia, taffettà.
Gli piaceva scivolare i diti sui tessuti. Gli piaceva annusarli di nascosto, veloce, mentre li metteva a posto. Erano nuovi, intonsi. Stoffa pura senza storia, pronta all’uso, che sapeva ancora solo delle fabbriche e dei telai, dei colori che l’avevano imbevuta e dello stanzone che le conteneva.
Che era salubre, asciutto e tiepido. Il padrone ci teneva da matti, che non diventasse mai freddo, o umido, o polveroso. Lo pulivano come un ospedale e ai primi freddi ci furono subito pronte le stufe di ghisa, da mattina a sera, e la brace calda la notte, che il giorno dopo era ancora arancione e bastava un po’ di pezzi di carbone per far riprendere il fuoco.
Tutti erano puliti e sani, lì dentro. Anche a Gino gli venne dato vestiti nuovi e pezzi di sapone e lamette. Coi soldi della prima mancia fece un salto dal barbiere e quando tornò rasato e imbrillantinato il padrone si congratulò.
Si vedeva che gli piaceva, Gino. Perché come lui lavorava e non parlava, non si affacciava in strada, non scherzava e non c’aveva grilli per la testa.
Il commesso più importante, lo spilungone, non faceva che riprendere quegli altri che uscivano a fumarsi una sigaretta, guardar passare una ragazza, far due chiacchiere coi commessi degli altri magazzini.
“Dentro, c’è da fare!”.
Anche nei momenti che lo stanzone era vuoto, le pezze tutte allineate a profumare sugli scaffali, il magazzino lindo e il nonno a russare accanto alla stufa.
“Bisogna sempre trovare qualcosa da fare”, diceva lo spilungone, che si chiamava Marzio, e dava l’esempio mettendosi a spostare pezze, cercando un ordine per fare venire meglio i colori, o spolverando il banco, o controllando i metri, che fossero tutti uguali.
I commessi mugugnavano e si mettevano a ciancicare con la stoffa, senza sapere davvero che fare.
“Non vi devono mai trovare senza far nulla; un magazzino con la gente appoggiata al banco prima o poi chiude”.
Quando arrivava un cliente, addirittura, Marzio e il padrone si mettevano a srotolare pezze così, come stessero lavorando già per qualcuno.
E Gino gli piaceva a tutti e due perché non si fermava mai. Quando entrava qualcuno c’era sempre lui che spazzava, o riordinava, come se fino a quel momento ci fosse stata una baraonda di gente ad arraffarsi la stoffa. E invece magari era due giorni che non entrava nessuno e loro erano stati tutti quanti a contare le gocce di pioggia per ore e ore intere.
Gli veniva proprio bene, quel mestiere.
Se lo sentiva nei diti, nel naso. Osservò per qualche settimana e poi l’avrebbe saputo fare meglio lui di chiunque altro.
Perché gli piaceva guardare Marzio e il padrone che accoglievano i clienti. Quelli già noti e quelli nuovi. Gentili, attenti, all’ascolto. Pareva fossero lì per risolvere tutti i problemi di questo mondo. Al servizio di chi entrava, obbliganti, si indaffaravano e indaffaravano tutti i commessi, Gino vide che ci mettevano molto più della lena necessaria a trovare quello che il cliente cercava. Che era facile, in realtà, perché lì dentro c’era un ordine perfetto secondo le materie, i costi, i colori. E in fondo a ogni pezza c’era attaccato un foglietto con una sigla in lettere che al cliente non diceva nulla ma che voleva dire, in codice, qual era il minimo e quale il massimo da chiedere al metro, per quel tipo di stoffa.
Lì stava l’abilità vera. Arrivare al massimo, facendo uscire il cliente beato, convinto d’aver pagato il minimo.
E lì il padrone era imbattibile. Perché con quella faccia buona e il portamento serio la gente avrebbe giurato sul suo nome. Gli avrebbe dato le chiavi di casa e in sposi i figli.
Si metteva a soffrire, durante la contrattazione. Come uno che vorrebbe fare meglio, davvero, e è tanto triste di vedere il cliente scontento, o in difficoltà. E sempre salendo e scendendo scale, srotolando, tastando, grattandosi il mento a scegliere per il meglio. E mostrando, mostrando, anche quando il cliente, ricoperto di stoffe, chiedeva pietà, aveva trovato quello che cercava, grazie che non si desse più disturbo.
Ma quale disturbo, era un piacere, e poi c’aveva un’idea che forse gli sarebbe piaciuta… ecco un’altra pezza di un altro genere, un altro colore. No? Non va? Meglio la prima? Non c’è problema, davvero, non si preoccupi, poi mettiamo a posto, si figuri è il nostro lavoro…
E il cliente ci pensava su e poi, se poteva (ma già si sapeva, che poteva) visto che c’era si faceva venire in mente un’occasione. “Fra un po’ è il compleanno di mia moglie… ma sì, mi dia anche quella”.
Contenti come pasque, quando incassavano. Anche i commessi, che c’avevano lo stipendio. Anche Gino, che c’aveva vitto e alloggio. Entrava nel sangue, il rituale. Dell’accoglienza, lo studio, la manfrina e la vendita.
Quando poi a fine sera il contabile chiudeva la cassa gli veniva a tutti la gioia di quei soldi che il padrone aveva guadagnato.

 L’altra faccia dell’America - Francesca Andreini
L’altra faccia dell’America - Francesca Andreini La prima volta che sono stata nella terra degli Amish - Francesca Andreini
La prima volta che sono stata nella terra degli Amish - Francesca Andreini Il mercato di Awa - Francesca Andreini
Il mercato di Awa - Francesca Andreini Gino/ 26
Gino/ 26 Mandala
Mandala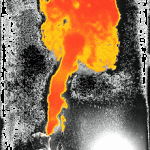 Gino/ 21
Gino/ 21 La prima volta che ho letto una lapide
La prima volta che ho letto una lapide





















