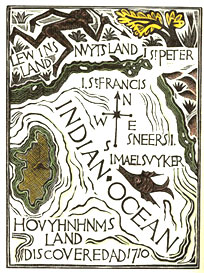
Ho vissuto sei mesi nell’isola di Koriyambi, ma gran parte del tempo l’ho trascorso nella capitale, la città di Soyumba.
Le osservazioni che seguono non sono i rilievi di un antropologo e neppure gli appunti ordinati di un viaggiatore curioso, ma soltanto le impressioni che nelle sere piovose annotavo ogni tanto sul taccuino. Quando ero nei villaggi, scrivevo al lume fioco della lampada, in baracche di legno a forma di piccola piramide, che chiamano ha-haué. Quand’ero in città, scrivevo, sempre di sera, in una confortevole casetta di pietra, illuminata da una luce soffusa.
Il ruolo di informatori lo hanno avuto di volta in volta le persone che incontravo al mercato o nella Casa celeste, che è come la nostra chiesa, oppure nella Volta Accogliente, che è l’edificio della città dove si celebrano la maggior parte dei riti. Casa Celeste e Volta Accogliente sono la traduzione, certo approssimativa, di Haué-mbie e di Aan-melapye.
L’isola si trova a sud della linea equatoriale, tra il ventiduesimo parallelo e il Tropico del Capricorno e dista dalla costa occidentale dell’Africa circa mille leghe. La savana del nord lascia il campo, già sotto la città di Soyumba, a un deserto che si spalanca tra dune rosse, piane dalla sabbia fine e giallorosa, tratturi per carovane. Il deserto poi degrada dolcemente verso la catena di basse scogliere che s’affaccia sul mare. Nelle terre che si aprono tra il nord della capitale e la linea della savana si coltiva cotone, ma anche caffè. Qualche bananeto si può trovare tra i villaggi che scendono verso la costa sud orientale. Fino alle soglie del Novecento era ancora sfruttata una miniera di diamanti: si trovava a sud ovest dell’isola, e tuttora si possono vedere sul luogo trivelle arrugginite, rovine di vecchie costruzioni e cunicoli, ora rifugio delle uerené, una sorta di lepri del deserto, dal mantello fulvo, vigilissime e veloci, che usano rubare le scorte di cibo dei viaggiatori, quando questi sono costretti a soste impreviste a causa di improvvise tempeste di vento.
Altri animali abitano l’isola, come gatti selvatici, diverse specie di scimmie, il leone della savana, un felino detto pantera viola, il mikuyì, cane che somiglia al nostro pastore tedesco, senonché è indolente, trascorre il più gran tempo in uno stato che potrebbe dirsi di letargo, si nutre solo di pesci d’acqua dolce, e dinanzi alle capanne dei villaggi, invece di fare la guardia, va incontro agli sconosciuti facendo grandi feste e balzando talvolta, con tutto il suo peso, in collo al visitatore, tra guaiti di benvenuto e slinguate affettuose. Molti uccelli migratori scelgono l’isola per le loro soste, soprattutto a primavera, quando le balze di sabbia si velano di chiazze erbose gialle e verdi che, se osservate da vicino, si rivelano essere bassi cespugli punteggiati da bacche blu. Un costume diffuso sia nei villaggi sia nella città è addomesticare specie di uccelli le più diverse. Così non è infrequente, entrando in una capanna o in una casa, essere accolti da trilli e cinguettii che paiono certo festosi, ma forse sono solo di richiamo o di malinconia. In tutta l’isola è poco praticata la caccia, mentre è assai diffusa la pesca, almeno lungo le scogliere meno impervie. Nei giorni di mare calmo piroghe veloci si allontanano dalla riva: l’equipaggio è composto dal vogatore e da un suo compagno che chiamano wehalini, cioè amico dei pesci. Costui, a un miglio circa dalla costa, si tuffa e cerca di scorgere, scendendo in apnea, qualche grosso pesce, del quale, una volta individuatolo, prende a imitare guizzo e movimenti. Risale in superficie e ridiscende più volte finché non accade che il pesce entri in confidenza col nuotatore e voglia giocare con lui. In quel caso l’amico dei pesci non risale più sulla piroga, ma tra inseguimenti e abili mosse da gioco, conduce il pesce fin verso la riva: qui esso è accerchiato da altri pescatori e catturato vivo. Per questa particolare forma di pesca la popolazione dell’isola è chiamata in tutto l’arcipelago wehalingalì, che vuol dire ingannatori di pesci.
La lingua dei soyumba – non ho mai saputo se è l’etnia che prende il nome dalla capitale o la capitale dall’etnia – è una lingua prevalentemente vocalica: quanto alle consonanti, dominano le labiali e le palatali. Il lessico pare essere ricchissimo, infatti per ogni oggetto ci sono più nomi, in rapporto alle stagioni diverse dell’anno. Inoltre le cose più familiari, e anche i nomi delle persone prossime, hanno un’ulteriore variante: di giorno un nome, di notte un altro. Quando ho chiesto a uno studioso locale ragione di questa pluralità, egli mi ha elencato molti motivi, tra i quali qui voglio ricordarne almeno uno. Il nome, egli diceva, non è che un’approssimazione all’essenza della cosa nominata, essenza che resterà sempre un enigma: più nomi si danno, più qualità della cosa si possono designare o almeno supporre, e di conseguenza maggiori probabilità ci sono che i nomi afferrino un frammento di quella inconoscibile essenza. E aggiungeva: quanto alla variabilità dei nomi di persona tra il giorno e la notte, essa si spiega col fatto che la differenza tra la luce e le tenebre agisce nei modi di sentire e di pensare: ciascuno di noi è diverso lungo l’arco del giorno, ma lo è soprattutto quando passa dal giorno alla notte. Devo aggiungere che lo studioso da me interpellato aveva compiuto i suoi studi in una università europea.
La lingua dei soyumba somiglia davvero al canto, tanto che nei discorsi rituali c’è sempre un accompagnamento musicale, con tamburi e strumenti a fiato che chiamano yu-yombalipé: una sorta di ottoni dal suono squillante e dolce. La lingua è ora scritta con lettere dell’alfabeto latino: un comitato di esperti, non molti anni orsono, ha codificato il passaggio dall’oralità alla scrittura. La letteratura era, fino a qualche anno fa, soltanto orale, ma ormai la scrittura è insegnata e praticata, al punto che anche nei villaggi più remoti si vedono affissi avvisi e scritte pubblicitarie.
La religione, in parte animistica, ha molti riti. Tra questi una specie di processione in onore dello spirito femminile chiamato Abalawa-ilé, cioè Signora delle gru. Nude, inghirlandate e tatuate, decine di donne dalla pelle d’ambra aprono il corteo, danzando e sorseggiando da coppe di legno una bevanda inebriante. Seguono uomini vestiti di tuniche bianche, che incedono con grande solennità. Quando il corteo è giunto nella piazza che si trova a ridosso delle mura, i musicanti si dispongono in cerchio e nel cerchio vengono chiamate, di volta in volta, due donne, le quali, liberatesi dalle ghirlande, si affrontano, nude, in una sorta di danza che è allo stesso tempo una lotta. La vincitrice va a scegliersi uno degli uomini del corteo e se lo conduce in una casa fuori porta detta Ahué-mbani, cioè Casa degli amori. Più fortunate sono le prime sorteggiate, perché può accadere che tra gli uomini del corteo ci siano i loro innamorati: in quel caso li scelgono con un forte grido di gioia. Le sfide durano fino all’alba, quando, così dicono, lo spirito è soddisfatto dei tributi d’amore ricevuti. Nonostante la straordinaria ospitalità praticata nella città di Soyumba, agli stranieri non è dato partecipare a questo rito amoroso, a meno che essi non abbiano già dimostrato di saper venerare con danze e canti la Signora delle gru. Ho conosciuto un giovane antropologo francese che, per poter partecipare a questo rituale o, come lui sosteneva, per poterlo conoscere meglio e meglio descriverlo nella sua ricerca, s’è sottoposto a lunghi esercizi di apprendimento delle danze e dei canti e s’è mostrato in grande interiore confidenza con lo spirito della divinità, o così ha fatto credere. Gli è accaduto di essere tra i prescelti, ma la notte trascorsa nella Casa degli amori lo ha persuaso a procrastinare la partenza. Oggi, a due anni da quell’evento, il giovane è ancora nell’isola.
Le strutture di parentela hanno codici che si riflettono nella lingua, nelle forme di interlocuzione, nei pronomi. Insomma la ricchezza della lingua è in relazione con la complessità e vastità dei rapporti familiari. La poligamia e la poliandria sono praticate entrambi, col risultato di una rete parentale di difficile decifrazione. Le nozze sono frequenti e il rito è celebrato nella Volta Accogliente, un edificio altissimo, a cupola, con il pavimento cosparso di stuoie di seta. Dopo le danze e le offerte gli sposi vengono lasciati soli, su un tappeto di fiori che si trova in un angolo della Volta. Prima della partenza degli ospiti, lo sposo canta versi di un poema cosmogonico yorumba, che tradotti e accomodati nella nostra lingua vogliono dire: “La nuvola è precipitata sulla terra / sciogliendosi in lacrime di gioia / perché ho fatto della tua pelle d’ambra / la veste del mio desiderio”. La donna risponde, cambiando tonalità e registro: “I miei giorni saranno la tua casa, / i miei occhi guarderanno i tuoi sogni, / il mio ventre sarà il fiume che scorre / nella valle del tuo futuro”.
Nell’isola, dopo la fine della colonizzazione si sono alternati diversi sistemi di governo, e da un decennio vige un ordine che potremmo dire repubblicano e democratico se non permanessero in uso alcuni istituti dei vecchi sistemi, come il diritto del Presidente di nominare dieci parlamentari scelti nel suo clan di provenienza e il diritto di farsi rappresentare, in alcune pubbliche manifestazioni, da una delle sue donne. Una volta che una donna abbia rappresentato il Presidente, la sua considerazione sale moltissimo presso gli uomini, e la percezione della sua bellezza si fa più intensa, cosicché finisce con l’essere desiderata da molti e molti sono in effetti coloro che la chiedono in moglie. Sembra che questo sia uno dei modi cui il Presidente ricorre per sciogliere un rapporto già logoro.
Il sistema giudiziario ha particolarità sorprendenti per noi europei. I tribunali sono tutti popolari, eletti democraticamente, rinnovati anno dopo anno. Essi non possono comminare pene corporali e neppure pecuniarie, ma soltanto per così dire morali. È infatti il giudizio della pubblica opinione che pesa più della condanna. Il condannato deve scegliere da sé il tipo di pena, sapendo che se non c’è corrispondenza tra la gravità del reato e la pena, non solo sarà sospeso dai pubblici uffici, ma sarà sottoposto ad alcune privazioni che per quel popolo sono pressoché insopportabili: non può essere ospitato né ospitare, non può partecipare ai riti nuziali e alle processioni d’amore, non può prendere moglie per tre anni. La condanna più grave che uno si possa dare è quella di andare a vivere per sei mesi tra i pinnacoli dell’Azzurra Dimora – nella loro lingua Hanvewa-Yablà – e dormire a quell’altezza su una lastra di pietra, visitato da cicogne e sparvieri. Il cibo, in questi casi, gli viene portato una volta al giorno da custodi.
Tra le credenze ancora diffuse c’è quella che attribuisce ai raggi lunari il potere di guarire da malattie anche gravissime. Ma la cosa può accadere quando la luna è al secondo quarto e alta nel cielo invernale. Così si vedono nottetempo carovane lasciare la città e seguire, fuori dalle mura, il cammino che conduce sulle balze desertiche. I soyumba credono che la luce lunare sia un effluvio profumato e benefico: per questo non solo i malati, ma anche i loro accompagnatori espongono, nelle notti del deserto, parti del corpo bisognose di cure, anche di cure preventive. Questo culto della luce lunare ha i suoi riflessi negli interni degli edifici pubblici e spesso anche nelle case private: le sorgenti di luce elettrica sono sempre coperte da veli di seta, l’uso del neon è proibito, i punti di ombra nelle sale pubbliche sono ritenuti privilegiati.
La credenza nella virtù dei raggi lunari ha favorito il successo di abili commercianti. Costoro vendono bottiglie d’acqua esposta per più notti alla luce della luna in luoghi particolarmente impervi del deserto. Non sono pochi i banchi del mercato che espongono queste merci ritenute miracolose. È questo uno degli aspetti che più mi hanno ricordato le nostre usanze. Mentre – per restare al mercato – tutto lì è diverso dai nostri costumi, tranne il vociare della folla, le grida dei venditori, gli inganni sui prezzi. Fatta eccezione delle merci deperibili e di rapido consumo, niente è comperato per sempre, ma soltanto acquisito, sotto forma di prestito, per un certo periodo mai superiore ai sei mesi. Questa è la ragione per la quale il turista di passaggio non può acquistare nient’altro se non provviste per il tempo del suo breve soggiorno. Di fatto molti propongono una revisione di questo sistema, ritenuto peraltro all’origine del diffondersi di furti e rapine e indebite appropriazioni.
Le abitazioni nella città di Soyumba, che ha trentamila abitanti, sono di pietra e di legno, disposte non una addossata all’altra lungo strade, ma isolate da piccoli spazi intermedi, per lo più usati per i giochi dei bambini. Accanto a tracce di architettura coloniale si possono riscontrare modelli riportati dalla struttura edilizia dei villaggi e trasferiti nella pietra. La casa cittadina è insomma una grande capanna di pietra, con un’ampia finestra sul retro e una specie di rosone sopra la porta di ingresso. Gli edifici pubblici sono invece alti, solenni, spaziosi: non è infrequente l’uso del ferro e del vetro, accanto alla pietra e al legno.
Le emozioni sono manifestate senza pudore. M’è accaduto di vedere spesso ragazze e ragazzi, ma anche adulti, piangere d’improvviso nel corso di una conversazione, o nell’angolo di un edificio, apparentemente senza motivo. Ho poi saputo che un ricordo che sopravvenga improvviso, la vista di una foglia tremolante al vento d’autunno, una formica che s’affanna cambiando direzione più volte, una goccia d’acqua che prima di staccarsi dalla grondaia trema per un istante possono essere la causa delle lacrime. Del resto è nota anche presso altre popolazioni dell’arcipelago la sensibilità dei soyumba nei confronti dei fenomeni naturali, la loro capacità di percezione del minimo evento, e soprattutto la convinzione che un sentire pulsa in tutte le cose, le quali vivono anch’esse di una loro vita. Come il riso, anch’esso frequente, il pianto è contagioso, ma presso i soyumba è connesso più alle proprie situazioni di gioia o alla sofferenza altrui che alle situazioni di dolore personale. Il dolore provoca in genere uno stato di mutismo, la contrazione del volto in una specie di astrazione, un’assenza e lontananza che sembra sottrarsi a ogni percezione dell’esterno.
Alla morte di un familiare o amico segue una danza rituale, che dura l’intera veglia funebre. Il giorno dopo, al momento della cremazione, mentre alcuni suonano per ore con i flauti e i tamburi una musica dolcissima, gli amici del defunto che possiedono uccelli in gabbia si recano alla cerimonia e liberano i volatili dicendo: “Accompagna il mio amico tra le nuvole, vola con lui e portalo dove l’oceano è di pietra e le case sono d’acqua”. Non si usa piangere il morto, non perché sia forte presso i soyumba la credenza di un aldilà, ma perché è radicata un’idea del tempo diversa dalla nostra. Lo scorrere del tempo umano è percepito in relazione strettissima con lo scorrere del tempo cosmico, e questo comporta due convinzioni: l’esistenza individuale è molto meno che il volo di un’effimera, se osservata dalla prospettiva del tempo dell’universo, inoltre ogni passaggio nel visibile – tale è la vita individuale – permane come presenza anche se sembra cancellato. Insomma non è tanto l’irreversibilità del tempo oggetto della riflessione, quanto la trasformazione di un tempo visibile in un tempo invisibile. Ciò che è passato perdura, trasformato in energia dell’universo.
Di altre credenze e di altri costumi dei soyumba dovrei parlare, dei giochi diffusi tra i bambini e gli adulti, della medicina popolare, dei culti, dei riti di iniziazione, dei residui di virtù sciamaniche rintracciabili presso i vecchi di qualche villaggio, del teatro, delle forme d’arte, dei modi con cui la tradizione viene insegnata e coltivata, dei rapporti con la modernità e con il turismo che da qualche anno approda, consistente, anche nell’isola di Koriyambi (un aeroporto è progettato, limitrofo alla capitale), attratto dalla bellezza di alcune cale marine e dai colori superbi dei tramonti. Ma per raccontare tutto questo con una cognizione non superficiale occorre ch’io torni laggiù. Per ora rinvio un viaggio pur fortemente desiderato. Forse perché l’ala di un dubbio mi sfiora spesso: sarà solo un viaggio oppure un addio al mio paese, alla mia lingua, ai miei affetti?

 Margini a Se la pietra fiorisce - Giuseppe Tiné
Margini a Se la pietra fiorisce - Giuseppe Tiné «Vi do la buonanotte».Un intervento di Gianni Celati - Redazione
«Vi do la buonanotte».Un intervento di Gianni Celati - Redazione Scrivere per nessuno - Gianni Celati
Scrivere per nessuno - Gianni Celati Divagazioni stanziali - Enrico De Vivo
Divagazioni stanziali - Enrico De Vivo Tempo del vedere, tempo dell’immaginare
Tempo del vedere, tempo dell’immaginare I classici e la barbarie
I classici e la barbarie Chirografie
Chirografie Arianna
Arianna





















