
Giorgio Messori è morto ieri mattina.
Lo salutiamo pubblicando questo scritto che ci inviò tempo fa.
*
Fin da subito andare nel Giura è stato innanzi tutto cercare i paesaggi di Gustave Courbet. Già a Mouthier erano apparse le rupi dipinte in un suo quadro, e proseguendo lungo la Loue verso Ornans, il paese dov’era nato, è comparsa finalmente anche la Roche-du-Mont, che ricordavo come sfondo di uno dei suoi quadri più famosi, quello della Sepoltura a Ornans, dove Courbet ha raffigurato una cinquantina di suoi compaesani raccolti al cimitero per seppellire uno di loro.
All’inizio cercare Courbet era soprattutto cercare le inquadrature dei suoi quadri. Ma al cimitero di Ornans, dove adesso ci sono anche le sue spoglie e che Courbet aveva dipinto nel 1849, appena un anno dopo che era stato inaugurato, lì al cimitero diventava più difficile ritrovare, anche solo nell’immaginazione, lo scenario originario della Sepoltura a Ornans. Ormai le tombe erano troppe e anche troppo ornate e infiorettate; inoltre col tempo erano cresciute tante case ad affollare l’orizzonte, finendo così per cancellare quell’intimità struggente, da cimitero di campagna, che si può ammirare in quel celebre quadro. E poi, anche volendo togliere dagli occhi case e tombe, e concentrarsi solo sulla lunga barriera della Roche-du-Mont e la rupe col castello, comunque non si riusciva neanche a capire bene come quello sfondo potesse essere contenuto in una sola inquadratura. Più facile forse l’effetto di una visione circolare, che non un “quadro” già predisposto dalla natura stessa.
Eppure Courbet aveva detto in una celebre lettera, considerata come una sorta di manifesto del realismo, che “ il bello è nella natura” e che “i nostri accorgimenti stilistici non hanno il diritto di deformarlo”. Ma ciò non vuol dire che Courbet volesse semplicemente fotografare la natura, perché “l’immaginazione in arte”, ha detto con molta chiarezza lo stesso Courbet, “consiste nel saper trovare l’espressione più completa di una cosa esistente”. Perciò non si tratta mai di copiare, piuttosto di rendere visibile qualcosa che ci appare in natura dandogli una forma, un’apparenza compiuta.
Ma forse è anche vero che ogni realismo, per affermarsi, ha sempre bisogno di nuove allegorie, e far cingere i suoi compaesani dalla Roche-du-Mont era una modo per Courbet di dichiarare la sua appartenenza a quelle rocce e a quella terra, terra inscindibile dai suoi compaesani, e forse dalla sua stessa carne. Perché ogni realismo, almeno all’inizio, ha sempre bisogno di una forte spinta ideale, quasi religiosa, in quanto vuol sempre proporre una visione “piena” del mondo.
“Essere non solo un pittore ma anche un uomo, in una parola fare dell’arte vivente, questo è il mio scopo”, aveva dichiarato Courbet in un suo scritto. E per Courbet l’arte vivente si nutriva soprattutto della sua terra a cui tornava sempre, anche durante i lunghi soggiorno parigini, almeno fino a che non lo costrinsero all’esilio negli ultimi anni di vita. Ma anche quand’era a Parigi, coi pittori alla moda malati d’esotismo, pare che Courbet rivendicasse con orgoglio l’appartenenza alla sua terra, ironizzando su tutti quelli che per dipingere partivano per l’Oriente, un po’ come adesso un romanziere dovrebbe partire per New York, o la Terra del Fuoco. Courbet diceva ai parigini malati di esotismo che lui un paese, una terra, ce l’aveva, e voleva dipingere quella.
Infatti Courbet la sua vallata l’ha raffigurata innumerevoli volte, percorrendola in lungo e in largo dalla sorgente del Loue, il fiume che l’attraversa, fino ad altre sorgenti e ruscelli che s’immettono nel fiume, fermandosi di tanto in tanto a dipingere la superficie dell’acqua che corre o che s’acquieta, le rocce che spuntano dal verde dei boschi e fra le gole dei ruscelli, e poi entrando nei boschi ombrosi dove s’incontrano cervi e caprioli, o cacciatori, oppure fermandosi in un viottolo di campagna dove passavano dei contadini che tornavano da una fiera. Buona parte della sua opera è, un canto d’amore alla sua terra, alla sua vallata, tanto che perfino nel grande quadro del suo atelier, dipinto a Parigi, Courbet si ritrae attorniato da una folla di amici, fra cui alcuni illustri parigini, mentre dà gli ultimi tocchi a un paesaggio della sua vallata nel Giura. Dietro di lui una modella, nuda, e un bambino con un cane sembrano gli unici ad interessarsi al quadro che Courbet sta dipingendo, mentre l’eterogenea compagnia che affolla il suo atelier si perde nella penombra di uno stanzone enorme.
Che l’arte di Courbet fosse inscindibile dalla sua terra era già chiaro allo scrittore Champfleury, considerato da molti il teorico del realismo, che al poeta Mx Buchon, cugino di Courbet, raccomandava in una lettera: “Courbet deve stare a Ornans. Se lo vedete, cercate di trattenerlo in paese il più a lungo possibile. Lui ha bisogno di ritemprarsi in mezzo alla natura”. E altrove, in un’altra lettera indirizzata allo stesso Buchon Champfleury diceva che a Courbet “l’aria di campagna è certo più congeniale e salutare di quella delle bettole di Parigi”.
Si dice che Courbet sapesse dipingere di tutto, perché fin da piccolo si era esercitato a osservare le rocce di calcare giurassico che naturalmente, come tutte le rocce, hanno forme e fisionomie molto diverse. Questo esercizio lo aveva portato ad avere una capacità di osservazione rara, che gli consentiva appunto di dipingere qualsiasi cosa avesse davanti.
Però non è considerato, credo a ragione, un grande ritrattista. Forse non vedeva gli uomini nella loro individualità, che è qualcosa che ha a che fare con l’osservazione psicologica più che con la descrizione delle forme che compaiono in natura, da cui Courbet è stato costantemente affascinato. In fondo i ritratti più belli sono di quegli uomini che appartengono ancora a una comunità (la gente al cimitero di Ornans) o che sono strettamente connessi alla terra (spaccapietre e contadini, ma anche il corpo di una donna). Sono invece meno interessanti quei ritratti dove c’è un uomo isolato, cittadino.
Si dice fra l’altro che la sua amicizia con Baudelaire si sia incrinata perché a Baudelaire non era piaciuto il ritratto che Courbet gli aveva fatto. E Courbet si sarebbe giustificato con lui dicendo che “è impossibile ritrarre uno che cambia faccia tutti i giorni”. Perché la mutevolezza di un volto non appartiene allo stesso ordine delle forme che cambiano continuamente nello scenario della natura, anche perché nella natura il tempo ha una durata, non è successione convulsiva di istanti, come può accadere per il volto di una persona.
Il talento fisionomico del “naturalista” Courbet sapeva distinguere bene le differenze, non individuare singolarità irripetibili. Gli alberi, le rocce, appartengono a una specie, a una famiglia, non hanno una loro identità distinta, un nome proprio. E le rocce, anche lassù nella Roche-du-Mont, non conoscono altri umori che quelli della pioggia, del vento, delle nuvole che si posano dal cielo.
Quando lo scrittore Jean Genet andò a visitatre Giacometti nel suo atelier di Parigi, osservò che la tavolozza di Giacometti era “una fangosa pozzanghera, di grigi diversi”. Perché Giacometti, anche nella pittura, cercava un’arte dura, pietrosa, non certo fluida o ariosa. Le sue opere, in un modo o nell’altro, dovevano avere la consistenza della pietra, forse anche la sua fragilità, ma una fragilità modellata dal tempo.
Nel Giura anche le pietre, le rocce colorano di terra, e spesso, per l’umidità, i sassi sono coperti di muschio. Sembrano esistere tutte le tonalità del verde edel marrone, le infinite variazioni di un paesaggio terrestre sottola linea dell’orizzonte. Ma non siamo più sulle Alpi, le rocce non indicano più il cielo, l’orizzonte illimitato.
L’arte di Courbet non è un’arte da alte vette, che potrebbero evocare l’infinito azzurro del cielo. La sua tavolozza era sempre umida di terra, letteralmente fangosa.
Pare che la valle della Loue sia una delle vallate più piovose che si conoscano. Anche i giorni che siamo rimasti nei dintorni di Ornans raramente si è affacciato il sole. Perciò ci si muove sempre sotto la minaccia di qualche acquazzone e bisogna spesso rassegnarsi a un ombrello, o a un rifugio improvvisato.
Tutta quest’acqua che vien giù la si può comunque ritrovare, anche se non piove,nei tanti corsi d’acqua che scorrono per la vallata,nelle sorgenti che escono dalle rocce, nel verde rigoglioso delle piante e il manto scuro dei prati. A inoltrarsi in un bosco, poi, bisognerebbe essere nittalopi, come i pipistrelli, per orientarsi in quel buio lussureggiante di alberi e arbusto.
E immersi nel buio erano anche tanti dipinti visti alla casa natale di Courbet, a Ornans, dove sono conservate una trentina di sue tele, per lo più vedute del Giura. Più che le forme mutevoli dei calcari giurassici la cosa che colpiva di più, guardando quei quadri, era constatare l’incredibile capacità di Courbet di scrutare nelle ombre, di entrare nel buio con gli occhi attenti di un nittalopo. Perché le sue ombre non sono mai una semplice cesura al chiaro, al luminoso. Speso sono fitte di segni, di piani diversi: zone di oscurità, non buio indistinto.
Pare che Courbet preparasse in genere dei fondi scuri su cui dipingeva con dei colori ancora più scuri. Da ciò, come dice John Berger in un suo saggio, il fatto che nei quadri di Courbet “la profondità è sempre dovuta all’oscurità”.
L’occhio di Courbet, oltre che sulle fisionomie delle rocce, si esercitava volentieri fra le ombre di alberi, nuvole, rocce, che magari si specchiavano nell’acqua costruendo una trama visiva in cui fondersi e distinguersi continuamente in una specie di gioco infinito. Ma non è l’infinito del cielo, è un infinito che sprofonda, s’inabissa in un ordine naturale che non ha più niente di cosmico: è solo terra, e l’acqua che la nutre.
C’era una strana eccitazione a scoprire Courbet nel paesaggio, a cercare i suoi verdi “fondi” che disegnano infinite configurazioni sotto le rocce, specchianti nell’acqua. Fra l’altro in macchina ascoltavamo sempre le ultime canzoni di Bob Dylan, e ce n’era una che al ritornello Dylan cantava “It’s not dark yet”, non è ancora buio, e ci sembrava un invito a guardare che ci veniva da Courbet. Perché anche la musica diventava courbettiana, non solo il paesaggio.
Una volta esaurita la curiosità di ritrovare i suoi quadri inquadrati nella natura, Courbet non era più “quell’immagine”, diventava un tono nella percezione del mondo. E anche Dylan cantava Courbet.
L’invito a scrutare nel buio, che leggevamo in Courbet e ascoltavamo in Bob Dylan, ci ha incuriosito pure a cercare una grotta che s’incontra andando verso la sorgente del Pontet, un breve corso d’acqua che poi si butta quasi subito nella Loue. La grotta è chiamata “La grotta dei falsari” e ha una configurazione così perfetta, con un bell’arco che si apre nella roccia e s’inoltra nel buio, da sembrare un archetipo capace di suggerire strane avventure: l’orso che esce, un ventre oscuro della terra, o appunto un covo segreto, come doveva essere per quei falsari che un tempo brigavano là dentro.
Per accedere alla grotta c’è una scaletta di ferro a cui ho rinunciato per le vertigini, ma Vittore che ci è andato mi gridava da dentro che era proprio una grotta come la si sarebbe potuta immaginare. E poi si è messo a guardare fuori, nel mondo visibile, protetto dalla roccia come se fosse il manto nero della sua camera ottica.
E mentre Vittore fotografava c’era lì a due passi, proprio sotto la grotta, un signore che perlustrava il terreno con un metal detector, lamentandosi che era riuscito a trovare solo della moneta corrente. Anche lui era in cerca di una sua avventura: cercava delle vecchie monete false perché adesso valgono di più di quelle vere, ci spiegava per giustificare la sua singolare ricerca.
Il ventre oscuro della terra etra invece un’avventura da vivere ancor meglio alla sorgente del Pontet, dove l’acqua sgorga dal buio di una grotta e non ci sono neanche tutti quei cartelli e staccionate che avevamo incontrato alla sorgente della Loue, che Courbet aveva dipinto ben 14volte. Quando ci eravamo stati noi c’era però troppo a gente, e soprattutto troppi cartelli e recinti a disturbare la visione. Invece alla sorgente del Pontet non c’era niente e nessuno che si frapponesse a una tranquilla visione
dell’acqua che sgorgava dalla grotta oscura.
La curiosità per le sorgenti ci era stata sollecitata da un libro trovato al book-shop del museo-casa natale, a Ornans, dove c’era un raffronto fra un quadro della sorgente della Loue e quel famosissimo dipinto di Courbet che raffigura, in modo molto realistico, il sesso di una donna. In quel quadro, intitolato L’origine del mondo, il volto della donna non si vede neanche, e il pube in primo piano è raffigurato con una cura quasi fotografica, che rende bene visibili i dettagli. Da qui probabilmente la sua celebrità “scandalosa”.
Ma la cosa più interessante, considerando il raffronto proposto da quel libro, era constatare che il sesso della donna era raffigurato nell’identica posizione, e con lo stesso “peso”, dell’acqua che sgorgava dalla sorgente della Loue. Quei due quadri, pur nella diversità del soggetto, avevano la stessa “inquadratura” ed esponevano un’identica armonia compositiva. Così in questa equivalenza si poteva leggere pure il segno di un mistero comune, che legava l’origine della vita all’origine stessa del nostro mondo terrestre, di tutto ciò che può appunto prender vita grazie all’azione vivificante dell’acqua. Dove non c’è acqua, come sulla Luna, si può infatti incontrare soltanto un immenso deserto. E allora per Courbet la sorgente del suo fiume poteva pure evocare il ventre di una donna, cioè l’origine stessa della vita umana.
E per restare al luogo là dove si nasce, si potrebbe dire che Courbet, a proposito della sua nascita, andava in giro a raccontare ch’era nato sotto una quercia in un viaggio che la madre aveva fatto da Flagey a Ornans.È probabile che questa sia una menzogna, una balla, perché Courbet coi parigini amava molto romanzare la sua vita, forse per crearsi un personaggio nella recita mondana, o perché gli piaceva semplicemente giocare con simboli e allegorie. E allora era meglio una quercia, che non il conforto di un letto nella sua bella casa di Ornans. Nascere sotto una quercia si confaceva meglio alla sua identità di pittore immerso nella natura vivente.
Comunque Courbet si è spesso ritratto sotto una quercia, da solo o con la donna amata, sulla cui corteccia in un quadro è inciso pure il nome, e un’altra volta, da giovane, sotto una quercia si era pure raffigurato ferito in duello, col petto insanguinato. Ma c’è soprattutto un quadro dove la quercia è padrona assoluta, ed è quello denominato La quercia di Flagey, proprio il paese da cui era partita la madre per partorirlo, nell’ipotesi romanzesca di una sua nascita all’aperto, in piena campagna.
In questo quadro la quercia è così maestosa da oscurare il cielo, anche perché Courbet sceglie di ritrarla coi rami che toccano quasi interamente i bordi della tela. Non ce la mostra a figura intera, con tutta la sagoma ben disegnata dall’azzurro del cielo.
Nonostante ciò è uno dei quadri più luminosi di Courbet, come se quest’enorme pianta avesse in sé un suo fulgore, quasi fosse la celebrazione, luminosa, del perdurare della vita sulla terra. Non a caso, per marcare la vita ultrasecolare di quell’albero, lo stesso quadro è anche chiamato La quercia di Vercingetorige, il celebre sovrano e condottiero degli antichi galli.
Dunque la quercia,nelle allegorie di Courbet, poteva essere anch’essa, come una roccia di calcare giurassico, testimone visibile del trascorrere del tempo; ma anche, nel caso della quercia, testimone vivente di un tempo più propriamente storico,che è poi il tempo in cui si svolge l’esistenza degli uomini, insieme alla memoria degli uomini che non ci sono più.
L’apparizione di una quercia, andando in giro per la vallata della Loue, l’abbiamo avuta dalle parti di Epurane, non troppo distanti da Ornans. Era una bella quercia, isolata in mezzo a un prato.
Però questa quercia non aveva i rami carichi di quel verde lussureggiante riconosciuto nella quercia che Courbet doveva aver dipinto a Flagey. Anzi, sopra i rami della nostra quercia, a Epurne, crescevano sbuffi di vischio che sembravano piccole metastasi, anche se dall’aspetto gentile, che però volessero ricordarci che adesso la natura è spesso malata.
Lo scrittore John Berger, nel suo saggio dedicato a Courbet, dice che i quadri di Courbet “somigliano a dei pozzi” e che “ci sono paesaggi di Courbet che potrebbero essere paesaggi riflessi in uno stagno”.
A questo proposito va detto che Courbet amava molto i miroir,gli specchi d’acqua che si formano quando ci sono degli sbarramenti lungo il fiume. Quand’era a Ornans gli capitava spesso d’andare a dipingere ai miroir della Loue. Perché quando il cielo è coperto,come capita spesso in questa vallata, allora i verdi di una natura umida, rigogliosa, si adombrano specchiandosi in un’acqua stagnante, e la luce è così riposante che si può stare a guardare nell’acqua pe delle ore. Se poi si alzano gli occhi, ad allargare la visione, sulla sommità del verde trapelano delle rocce, disposte come una corona su cui si posa il cielo. Perché, come già detto, nella vallata della Loue le nuvole sono spesso basse, e allora si può avere l’impressione di trovarsi davvero in fondo a un pozzo.
Quella volta che mi son seduto sul muschio all’ombra degli alberi in riva al Miroir de Scey, uno dei luoghi prediletti da Courbet, quella volta mi son trovato letteralmente immerso nella infinite tonalità di verde che si specchiavano nell’acqua stagnante del miroir, nelle pozzanghere dopo ch’era appena piovuto. Fra le cime degli alberi, specchiati nell’acqua, comparivano spicchi di quel cielo scuro che pare gravi spesso in questa vallata, e le nuvole sembravano così pesanti, riflesse nell’acqua, d’apparire come fossero fatte di terra, quasi fossero soltanto il fondo di una pozzanghera.
Anche guardando le marine di Courbet, naturalmente dipinte altrove, in Normandia, colpisce il fatto che pure l’acqua del mare abbia spesso una consistenza fangosa. C’è un quadro conservato alla Nationalgalerie di Berlino, dipinto nel 1869, dove un’onda del mare in tempesta si concretizza in un’enorme zolla, sotto cumuli fangosi immobili nel cielo. L’azzurro è solo un ricordo, uno spiraglio che trapela tra le nubi pesanti di terra.
Ancora non riesco a capire bene cosa mi attragga dello “scuro” Courbet. Se penso a ciò che amo, alle immagini che ho amato di più, come i quadri di Hopper, Piero della Francesca, le foto di Luigi Ghirri, mi sembra che siano tutti esempi di visioni che vanno verso la chiarezza, la luminosità. Immagini e corpi sospesi nella luce, evanescenti.
Invece Courbet, grazie anche a quel viaggio nel Giura, m’introduce in un mondo da cui sembra sparire il cielo, la sorgente di luce. C’è l’acqua, la terra, la forza di gravità che spinge giù, e il cielo quando appare è spesso un coperchio. È come sentirsi sempre in un orizzonte chiuso, irrimediabilmente terrestre.
Forse è proprio questo “fondo” che mi attrae in Courbet: vedere il mondo come un’apparizione solamente terrestre, nel senso proprio della terra, ma anche della nostra, della mia carne. Insomma il mondo “materiale”, la materia di cui siamo fatti e di cui è impastato il mondo. Letteralmente Ex-terrae-factus, fatto di terra, esterrefatto. Uno stupore nuovo, forse più doloroso.
Passeggiando una sera lungo la Loue, Vittore ha trovato un bruco luminoso nascosto nel fogliame. Non aveva la luce intermittente delle lucciole, ma una luce verdina continua, simile a quei bracciali fosforescenti che a volte si mettono ai concerti, o nelle sere d’estate. Nessuno di noi aveva mai visto un bruco del genere, anche se poi mi sono informato da altri che mi hanno spiegato che questi bruchi esistono da sempre. Ma noi non li avevamo mai visti.
Detta così sembra una storia inventata, però ci è successa davvero e sembrava davvero un segnale del destino, un’indicazione (di Courbet?) che voleva invitarci a scrutare nel buio, a cercare nel buio le luci più nascoste.
Riguardando le foto fatte nel Giura, specie quelle al miroir de Scey, che ci aveva così incantato, nelle foro però non ritrovavamo lo stesso splendore oscuro che avevamo riconosciuto nel paesaggio, suggestionati da Courbet. Vittore era insoddisfatto, voleva tornare nel Giura per scattare altre immagini, per trovare finalmente un paesaggio che corrispondesse alle attese.
Poi girando un provino, quasi per caso, sul fondo dell’acqua è apparso improvvisamente un paesaggio così ampio da far sembrare le altre immagini semplici dettagli, approssimazioni. Capovolgendo un provino appariva finalmente un paesaggio, cioè una veduta ampia e che suggerisse anche un’idea di compiutezza, insomma qualcosa in cui far volentieri perdere i propri pensieri, il proprio sguardo. Così abbiamo provato anche con altri provini, e ci siamo accorti che spesso, capovolti nell’acqua, i paesaggi al miroir de Scey diventavano più interessanti, affascinanti e compiuti.
Anche in questo caso dovevamo ringraziare Courbet per averci insegnato a scrutare nel buio, a guardare il mondo che si specchia anche nel fondo di una pozzanghera. La cosa strana di quei paesaggi “trovati”, saltati fuori in un blow-up un po’ casuale, è che le immagini riflesse, e capovolte, spesso ricordavano davvero quei paesaggi di Courbet che sembrano paesaggi riflessi in uno stagno, come diceva John Berger. E non è che i paesaggi “trovati” ricordino qualche altra opera di Courbet, non cercano di rifare un suo “quadro”.
Però in quelle immagini potevamo riconoscere la profondità di tanti paesaggi di Courbet, profondità dovuta anche al turbamento prospettico che si può avere quando si guarda il mondo riflesso nell’acqua. Nell’acqua anche il cielo torna per terra.
Lungo la Loue, nei luoghi dove andava a dipingere Courbet, ci sono le riproduzioni dei quadri fatti in quei posti, e uno sgabello dove il visitatore può ritrovare il punto di vista scelto da Courbet. C’è anche una tavolozza, accanto al quadro, dove si spiega la storia di quell’opera.
A dir la verità i punti di vista non coincidono mai tanto, e ci sono delle vedute che proprio non si spiegano. Ma l’errore, almeno all’inizio, era pretendere di ritrovare i quadri di Courbet intatti, già incorniciati nella natura vivente, come se fossero immediatamente disponibili a farsi ritrarre da un obiettivo fotografico. Perché non va neanche dimenticato che Courbet, come ogni pittore, alla fine faceva i conti innanzitutto con lo spazio del quadro, e perciò si potevano spostare anche delle rocce, sulla tela, senza con questo tradire le rocce.
La visione di un pittore, per quanto il pittore voglia avvicinarsi a una visione empirica, è sempre un ricrearsi del visibile, mai una sua riproduzione. D’altronde il visibile non ha in sé la facoltà di riprodursi, e se lo vediamo è anche grazie ai tanti pittori, fotografi, cineasti, che ce lo hanno reso visibile. Quando vediamo, vediamo anche attraverso dei quadri, o la scena di un film. Perciò una dimensione così profondamente terrestre dello spazio la riconoscevo anche grazie a Courbet, e può capitarmi di riconoscerla anche altrove, non per forza nel Giura.È diventata quasi uno stato d’animo, un’inclinazione che segue una sua direzione.
È sempre strano provare a guardare, per quanto possibile, un paesaggio con gli occhi di un pittore, perché sembra di entrare in quel processo mentale che ha reso visibile il visibile. L’esperienza non è tanto ciò che si vede, ma come si organizza una visione. Perciò è anche sempre qualcosa che travalica il visibile, qualcosa di simile a un’esperienza interiore, letteralmente interiore perché vissuta nel corpo, attraverso cui vediamo e ci muoviamo nel mondo. E il mondo, quando riesce a organizzarsi in una visione, non è più soltanto qualcosa che riconosciamo all’esterno, nello spazio al di fuori di noi.

 La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori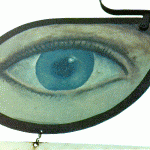 Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo - Giorgio Messori L’Esordio - Enrico De Vivo
L’Esordio - Enrico De Vivo Finestre in Engadina
Finestre in Engadina





















