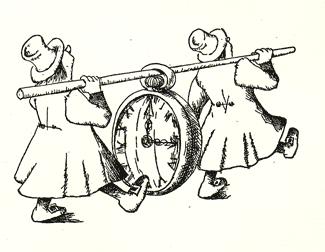
Dopo aver letto il suo libro, “La trasparenza delle immagini” (di cui ho scritto qui), avevo chiesto a Emanuele Coccia di rispondere ad alcune domande intorno alle questioni da lui trattate. Coccia ha replicato alla mia richiesta con una lettera che è una riflessione sulla scrittura e, allo stesso tempo, un’appendice perfetta al suo libro. La pubblico qui di seguito con il suo consenso, insieme alle domande che gli avevo inviato. Il titolo è redazionale. (E. D. V.)
*
Caro Enrico,
vorrei scusarmi per il mio silenzio: mi spiacerebbe se tu credessi che abbia dimenticato le domande che mi avevi posto qualche mese fa. Ho provato più volte in questi mesi a rispondervi, senza mai riuscire a tracciare poco più di una riga. E questo non perché le tue domande fossero fuori luogo: al contrario, esse mi hanno spinto a ricerche, a nuove letture, domande impensate, ad altre scritture. Ma ogni riferimento al libro invece mi era impossibile. Credo di non essere capace, almeno non ancora, di pormi seriamente dinanzi ai miei vissuti – agli stessi pensieri che mi hanno attraversato – in termini di vero e proprio soggetto conoscente. E ciò perché in realtà non sono stato mai io a pensare in essi: mi sono trovato sempre gettato in essi, e ho dovuto a fatica provare ad esistere nel medio del loro stesso spessore, a ritrovare una possibilità di esistenza, un mondo possibile in quelle luci così estranee al luogo in cui ricordavo di provenire. Ogni lettura, ogni atto linguistico è in fondo una forma di inatteso e subitaneo esilio. (O forse tutto ciò che vive è in esilio: in esilio da sé innanzitutto e dal proprio luogo. Vivere significa sempre essere fuori luogo). Si è improvvisamente gettati in un mondo ed in un’esistenza diversa da quella che ritenevamo essere la nostra. Comprendere in questi casi serve a poco; così come del tutto inutile è riuscire a capire di quale luogo si tratti. Trovatisi in questo non-luogo, ciò che permette di sopravvivere è l’istinto a percorrere il paese, schizzare mappe e soprattutto lo sforzo di iniziare a vivere in esso. Fare quasi lo sforzo inverso a quello dell’etnologo: ricostruire il modo che la vita umana assume in questo paese, non per descriverlo, ma per aderirvi il più possibile. La scrittura del libro è stato tutto questo: qualcosa a metà strada tra una mappa di questo paese di idee, pensieri e visioni (mi verrebbe da scrivere colori, linee, spessori, perché in fondo tutto in questi paesi non ha altra consistenza che quella di immagini), un diario di viaggio e assieme un congedo definitivo. Ora sono altrove e tutto ciò che posso apprendere di quel luogo deriva da quelle pagine. Perché chi ha scritto quel libro è interamente scomparso, sprofondato in esso come in un Atlantide. Di quell’io che ha vissuto e pensato in quel luogo – posso dare solo vaghe testimonianze. Non ne so più nulla. Certo, vi sono ancora immagini e scorie che rivivono in me, ma lo fanno allo stesso modo in cui secondo Warburg, nel gesto di una golfista può rivivere lo spirito Salomé degli antichi, o nel modo in cui nel nostro gesto distratto di toccarci la testa nei momenti di distrazione rivive quel medesimo gesto con cui i romani invocavano il proprio Genius. Nessuno dei due ne sa nulla e se v’è un qualche rapporto, è qualcosa più vicino ad una sublime ignoranza, ad un uso senza conoscenza. Non so cosa sia davvero rimasto. Meglio, rimasto è solo l’irriconoscibile: ciò che rende quel libro irriconoscibile e ciò che rende me irriconoscibile a me stesso. Se qualcosa vive lo è proprio per questo elemento irriconoscibile e quanto chiamiamo ego non è soltanto il meccanismo atono attraverso cui ciascuno arriva a coincidere con se stesso e la propria immagine, ma la custodia e la cura di un irriconoscibile. Per questo l’Io è sempre il luogo di un problema, di un corpo a corpo con se stessi che non può mai essere risolto attraverso la sola conoscenza. L’irriconoscibile è anzi quel punto cieco in cui non riusciamo più a distinguerci da tutto ciò che non siamo, il luogo in cui viviamo, le persone che incontriamo. Un libro non è un modo per ritrovarsi ma la decisione di perdersi in qualcosa che non ci appartiene né potrà mai appartenerci. E la scrittura è sempre il tentativo di produrre un rapporto a questo irriconoscibile – ciò che resta di ciò che abbiamo vissuto e ciò che ci trascina senza arresto verso ciò che non siamo ancora e verso ciò che non abbiamo vissuto.
Scusa per questa lettera così lunga, ma volevo testimoniarti la gratitudine per quello che hai scritto e per le tue domande, che mi hanno portato nello studio dove non sarei arrivato da solo. Mi spiace solo di non essere stato capace di darti risposte che fossero all’altezza delle tue domande. Spero però di avere la possibilità di conoscerti personalmente, e di poter continuare a scriverci, anche se con questi tempi lunghi e queste piccole sfasature tra la domanda e la risposta.
A presto, tuo
Emanuele Coccia
Diciannove domande
di Enrico De Vivo
Un’interrogazione è conoscibile indifferentemente
dall’esistenza di una soluzione o di un’eventuale risposta”Emanuele Coccia, La trasparenza delle immagini
1 – I due termini che sono nel titolo del suo libro, “trasparenza” e “immagini”, mi riportano alla mente questa frase di Michaux: “Scrivo e dipingo per attraversarmi”. Qui Michaux, per alludere alla soggettività pensante (scrivente, raziocinante), non usa una definizione psicologica del tipo “per esprimermi”, ma immagina l’interiorità attraverso una metafora di luogo che implica un passaggio, un affidamento a qualcosa di esterno che non ci appartiene.
2 – Secondo Aristotele, gli antichi, che credevano che “il pensiero e l’intelligenza siano una specie di sensazione” (De anima, III, 427a), “avrebbero dovuto parlare anche dell’errore, che è la condizione più caratteristica degli animali, nella quale l’anima trascorre più lungo tempo”. Dalla considerazione dell’errore, della follia, dell’oblio prende avvio anche la speculazione averroista, per mettere in luce che l’uomo soltanto accidentalmente, e soltanto grazie ai suoi propri “errori”, diventa “razionale”. È come se le illusioni e gli inganni dell’immaginazione fossero il cibo del pensiero, che altrimenti sarebbe una landa disabitata, desolata e sterile.
3 – Tra le accuse storiche mosse all’averroismo, c’è quella di “ridurre l’uomo a una bestia (quoddam brutum)”. Questa riduzione – che mi fa venire in mente i giganti “empi e vagabondi” di Vico e gli yahu in Gulliver – viene attribuita all’averroismo, se ho ben capito, proprio perché l’averroismo propone una sorta di regressione rispetto all’idea, “chiara e distinta”, e tipica della filosofia della coscienza, di un soggetto conoscente e parlante?
4 – Noi siamo abituati a pensare che è all’interno di una coscienza che avviene qualsiasi scoperta intellettuale o conoscenza, e non, come lei osserva sulla scorta dell’averroismo, nel medio di un inconscio, cioè quando ancora non si sa nulla. Potrebbe chiarire meglio che cosa intende con l’espressione “nel medio di un inconscio”?
5 – Se, come lei osserva, l’animale razionale piuttosto che a un ente, corrisponde a uno “stato di composizione o di aggregazione dell’intelligibilità con i fantasmi individuali”, si potrebbe dire che la ragione stessa – ma anche la scrittura, la filosofia –, è la capacità di porre in relazione la parte bruta e infante (fantasmatica) di sé con la parte sconosciuta e separata (intelligibile) del pensiero universale?
6 – Gli averroisti ricorrono all’immagine della tavoletta di cera già presente in Aristotele, per chiarire che “potere significa essere capaci di passione (posse est pati), e, viceversa, che ogni passione non è che il segno di una potenza…”. Dunque la conoscenza non è altro che una disposizione alla passività?
7 – Come avviene il passaggio dalla possibilità di pensare, al pensiero di qualcosa di particolare, all’atto di pensiero? Secondo quale “dinamica” l’intelletto materiale, la totalità del pensabile, entra in contatto con un soggetto? A questo punto l’averroismo introduce la nozione decisiva di “immagine”, collegata, mi sembra di capire, a quella di intelletto teorico (intellectus speculativus). È dunque grazie a un elemento estraneo a sé, fuori di sé, che il pensiero diventa attuale?
8 – Se la ragione non è delle cose del mondo che ha bisogno per raggiungere la sua perfezione, ma delle cose del pensiero, di conseguenza il filosofo non è colui che ha la massima esperienza delle cose del mondo (la cosiddetta saggezza), ma colui che è massimamente agile e coraggioso nella produzione di immagini (“sensibilia non materialia”, secondo una bella definizione di Averroè). Lei parla a questo proposito di “sensibilità immaginale”. Potrebbe chiarire questa espressione molto intricante?
9 – Lei dice che quella dell’averroismo è “una rivoluzione poetica prima che noetica”, e lo dice in riferimento alla figura del filosofo, ovvero “colui che avrà saputo trasformare in congiunzione la divisione tra il proprio corpo individuale e l’unico intelletto, quella tra esperienza e intellezioni e quella, nell’intelletto, tra potenza e atto”. Di “filosofi poeti” tutti intuitivi aveva parlato anche Vico. È in un senso simile che intende anche lei?
10 – L’averroismo “rappresenta il solo episodio in cui il pensiero abbia cercato di amare quanto la vita umana non cessa di frequentare e produrre”: debolezze, illusioni, stupidità, fantasie, dimenticanze. Vengono in mente poeti e scrittori come Leopardi, Kafka, Beckett; ma anche grandi smemorati come Don Chisciotte e Bartleby. Pensare significa in qualche maniera aver sempre bisogno di ricordare l’immemorabile e, quindi, di immaginarsi tutto?
11 – A proposito di uno dei personaggi più noti di Ariosto, Gianni Celati scrive: “Angelica incarna l’instabilità delle immagini, che trovano la loro potenza nel sottrarsi a ogni fissità, nell’essere sempre erratiche e inafferrabili. La potenza delle immagini è l’instabilità, la mutevolezza che ci rimanda sempre ad altro, la sfuggenza mercuriale di Angelica”. Il soggetto della conoscenza così come viene delineato nel suo libro assomiglia piuttosto a un poeta che “pensa nelle immagini”, che a un filosofo o a un professionista del sapere come siamo abituati a immaginarlo oggi.
12 – Altra cosa importante, forse, è pensare “intellezione e immaginazione non più nei termini di una successione cronologica per cui la prima sospende la seconda, ma in un rapporto di simultaneità: motore e mosso sono infatti simultanei”. Questo significa anche che la fantasia non è prerogativa infantile o precedente in qualche maniera il pensiero, e che l’immagine non è qualcosa da superare o rimuovere?
13 – Per Vico è l’immaginazione (un “errore”), cioè la capacità umana di figurarsi il mondo, a dare inizio alla civiltà. L’umanità che esce dal diluvio e dallo stato ferino va dietro alla sua fantasia, procede per ipotesi pratiche e invenzioni minime (il “senso comune”?), prima di dare vita a qualsiasi istituzione, che è sempre innanzitutto immaginata, mitica. Il mondo è stato sognato prima di essere qui, e l’esser qui non è altro che l’appendice (effimera, imperfetta?) di un sogno. Secondo lei, attraverso queste osservazioni, è possibile collegare la speculazione vichiana all’averroismo?
14 – Da Tommaso in poi la filosofia ha cercato e trovato in un ego il responsabile primo e ultimo di qualsiasi idea. Se questo uomo pensa (hic homo intelligit, Tommaso) vuol dire che c’è sempre un soggetto sovrano del pensiero, e se il soggetto è sovrano del pensiero è anche sovrano e responsabile delle proprie azioni. Quando l’averroismo capovolgerà i termini di questa affermazione, sostenendo che homo non cogitat, sarà anche l’esigenza giuridica della filosofia medievale a esser messa in discussione – insieme a qualsiasi costruzione sociale. Esiste dunque un mondo e un modo – un’utopia? – in cui gli uomini possano stare insieme, che va al di là di qualsiasi legge e responsabilità?
15 – Mi pare che non ci sia molto scarto tra l’hic homo cogitat di Tommaso e il cogito cartesiano. Lei dice che invece “la prospettiva averroista sembra essere perfettamente inversa a quella cartesiana”, e cita Ibn Bagga, secondo il quale il regime politico compiuto perfetto è quello in cui è sospeso qualsiasi ordine giuridico, così come la sanità di un corpo coincide perfettamente con la sospensione di ogni pratica medica. La città perfetta non è quella in cui tutti rispettano le regole, ma quella in cui non c’è bisogno di regole, ovvero le regole sono solo immaginate o immaginabili?
16 – Attribuendo all’uomo un’autonoma produzione di pensiero, gli si attribuisce quindi un’autonomia di azione, un libero arbitrio: l’uomo è causa di una serie di eventi particolari, che lo rendono distante e diverso sia dalla natura che da Dio. Ci sono delle cose che accadono al di fuori della natura (che a questo punto diventa quasi un ingombro, un ostacolo) e, ovviamente, della divinità: queste cose sono le cose ragionevoli e sagge della prassi. La prassi, lei osserva, è insomma il modo specificamente umano in cui le cose accadono. Che fine ha fatto, in questo processo, l’uomo razionale – e, in quanto guidato dal senso comune, naturale – di cui ragionava Aristotele?
17 – Che senso ha “raccontare la propria esperienza”? Spesso, nei modi in cui intendiamo questa espressione, significa mettere in fila a scopo morale dei fatti realmente accaduti e collegati alla nostra individualità. Così il linguaggio viene dotato di una coscienza, ma perde ogni legame con la scienza, con la conoscenza collettiva. Oggi questo movimento mi sembra particolarmente accentuato dalla proliferazione di ego invadentissimi nel campo della cultura, ma anche in ambito sociale, politico, etc. Quando Benjamin parlava di perdita della capacità di raccontare collegata alla caduta dell’esperienza, alludeva forse a un processo del genere, in seguito al quale non capiamo più che, per conoscere il mondo, non basta “raccontare la propria esperienza” o avere buone intenzioni, ma bisogna mettersi in relazione con qualcosa che non ci appartiene, e che l’averroismo definiva pensiero materiale?
18 – Le panie soggettiviste in cui finiscono immancabilmente tutte le ambizioni e le teorie realistiche o psicologiche sono forse legate essenzialmente a un oblio della distanza – tutta sempre da percorrere – tra potenza e atto. L’attualità assoluta in cui viviamo oggi, il tempo reale che ci assilla, la ghettizzazione della fantasia (e la sua inerenza socio-culturale a campi limitati: l’infanzia, il gioco, lo spettacolo), non sono forse il sintomo di un oblio della potenza, ovvero di una profonda incapacità di colmare con la volatile immaginazione la distanza che ci separa e ci separerà sempre dall’eternità del pensiero?
19 – Lei dice che “il mito dell’interiorità non è in fondo che una conseguenza delle nozze illecite tra umanità e razionalità che la teologia non ha mai smesso di celebrare”. Poi aggiunge che nel mondo antico le cose stavano molto diversamente, in quanto la conoscenza veniva pensata sempre nei termini di una assoluta estraneità all’uomo come a tutti gli altri enti. Il “mito dell’interiorità” è dunque una creazione tutta moderna? Penso qui anche alle osservazioni di Benjamin nel frammento Il capitalismo come religione, citato da Agamben in Elogio della profanazione, in cui si dice che capitalismo e cristianesimo hanno cospirato affinché dio fosse interiorizzato dall’uomo attraverso una “mostruosa coscienza colpevole”, che a me allora sembra il parto infelice delle nozze illecite di cui sopra.

 Altri professori - Enrico De Vivo
Altri professori - Enrico De Vivo Smanie di conquista - Enrico De Vivo
Smanie di conquista - Enrico De Vivo Un altro Novellino/ 1 - Enrico De Vivo
Un altro Novellino/ 1 - Enrico De Vivo Saggi Inventati - Enrico De Vivo
Saggi Inventati - Enrico De Vivo Fine di amore
Fine di amore Carattere
Carattere Le parole, una polvere bianca
Le parole, una polvere bianca





















