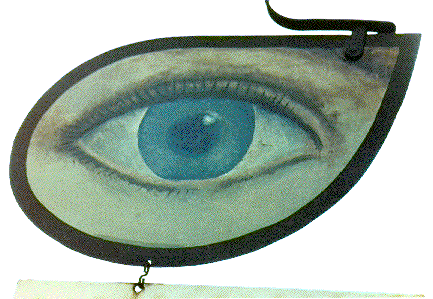
L’estate che ero a Villa Minozzo, in un minuscolo appartamento preso in affitto dal veterinario del paese, quando a ferragosto è venuto Vittore a trovarmi e abbiamo cominciato ad andare in giro, lui con la macchina fotografica, io con quaderno e matita, per esercitarci a osservare il mondo che avevamo attorno, fin dall’inizio cu siamo proposti di cercare un paesaggio terrestre, perché ci eravamo detti che la maggior parte degli uomini, quando guardano nella natura, hanno in fondo davanti a sé lo stesso paesaggio, almeno nelle sue linee essenziali. Sotto c’è la striscia verde e marrone (la terra) e sopra l’azzurro del cielo.
È chiaro che parlare di paesaggio terrestre può sembrare tautologico, perché ovviamente è l’unico paesaggio che possiamo conoscere, a meno di non abitare su Marte o sulla Luna. Ma assumere la coscienza di vivere in una dimensione “terrestre” può aiutare a superare certi limiti, ad esempio i confini dell’io, della vita di società, e di un’immaginazione sempre proiettata in qualche altrove, in mondi virtuali e spesso claustrofobici.
Prima ancora che un lavoro “artistico” la nostra ricerca la intendevamo come terapia, un modo per esercitarsi a non perdere la sensibilità a ciò che ci era attorno, e provare ad accorgersi ancora del vento, della pioggia, delle pietre e delle nuvole, dei cani, degli uomini. E l’intento era di vederli tutti in uno stesso orizzonte senza particolari distinzioni, come parti di un paesaggio rintracciabile in qualche luogo della Terra.
Tutto è partito dal territorio attorno al paese di Villa Minozzo, uno dei comuni più spopolati della provincia di Reggio Emilia ma anche uno dei comuni più vasti d’Italia, addirittura il più vasto fino a pochi anni fa, mi aveva detto Graziano che ricordava di averlo imparato a scuola. Qui la poca gente rimasta è sparsa in tante frazioni, e per vedere il paese affollato bisogna aspettare il giorno di mercato, quando la Dina al suo bar frigge il baccalà ma dopo una cert’ora, verso le undici, già non lo si trova più. Perciò, se proprio lo si vuol mangiare, bisogna aspettare un’altra settimana.
Fuori dai giorni di mercato non c’è mai tanta gente in giro, neanche d’estate perché i turisti non vengono e al massimo rientrano le famiglie che sono andate via e han tenuto la casa.
Il paese di Villa Minozzo non ha niente di pittoresco, non è il tipico paesino di montagna che sembra subito un presepe. Le case vecchie si mischiano a costruzioni più moderne in modo alquanto casuale, e dal giornalaio le uniche cartoline del paese sono vecchie foto in bianco e nero dove c’è sempre una seicento parcheggiata, di volta in volta, in una via del centro, poi davanti alla scuola media, e poi ancora accanto a un edificio appena fatto. Probabilmente era la macchina del fotografo che era andato in giro a fotografare il paese, e fra l’altro questa seicento è l’unica macchina che si vede in queste vecchie cartoline.
Insomma a Villa Minozzo non c’è niente e non si fa niente per attirare i turisti. Inoltre la terra che c’è intorno è stata per lo più abbandonata, e sulle montagne ci sono parecchie frane, come succede sempre quando si abbandona un territorio.
Prima che arrivasse Vittore non andavo tanto in giro. Stavo quasi sempre a lavorare nel mio appartamento d’affitto, due vani più il bagno, e ogni tanto uscivo per mangiare qualcosa dalla Dina o da Graziano, che ha un agriturismo appena fuori il paese.
Graziano lo conoscevo già da prima, quando faceva l’orologiaio e abitava a Reggio, in una vecchia casa del centro. Poi ha deciso di tornare al paese d’origine e aprire una piccola azienda agrituristica dove spesso trovano rifugio le persone più stravaganti della zona. Con loro Graziano ha formato anche un gruppo che si chiama Pericolo Giallo, e di tanto in tanto si esibiscono in qualche farsa recitando in ottave ariostesche, com’era nella tradizione dei maggi che si facevano sulle montagne per rievocare le gesta di antichi cavalieri. Loro non raccontano di cavalieri, preferiscono parlare di cose di attualità, ma uno di loro, Maurino, agli spettacoli si mette sempre il costume d’antico cavaliere e sguaina la spada sproloquiando al ritmo delle ottave e arrabbiandosi col mondo.
Le serate da Graziano a volte erano parecchio movimentate, ma per il resto vivevo nella quiete più assoluta. Anche ad andare in giro con Vittore, a fare i nostri esercizi di osservazione, non s’incontrava quasi mai nessuno. Inoltre in quei giorni che giravo con Vittore venivano sempre dei temporali,
come spesso capita dopo il ferragosto, e il tempo era continuamente incerto. Così a camminare sui prati uno s’infangava tutto, e anche alle Fonti di Poiano, dove prima si concentravano i pochi villeggianti che c’erano, anche lì non c’era quasi più nessuno, nessuno che si sdraiasse più sui prati o sopra i sassi a prendere il sole.
Le Fonti di Poiano sono state la prima tappa delle nostre esplorazioni attorno a Villa Minozzo. Era appena piovuto e mentre eravamo lì e camminavamo lungo il Secchia, in una bella vallata aperta, nel silenzio della natura è nato il proposito di cercare di definire un paesaggio terrestre, e l’idea che in fondo gli uomini vedono quasi tutti uno stesso paesaggio: la linea dell’orizzonte con sotto la striscia verde e marrone, e sopra l’azzurro del cielo. Per comporre l’immagine di un paesaggio terrestre bisognava saper combinare questi elementi, distribuirli bene nello spazio.
In questo le vallate dei fiumi hanno un vantaggio immediato. Il corso del fiume indirizza lo sguardo in una prospettiva all’infinito, e tutto sembra subito comporsi in qualcosa da contemplare, perché lo sguardo di focalizza nella fuga prospettica e i pensieri gli vanno dietro, correndo insieme a lui. E così ci si può scordare anche di sé e perdersi nella visione della natura sovrana, fin quasi a scomparire nel paesaggio, fino a diventare “una docile fibra dell’universo”, come diceva Ungaretti in una sua poesia sui fiumi.
Se ogni atto di contemplazione implica un annullamento di sé, un abbattimento delle difese dell’io, allora l’invenzione della prospettiva, che impone un punto di vista fermo, fisso, tutto concentrato su un punto di fuga, questa particolare visione può senz’altro favorire quell’immobilità che lievita nell’estasi contemplativa. E se organizzare la visione secondo rigide leggi prospettiche risulta spesso francamente impossibile, quando ci muoviamo nel mondo, se invece camminiamo lungo un fiume, con l’acqua che si perde in un punto imprecisato dell’orizzonte, si può avere davvero l’impressione che tutto converga nel punto dove il fiume prosegue la sua corsa, e i volumi dei colli, che lentamente digradano verso il corso dell’acqua, disegnano la scansione geometrica di questa profondità.
Quei giorni che andavamo in giro per le vallate attorno a Villa Minozzo, eravamo costantemente attratti dalle frane. Ce n0era una anche sul greto del Secchia vicino alle Fonti di Poiano, quasi completamente nascosta dalla vegetazione che cresceva lungo il fiume. Ogni frana era il segno tangibile della “terrestrità” di quel paesaggio, un nuovo ordine della natura che andava considerato, senza far troppo i conti con l’opera dell’uomo.
Di frane ne abbiamo incontrato anche andando in Val d’Asta, una delle vallate più spopolate della zona. Fra l’altro Graziano mi diceva che da tanti anni c’è pure un gruppo politico che lotta per l’autonomia di questa valle, vorrebbero una scissione dal comune di Villa Minozzo. Ma i secessionisti sono tutti troppo vecchi, diceva Graziano, non spaventano nessuno e si prendono sempre quei pochi voti alle elezioni, anzi, i voti diminuiscono sempre perché ogni tanto muore qualcuno.
Questo vuol dire che le frane sono il segno di una terra abbandonata, ed era in questo abbandono che volevamo concentrare la nostra attenzione. Volevamo cercare un ordine, per quanto possibile, nel disordine fangoso delle frane.
A un certo punto è sorta la domanda su quali fossero i segni “terrestri”. Ce lo siamo chiesti quando siamo tornati alle Fonti di Poiano e da lì abbiamo risalito il Secchia. A guardarci attorno, se non fosse stato per un ponte sullo sfondo poteva essere qualsiasi epoca, anche preistorica. E lì abbiamo trovato legni bruciati, sassi, acqua, piante selvatiche. Allora inoltre era estate e il fiume molto basso, così il greto era larghissimo e sui sassi si erano depositati tronchi e arbusti trascinati dall’acqua. Ogni tanto tracce di fuochi, perché era davvero un luogo idea per bivacchi, uno di quegli spazi che la Terra s’inventa e che sembrano immediatamente abitabili.
Andando avanti abbiamo anche trovato, all’imbocco di un sentiero, un piccolo cippo con la foto a colori di un uomo coi baffi. Non c’era nome, data, niente; non c’era scritto niente. C’erano solo dei fiori finti e polverosi appoggiati sopra. L’unica identità poteva essere data dalla foto di quell’uomo coi baffi, che però Vittore non ha voluto fotografare.
Sulla Gazzetta di Reggio del diciotto agosto c’era una notizia che ho voluto annotarmi, perché riguardava il territorio che andavamo esplorando e anche, con una strana coincidenza, il terreno della nostra ricerca. La notizia diceva che due persone, un vecchio contadino e un villeggiante, nella notte di ferragosto avevano visto un Ufo nel cielo di Ramiseto. Il giornale diceva che in montagna capita abbastanza spesso, l’ultima volta era stato un elettricista di Cervarezza, che in primavera aveva visto una navicella sul Ventasso. Per spiegare cosa aveva visto, il contadino di Ramiseto ha detto (parole del giornale): “Mentre viaggiava la coda si sbriciolava lasciando cadere pezzi infuocati nella zona di Castellaccio. Dalla finestra di casa mia, dove mi trovavo, ho avuto l’impressione che fosse caduto qualcosa di veramente strano sul Castellaccio”.
Dubito che il contadino si sia espresso proprio così, comunque un paio di giorni dopo siamo voluti partire anche noi alla volta del Castellaccio, perché ci avevano detto che da lì c’era pure un bel panorama e si chiamava così per le rovine di un castello. A Poiano abbiamo chiesto l’indicazione a un contadino, che ci ha detto di seguire una strada sterrata che passava dietro un cimitero. E poi, per sapere se valeva la pena andarci, gli ho chiesto anche se era bello, il Castellaccio. Al che lui i ha risposto: “A chi piace. A me non dice niente”.
Comunque la strada non l’abbiamo neanche trovata. All’unico cimitero che abbiamo visto c’era una carraia che poi s’interrompeva. E così scoraggiati, e non troppo curiosi, siamo ritornati indietro rinunciando all’Ufo.
C’era capitato altre volte di non riuscire a raggiungere dei luoghi seguendo le indicazioni di qualcuno. Non abbiamo trovato neanche la cava di ofiolite che ci aveva indicato Federico, un geologo amico di Graziano, un ragazzone grande e grosso che nel Pericolo Gallo si veste da chierichetto. Una sera ci aveva detto che dovevamo assolutamente andare alla cava perché l’ofiolite era una strana roccia porosa, grigiastra, e là sembrava di stare sulla Luna, su una luna grigia. Ma non so come neanche lì siamo riusciti ad arrivare.
Forse perché una mappa non è mai un territorio, come recita una celebre frase di Gregory Bateson, e noi non appartenevamo a quel territorio come Federico e Graziano, o il contadino di Poiano. Potevamo solo andare avanti e indietro col piacere di esplorare, perdersi, ogni tanto fermarsi attratti da qualcosa. E così un po’ alla volta ci costruivamo anche una mappa mentale fatta di immagini, persone, nomi di luoghi, pure di quelli mai visti come la cava di ofiolite o il Castellaccio che comunque, in virtù del loro nome, s’imprimevano nella memoria quasi come un’esperienza vissuta, un’immagine già vista.
Si sa che noi riusciamo a vedere soprattutto grazie alle parole, al linguaggio. Nominiamo le cose, per vederle. Ma la natura non ha bisogno di nomi, ha scritto qualcuno, le rocce non hanno bisogno della mia memoria. E poi una mappa, diceva Bateson, non è mai il territorio.
Quando da Cavola siamo scesi verso il greto del Secchia, dalle parti di un’industria di ceramiche che sta scavando un bel pezzo di montagna, abbiamo trovato lungo il fiume delle ferraglie abbandonate e arrugginite, forse servite per mettere in piedi la fabbrica. C’erano tralicci, una ruspa, silos e container, così arrugginiti che si mimetizzavano bene con la natura intorno. Perché la ruggine aveva colorato le ferraglie di verde, marrone,
giallo: i colori terrestri.
La sera chiacchierando con Vittore è saltata fuori l’idea che oggi per vedere Pompei, così come potrebbe averla vista un viaggiatore del ‘700, bisogna andare a scovare vecchie fabbriche in rovina, ferraglie abbandonate. Perché l’archeologia strappa inevitabilmente alla natura i reperti del passato, natura a cui sarebbero destinati come qualsiasi altra cosa, e li sottrae così al loro destino di cose, materia.
Ricordo che da bambino le visite al museo non mi facevano entrare mai in nessuna memoria. Una memoria l’ho invece scoperta la volta che ero andato con un amico nella vecchia e cadente fabbrica della Montecatini, appena fuori città. Girando in mezzo a quelle rovine annusavo il passato, che mi appariva come un groviglio oscuro e inesplicabile, immerso in un grande silenzio. Non era più come andare a casa di qualcuno, come potevo credere entrando in un museo. C’era un disordine che affascinava e impauriva, e che comunque mi faceva sentire diverso, in un’altra dimensione.
Le rovine, le cose abbandonate a sé, ci aiutano ad uscire da un tempo sempre preso da scadenze immediate, da una quotidianità tiranneggiata dalle notizie che vogliono scandirci il passare dei giorni e le stagioni. Perché riconoscere la sovranità della natura, che domina pure sui manufatti dell’uomo, vuol dire entrare in un tempo più lungo, che la nostra civiltà non sa più considerare.
A questo proposito il filosofo Michel Serres dice che questo tempo lungo è scomparso con la scomparsa, o rimozione, di una memoria legata a chi viveva all’aperto, immerso nel tempo esterno delle intemperie, come ilo contadino o il marinaio. La scomparsa di questa memoria produce, per Serres, effetti ben più nocivi e incalcolabili dell’inquinamento che già infliggiamo all’aria, la terra, l’acqua. Anche perché la cosiddetta globalizzazione, progettata nel chiuso degli uffici del Potere, si è dimostrata assolutamente incapace, come si sa, di considerare il Pianeta Terra, quando invece un contadino sapeva bene di dover fare sempre i conti con la sua terra, ed era la terra che era a lui sovrana, perché sapeva di non poter vivere senza di essa.
Sono considerazioni quasi ovvie, ma è molto efficace e profondo il modo in cui Michel Serres riesce a formularle: “Se esiste un inquinamento materiale, tecnico e industriale, che espone il tempo, quello della pioggia e del vento, a rischi concepibili, ne esiste un altro, invisibile, che mette in pericolo il tempo che passa e trascorre, un inquinamento culturale che abbiamo inflitto ai pensieri lunghi, autentici guardiani della Terra, degli uomini e della cose stesse”.
Stare nel tempo atmosferico, nella pioggia che cade e nel vento che soffia, è sempre un modo per sfiorare anche la memoria di un tempo più lungo, che forse un tempo era patrimonio culturale di contadini e marinai, e che è il tempo del tempo che passa e che può abitare solo la natura.
Al bar di Sbologno abbiamo trovato un calendario del ’95 con le immagini del fotografo svizzero Schuermeier, che intorno agli anni venti aveva girato a lungo per queste montagne. In una foto del calendario era ritratta la famiglia del nonno del padrone del bar. E il barista ci aveva spiegato che il telaio che si vedeva nella foto era nella stanza accanto al bar, perché quella era appunto la sua casa di famiglia, e solo dopo la guerra ci aveva fatto l’osteria.
Ad andare nei bar di queste minuscole frazioni, e ad abbandonarsi al ritmo lento dei gesti del barista, degli uomini che giocano a carte tutto il pomeriggio, stando lì è facile ascoltare ancora memorie lontane, come al bar di Carù dove il vecchio barista ci ha raccontato della guerra, di quando su quelle quattro case avevano buttato due bombe enormi. Diceva che costavano più le bombe delle case bombardate e ricordava che per terra una bomba aveva fatto un buco di 11 metri di diametro e 11 di profondità.
Nelle periferie del mondo la memoria di un tempo lungo, fuori dal tempo delle notizie, sembra ancora miracolosamente esistere, sopravvissuta nel piacere di perdersi ancora nel tempo di un racconto.
Una tappa obbligata delle nostre perlustrazioni è stato il Lago Calamone, al Monte Ventasso, uno dei luoghi più conosciuti della zona, meta anche di campeggi e scampagnate. Quando ci siamo arrivati stava scendendo la sera, e l’acqua stagnante del lago rifletteva un cielo plumbeo. In giro non c’era quasi nessuno, solo il vociare indistinto di una famiglia che raccoglieva i resti di un picnic. Tutto il resto era fermo, immobile, e avevano steso anche dei sacchi di iuta perché il terriccio non smottasse nell’acqua.
Ricordo che l’amico poeta Vince Fasciani, che è nato sul lago maggiore e da tanti anni abita a Ginevra, sul lago Lemano, aveva scritto una volta che il colore del lago è il colore dell’acqua morta, perché non c’è l’energia viva che si vede nel mare, nei fiumi che corrono. E io stesso, quando ho abitato per più di un anno sulle rive di un lago, a Zurigo, mi sono sentito a volte stregato da una stagnazione luttuosa, funebre, quasi fosse un miraggio lacustre, e quando volevo mettere in moto i pensiero preferivo passeggiare lungo il Limmat, il fiume che sfocia nel lago proprio a Zurigo, in centro, e così mi dirigevo fuori dalla città per ritrovare l’energia di un fiume e rinfrescarmi i pensieri.
Il lago però aiuta a fermarsi, quando c’è bisogno di farlo, e ritrovare così la quiete che possono dare anche i cimiteri di campagna. Perché i laghi hanno sempre una loro calma cimiteriale, e i rumori, attutiti dall’acqua, sembrano rispettare la consegna di un silenzio meditabondo, malinconico.
Che il lago sia un luogo di pace lo testimonia perfettamente Robert Walser, che spesso terminava le sue passeggiate in riva a un lago, meglio se un laghetto apparso quasi all’improvviso, inatteso, dove potere finalmente risposarsi. Se i suoi vagabondaggi finivano sempre per avere un andamento ascensionale, fino a un progressivo annullamento di sé, fino ad arrivare a un’assoluta vaghezza, il lago diventava allora la meta ideale, il luogo dove concludere una passeggiata e immergersi nella luminosità stessa del cielo. Perché il lago è sempre anche un riflesso del cielo, con cui si confonde.
Quando arriva sul Greeifensee, un laghetto a pochi chilometri da Zurigo, Walser dice che “è lago, e bosco che lo cinge; è cielo ma di un azzurro così tenero e un po’ offuscato; è acqua, ma acqua così simile al cielo che può essere soltanto il cielo e questo soltanto acqua azzurra; è dolce azzurra calda quiete”.
I primi mesi che ero a Zurigo abitavo in una casa su una collina da cui si poteva vedere il lago. Ricordo che nelle giornate piene di luce a stare in soggiorno, dove c’era una grande vetrata, era come avere in faccia il riverbero di un’enorme stagnola. Di notte le luci della città si specchiavano ai margini dio un enorme cratere nero.
Allora leggevo spesso racconti di fantascienza, e il lago era il mio Ufo, o meglio uno di quei posti dove il protagonista di una storia si trova capitato per caso, ma c’è una calma artificiale che lo inquieta, preludio di sciagure future. A volte la quiete può giocare brutti scherzi, far sognare mostri e catastrofi (e forse non è un caso che Frankenstein sia stato concepito e scritto sulle rive del lago di Ginevra, o che esista la leggenda del mostro di Loch Ness).
Ma per tornare al tempo più naturale delle storie, al tempo lungo dei racconti, erano le serate da Graziano a offrire le migliori occasioni per ascoltare storie, o antiche memorie che giravano per il paese.
C’erano spesso storie di persone conosciute ormai scomparse, come quella di “Mao”, soprannominato così per le sue idee politiche, che da bambino Graziano ricordava di aver conosciuto personalmente. Questo “Mao” era un tipo grande e grosso, e Graziano aveva sentito dire che da giovane aveva fatto il “passatore”, cioè di mestiere, visto che era molto robusto, traghettava sulle spalle la gente che voleva oltrepassare il Secchiello, il torrente che si getta sul Secchia e che passa vicino al paese. Questo “Mao” non aveva tanta paura di usare le mani, se occorreva, perché non aveva neanche paura di finire in galera perché in galera c’era già stato, non si sa bene per cosa, ma a volte la gente si divertiva a stuzzicarlo, per vedere come reagiva.
E poi naturalmente c’era la storia dell’anarchico Zambonini, che fra l’altro è ricordato ancora da una lapide abusiva nella piazza del paese, messa su qualche anno fa da Graziano e i suoi amici del Pericolo Giallo durante un’occupazione del municipio, fatta per protestare che Zambonini comparisse in piazza solo nell’elenco dei civili caduti in guerra, come se fosse morto per caso sotto le bombe, o in un rastrellamento. Invece i fascisti erano andati a prenderlo a casa sua e lo avevano fucilato in quanto anarchico. Ma questo Zambonini, proprio perché anarchico, solitario, non figurava tra gli arruolati nelle bande partigiane, e così il comune lo aveva messo tra i civili.
Di mestiere Zambonini faceva il mulattiere, cioè guidava dei muli che servivano a portare dei pesi, per chi ne avesse bisogno. E una volta aveva aiutato il prete a traslocare e quella volta s’era cercato di trattenere dal bestemmiare, cosa che faceva abitualmente, perché aveva rispetto del suo cliente. Ma quando a un certo punto i suoi muli si erano fermati e non c’era più verso di farli andare avanti, Zambonini
dopo un po’ aveva perso la pazienza, raccontava chi c’era, e allora ha tirato qualche bestemmia e i muli sono subito ripartiti. Perché finalmente i muli avevano riconosciuto la voce del loro padrone.
Da Graziano c’era sempre il cane Luigi, che aveva una strana mania per i sassi. Un sasso poteva stare a fissarlo per delle ore, in attesa che qualcuno glielo lanciasse. Poi lo riportava indietro e si rimetteva a guardalo finché non gli veniva rilanciato di nuovo.
Le famiglie e le razze nella natura si mischiano sempre, non esistono pregiudizi o pulizie etniche. Si possono anche intrecciare misteriose relazioni, come quella che legava Zambonini ai suoi muli, o il cane di Graziano ai suoi sassi.
Un amico fra l’altro mi ha detto che in non so quale cultura i cani sono considerati psicopompi, cioè conduttori d’anime. E allora, guardando il cane che guardava i sassi, mi piaceva ricordare un amico ormai scomparso, che si chiamava proprio come il cane di Graziano, e che è la persona a cui devo la maggior parte dei pensieri che qui cerco di tirar fuori, e a cui devo fra l’altro l’amicizia con Vittore, visto che ci siamo conosciuti grazie a lui.
Comunque quest’amico, facendo una volta il gioco di chi si vorrebbe essere se non si fosse uomini, aveva detto che a lui sarebbe piaciuto essere un sasso, una pietra, e star lì immobile nel tempo. Anche lui naturalmente intendeva sia il tempo che passa che quello atmosferico, perché tutto quello ha fatto è un insegnamento a considerarli entrambi.
Così ripensando all’amico guardavo con maggior simpatia anche il cane Luigi, m’immaginavo che il cane psicopompo, e l’amico che non c’era più, vivessero davvero nell’anima dei sassi e delle pietre, e nel tempo che non finisce mai e che ci porta il vento, la pioggia che cade.
Essere in un paesaggio terrestre vuol dire allora abitare anche la materialità delle cose, essere nella pesantezza del mondo. Così andavano bene le frane, i sassi, il fango, la terra, i legni bruciati. Ma era paesaggio terrestre pure il mio appartamento ammobiliato con la tivù in bianco e nero sopra il frigo, e alle pareti una madonna e la stampa col fiume e le montagne, il velluto marrone della poltrona, la bombola del gas. Anche quella era terra.
Ricordo che ogni volta che il frigo s’accendeva o spegneva scuoteva anche la vecchia tivù a valvole abbassandole il volume, e mi veniva in mente quel celebre detto sul battito d’ali di una farfalla che poi diventa un uragano. Il vantaggio di quell’appartamentino ammobiliato era che le macchine della casa erano tutte vecchie e si concentravano in pochi punti. Era un ecosistema semplice, e mi sembrava di non aver bisogno d’altro.

 La letteratura, il gioco, i bambini - Enrico De Vivo
La letteratura, il gioco, i bambini - Enrico De Vivo La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori
La via di Petrarca/ 1 - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 1 - Giorgio Messori Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori
Piccolo tributo a un posto in cui mi è capitato di vivere/ 2 - Giorgio Messori La via di Petrarca/ 2
La via di Petrarca/ 2 Finestre in Engadina
Finestre in Engadina Non è ancora buio
Non è ancora buio





















