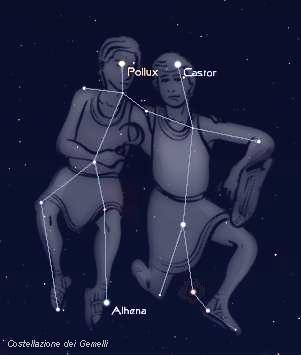
Un romanzo familiare che, via via, da storia di esistenze individuali, si trasforma in un affresco dell’esistenza in quanto tale, dell’esistenza nella quale respirano i viventi e le cose, la terra e i suoi colori. Nella storia di due fratelli, nel loro legame fatto di reciproca amara sorveglianza, di distanza sofferta e insieme perseguita, si disegna la linea della vita stessa. È, si potrebbe dire, il vento della vita che si fa scrittura, si fa narrazione, e attraverso le voci dei personaggi e le situazioni mette in scena una meditazione sull’esistenza: la curva del tempo che lacera e consuma, il rito delle partenze e degli arrivi, la presenza di un altrove che è richiamo ma anche disincanto, la ferita di conflitti e di offese non risarcibili, la memoria che l’irreversibilità del tempo rende aspra. Due fratelli del brasiliano Milton Hatoum (Marco Tropea editore, 2005) riprende il tema classico, e perturbante, della fraternità gemellare, della sua proiezione nella fantasmatica del doppio. Un tema che il narratore svolge secondo un’invenzione insieme calda e amara, affidando all’antico motivo il compito di dire qualcosa su ciò che unendo separa, sulla prossimità che si fa lontananza, sul legame che si rovescia in odio. È l’altra faccia dell’agnizione classica, plautina: la distanza tra i due fratelli è una malattia che non ha alcuna remissione, si approfondisce, si fa invasiva, invasiva dei pensieri, della vita stessa.
Un’aggressione da adolescenti, un gesto di gelosia amorosa, è l’offesa originaria. Che non troverà mai rimedio. Omar e Yakub sono i due fratelli, figli gemelli di Zana e Halim, libanesi emigrati in Brasile. Omar è ombroso, fragile, abitato da una disperazione che si fa eccesso, fuga, violenza, visitato talvolta da una tenerezza filiale che non trova le sue vie. Yakub, l’offeso, è lucidissimo ed enigmatico, attivo e riuscito negli studi, si trasforma in vendicatore sottile, ordinato, perverso: cinque anni passati in Libano, quasi in una sorta di esilio nella terra d’origine paterna e materna, non hanno lenito la ferita. L ’integrazione sociale e professionale di Yakub è assillata dall’impossibilià del perdono, la deriva di Omar è inarrestabile, ed è a un certo punto sfiorata dalla ribellione, anche politica, pur nella scompostezza e nella degradazione.
È Manaus, la città lambita dal rio Negro, prima che questo si riversi nel rio delle Amazzoni, il teatro animatissimo di questa storia. Una storia che ha qualcosa del teatro tragico e qualcosa dell’epica moderna, faulkneriana, dei suoi tempi immobili, dei suoi gesti sospesi nel tempo-spazio della coscienza. E si sente il confine con la grande foresta. Fascinazione dei porti fluviali, ma anche inquietante affollarsi di figure bizzarre e perdute, di sinistri trafficanti, di mercanti e speculatori. Il mondo di Álvaro Mutis e di García Márquez riaffiora, ma reso come limpido, essenziale, e calato su uno sfondo dove il tragico ha radice nei corpi, nella loro singolarità, nella loro impossibile relazione.
Quando il lettore è preso dal gioco intimo e perverso dei due fratelli s’accorge che c’è un altro personaggio che riempie la scena, ed è la città di Manaus – la città stessa di Milton Hatoum – con il molo Escadaria, la praça de Saudade, la rua dos Barés, il mercato, i venditori ambulanti, e soprattutto gli odori forti e i sapori della terra amazzonica affiancati o mescolati agli odori e ai sapori di cibi e bevande che vengono dalla tradizione libanese. Il lessico che nomina spezie, pesci, zuppe, bevande alcoliche, dai suoni dolci e invitanti, racconta l’incontro di due lingue, araba e portoghese-brasiliana, che è incontro di percezioni, di ricordi, di abitudini. L’incontro antropologico tra due culture allude a una possibilità ulteriore, difficile, negata, e tuttavia cercata: la possibilità di una armonia nella pluralità. Cosa che potrebbe accadere se tutti i sensi dell’individuo partecipassero in profondità al riconoscimento dell’altro. Perché questo bellissimo romanzo è anche un romanzo sui rapporti tra le culture, sulla migrazione e i suoi lasciti, sullo specchiarsi di due mondi di povertà e sul loro difficile confronto, sulla loro contrastata tensione verso una plurale armonia.
Lo slittamento del personaggio centrale in un altro personaggio è forse l’aspetto formalmente più avvincente del racconto. Perché il lettore può leggere la storia a partire da un singolo punto d’osservazione coincidente col singolo personaggio. Così tutte le figure contribuiscono a definire il clima e il sapore della narrazione. A partire dal personaggio narrante, Nael, voce che vive nel cuore della storia stessa, cresce con essa, d’essa coglie velature e non detto: è in mezzo tra lo sguardo della madre, Domingas, domestica indigena arrivata orfana nella famiglia, col suo carico di storie dolorose e di favolosi incantamenti, e lo sguardo curioso di chi viene dopo, e allo stesso tempo sa di avere come padre uno dei due fratelli, enigma non rivelato, fonte di interrogativi, fonte di una mobilità inquieta dello sguardo stesso. La grande casa, col giardino e le amache e il portico e, dinanzi, la strada in discesa ombreggiata dai manghi centenari, è l’altro spazio scenico che accoglie questo incrocio di destini.
La casa che apre e chiude, con la tristezza di un abbandono, il racconto. Zana, la madre, nata a Biblos in Libano, è della casa, e del legame tra i due mondi, la vera custode, e ha spesso i tratti mediterranei della mater dolorosa. Come Halim, il marito, ha l’ardore e la fierezza e l’espansiva gioiosa ospitalità propria della sua origine. Altre figure popolano il romanzo. Tra queste, la sorella Rânia , sulla cui bellezza precipita implacabile l’erosione della vita. E Abbas, il poeta autore di gazal – poesie d’amore della tradizione araba in quindici distici – che è all’origine dell’incontro amoroso di Halim e Zana. La poesia d’amore, sembra dire una sotterranea vena utopica, è ciò che resiste nell’altrove, e rende fecondo ogni incontro. Il sorriso della lingua che trascorre sotto l’amarezza dei destini.

 Arianna - Antonio Prete
Arianna - Antonio Prete I classici e la barbarie - Antonio Prete
I classici e la barbarie - Antonio Prete Passeggiata a Torre Sant’Emiliano - Gianluca Virgilio
Passeggiata a Torre Sant’Emiliano - Gianluca Virgilio Sartre, la passione della critica - Antonio Prete
Sartre, la passione della critica - Antonio Prete Don Chisciotte
Don Chisciotte Chirografie
Chirografie Luna nera
Luna nera





















