
L’ultima volta che ho visto Wolfgang Hilbig, alla fine di marzo di quest’anno, mentre mi parlava della diagnosi dei medici sedevo senza parole di fronte a lui. Era, come si suol dire, segnato dalla malattia e probabilmente il suo peso era ormai dimezzato rispetto a un tempo. Benché avesse le vertigini, un effetto della chemioterapia, cui si era sottoposto contro il consiglio dei medici, parlava come per rasserenarmi. “Mi hanno detto che adesso posso fumare quanto voglio”. Descriveva scene d’ospedale come se le leggesse ad alta voce dai suoi libri. “Mah, sai”, disse e sorrise, “la prendo con molta tranquillità”. Bisogna immaginarsi queste frasi nel dialetto sassone di Meuselwitz, e soprattutto la pronuncia infinitamente allungata della parola “cool” con cui indicava la tranquillità. “La prendo sportivamente”, disse il pugile con l’osso nasale rotto e, come leggendo ad alta voce, intonò la penultima sillaba molto acuta, come se ogni frase dovesse trascinarne un’altra dopo di sé. Non riusciva ad immaginarsi di morire. Si dava ancora dieci anni. Non so se ci credesse veramente. Ma c’era almeno da credere che esprimesse questa prognosi anche per amore del suo interlocutore, che ora – davanti a dieci anni d’avvenire – ritrovò la lingua e gli chiese se e cosa avesse scritto nell’ultimo periodo.
“Storie di fantasmi”, disse lui, “scrivo storie di fantasmi”.
“Storie di fantasmi?”. Ma in quello stesso momento trovai la sua risposta perfettamente plausibile e perfino conseguente. Ognuno dei suoi libri mi era sempre sembrato l’ultimo, perché credevo che non potessero essere superati nella loro radicalità, che lui stesso sarebbe potuto riuscirci solo con difficoltà. Cosa doveva venire dopo Le femmine, cosa dopo Vecchio scorticatoio, cosa dopo Io, cosa dopo Soluzione provvisoria? E tuttavia ad ogni nuovo libro comprendevo che esso era già presente in nuce in quello che lo aveva preceduto. Parlammo, alla fine soltanto in poche frasi, dei sentieri che conducevano a queste storie di fantasmi – e riportavano anche indietro. Venne fuori il nome del suo protettore e amico Franz Fühmann, che con il saggio L’elemento mitico nella letteratura ha scritto un testo poetologico fondamentale non solo per Wolfgang Hilbig. E da Fühmann una strada conduceva anche a E.T.A. Hoffmann, che tra i Romantici, così importanti per Wolfgang Hilbig, fu certo quello a cui lui era più legato. E io citai fedelmente quello che Wolfgang Hilbig aveva già scritto negli anni settanta in prose e saggi, e cioè che nella classe operaia la convinzione che esistessero i fantasmi era forse più diffusa della coscienza di classe, e che con la mitologia religiosa sorge anche la fede nell’esistenza dei fantasmi. “Hai letto quelle cose?”, chiese lui, come se il fatto lo sorprendesse. Rise, tossì a lungo, si accese una nuova sigaretta. “La letteratura che si è rifiutata di servire la distrazione è stata punita sul mercato con l’indifferenza…”, si legge da qualche parte in Soluzione provvisoria.
Il cancro era nelle ossa, mi spiegò. Gli faceva piacere che adesso venisse qualcuno due volte al giorno a portargli i medicamenti. Si sentiva accudito. E di sera veniva spesso C. Dormiva molto, ma una volta finita la chemio sarebbe anche tornato a fare qualcosa… Poesie magari. “La prendo sportivamente”. Dovetti pensare alla sequenza d’apertura di Soluzione provvisoria, all’incontro di boxe con il manichino: “Un momento dopo si stupì di come i suoi istinti funzionassero ancora magnificamente. La sinistra gli partì automatica dall’anca, scavalcò il braccio minacciosamente alzato e colpì secco un angolo del mento prima ancora che fosse entrato nel suo campo visivo…”.
Per Wolfgang Hilbig è difficile parlare di un opus magnum. Si tratti delle prime o delle ultime poesie, delle prime prose brevi, dei suoi romanzi, dei racconti. “In realtà tutto in lui è buono”. Credo che Soluzione provvisoria sia il più importante libro tedesco degli ultimi vent’anni. In epigrafe al testo ci sono due citazioni, la prima di Strindberg : “Per poter scrivere le mie opere ho sacrificato la mia biografia, la mia persona. In effetti ho avuto molto presto l’impressione che la mia vita fosse strutturata in scene, affinché la potessi vedere da tutti i lati. Questo fatto mi riconciliò con la sfortuna e m’insegnò ad intendere me stesso come oggetto”. La seconda è di Nicolás Davila ed è affine alla prima: “Io avanzo nelle tenebre. Ma mi guida il profumo della ginestra”.
La franchezza con cui Hilbig opera contro di sé come autore è qualcosa che toglie il respiro. Ma è solo al prezzo di questa franchezza che è finalmente possibile trovare una via d’uscita attraverso la cruna d’ago del materiale autobiografico, verso un significato aperto agli altri. In Hilbig convivono sempre i due aspetti dell’orrore e della bellezza. Lui, l’utensilista e il fuochista di caldaie di Meuselwitz, il cui padre cadde a Stalingrado, il cui nonno era analfabeta, che come lavoratore e scrittore prese in parola la DDR e finì così, volente o nolente, per dimostrarne l’assurdità, smuove i sedimenti della propria anima e della nostra società. Per poter sopportare una simile impresa, egli deve renderne conto in un linguaggio che ha come punti di riferimento i Romantici tedeschi e (soprattutto) William Faulkner, e che sviluppa una magia alla quale nessuno che non sia duro d’orecchio può sottrarsi.
Al momento di congedarci avrei voluto disporre di un’espressione che riassumesse tutto ciò che vedevo in lui e quello che lui significava per me. Invece lui mi diede degli affettuosi colpetti sulla pancia in segno di saluto e disse: “Anch’io una volta avevo una pancia così bella, ora purtroppo è sparita”. Rise, e risi anch’io. Nella speranza di rivederlo, scrissi un discorso da tenere di lì a poco in occasione di una sua premiazione; per il titolo presi in prestito le ultime parole di Vecchio scorticatoio: “Il luogo dove pascolano i minotauri”.
Il mio dialogo a quattr’occhi con il minotauro, di cui mi ero ardentemente augurato che Wolfgang Hilbig potesse essere testimone, si svolse già senza di lui. Al più tardi in quel momento fu chiaro quanto brevi sarebbero stati i dieci anni. Quel pomeriggio al Peter-Huchel-Haus di Potsdam, però, un amico che ancora due settimane prima era stato con Wolfgang Hilbig ad un concerto di Bob Dylan mi raccontò come il poeta Hilbig fosse balzato all’improvviso dal suo posto e con un urlo avesse sollevato il pugno destro. Quello, disse l’amico, fu il suo congedo da Bob Dylan. Io credo che sia stato il suo congedo e basta. Ho questa scena davanti agli occhi come se l’avessi vissuta io stesso, un gesto e un urlo di quest’uomo di sessantacinque anni – e in quel momento seppi anche l’espressione che avrebbe detto ciò che vedevo in lui, perché solo lui, Wolfgang Hilbig, poteva riempire di dignità e grandezza quest’espressione dubbia e deturpata fino al ridicolo: Wolfgang Hilbig, tu sei il campione!

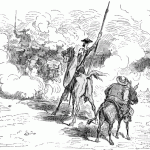 Double face. Note a cura dell’autore - Ingo Schulze
Double face. Note a cura dell’autore - Ingo Schulze Due vite - Ingo Schulze e Christine Traber
Due vite - Ingo Schulze e Christine Traber





















