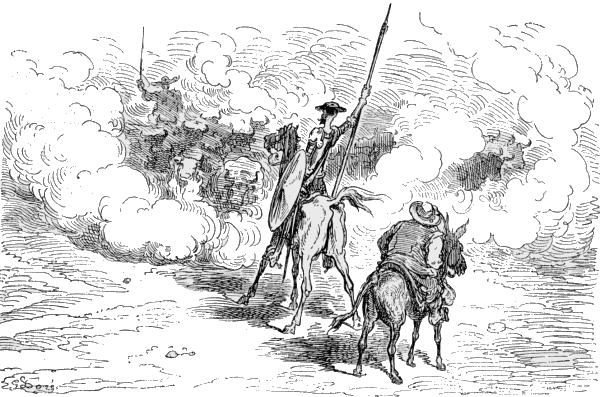
Nell’aprile 1997, poco meno di un anno prima dell’apparizione di Semplici storie, dovetti tenere in qualità di ex-borsista un discorso per il conferimento del premio Alfred Döblin. Alla vigilia della conferenza trovai nell’opera omnia di Döblin la frase alla quale il mio discorso finì per approdare. Nell’Epilogo del 1948 egli scrive: «Inoltre ogni libro aveva il suo stile, che non veniva gettato dall’esterno sul tema in questione. Non avevo un mio ‘proprio’ stile, da portarmi in giro una volta per tutte come il ‘mio’ (“Lo stile è l’uomo”), bensì lasciavo che lo stile sortisse dalla materia». Nel manoscritto si legge anche: «[…] ero attento a far sì che lo stile sortisse dalla materia».
Avevo trovato in Alfred Döblin un patrono letterario. Grazie a lui compresi meglio la mia stessa scrittura. Anche per me si tratta di trovare di volta in volta lo stile adeguato.
L’idea di scrivere una novella sui miei anni scolastici nella RDT la ebbi quando Semplici storie era ancora in fase di editing. Per quanto amassi la short story, anelavo a un cambiamento, a frasi più lunghe, similitudini, descrizioni.
I modelli non dovetti cercarli a lungo. Li trovai in libri molto diversi fra loro come Tonio Kröger di Thomas Mann, I turbamenti dell’allievo Törless di Robert Musil o nelle novelle di Stefan Zweig. Essi mi apparvero adeguati da un lato perché la Dresda che avevo conosciuto io, nelle sue maniere e in tutta la sua cultura, era molto tradizionale e borghese, di una ‘borghesità’ che nella RDT avevo sentito come qualcosa di opposto alla mia condizione. Dall’altro speravo di raggiungere un effetto di straniamento se questo tono ‘tardoborghese’ fosse entrato in collisione con la quotidianità scolastica del socialismo reale.
Scrissi il primo capitolo di questa novella mentre ero in viaggio per le letture pubbliche diSemplici storie e credevo – la trama e il finale li avevo ben chiari – che avrei ultimato il manoscritto entro l’autunno, così l’anno successivo avrei già potuto presentare un nuovo libro.
Tuttavia, per quanto chiaro mi apparisse il contenuto, la novella non riuscivo a scriverla. Già con il secondo capitolo smarrii il tono. Invece di descrivere la pubertà, suonavo io stesso puerile. E mi accorsi che anche il primo capitolo non era immune da questo difetto. Era una situazione analoga a quella dopo il mio primo libro – come se da un giorno all’altro avessi disimparato a scrivere.
Per quei tentativi non mi viene in mente nessun attributo migliore di ‘postdissidenti’. Ancora una volta davo un calcio alla defunta RDT, senza rischiare niente. Da cosa avrei potuto riconoscere, come lettore, che questa novella era stata scritta solo nel 1998/99 e non prima della caduta del Muro? Che cosa aveva a che fare tutto ciò con il nostro qui e ora?
Per dire qualcosa a proposito dell’est, dovevo scrivere anche dell’ovest. L’uno era comprensibile solo attraverso l’altro. Soltanto quando avessi confrontato la mia quotidianità scolastica con il mondo in cui vivevamo dal 1990, solo allora forse la novella sarebbe stata possibile.
Per capire che non potevo scrivere semplicemente sulla RDT mi ci volle un anno. La ricerca della struttura definitiva del libro mi occupò fino agli ultimi mesi di un lavoro che si protrasse per oltre sette anni.
È difficile dire come nascono le idee. È più semplice dare un nome agli stimoli. Senza leConsiderazioni filosofiche del gatto Murr con biografia frammentaria del direttore d’orchestra Johannes Kreisler su fogli di minuta casualmente inseriti. A cura di E.T.A. Hoffmann, probabilmente Vite nuove. La giovinezza di Enrico Türmer in lettere e in prosa, curate, commentate e corredate da una prefazione di Ingo Schulze non sarebbe così com’è. In Hoffmann ci sono due vicende biografiche, quella del gatto, meschino e conformista, e quella dell’artista Kreisler, che si incontrano in modo apparentemente improvviso. Come stimolo durante la lettura emerse poi il fatto di impiegare ogni giorno il retro bianco delle versioni stampate dei miei manoscritti per qualsiasi cosa, anche per schizzare delle lettere.
Quando mi fu chiaro che quello che volevo era raccontare sul retro della mia novella la storia dell’89/90 in forma epistolare, credetti di poter cominciare a scrivere.
Fino ad allora avevo sempre preso le mosse da una costellazione, da una frase, da una situazione, e i personaggi si erano resi riconoscibili durante la scrittura. Al terzo libro era esattamente il contrario: se volevo scrivere anche una sola frase, dovevo prima farmi chiarezza sui personaggi, soprattutto sul protagonista. Come vedeva il mondo Enrico e come lo vede Heinrich Türmer – che germanizza il proprio nome all’inizio degli anni novanta –, e quali sono le sue ragioni?
Perché scrive, a chi e a quanti scrive, che cosa scrive a chi? Solo sei mesi prima della pubblicazione del libro trovai ciò che sembra evidente, e cioè la sua struttura circolare, o meglio: la struttura pseudocircolare. Türmer narra la sua vita fino ai primi giorni di gennaio dell’anno 1990, gli stessi in cui comincia a scrivere le lettere. Questo significa che l’episodio descritto nella prima lettera (a Vera) è narrato un’altra volta – in un’altra chiave di lettura – nell’ultima lettera (a Nicoletta). Solo con l’ultima lettera veniamo a sapere in quale situazione si trovava Türmer quando scrisse la prima.
Le difficoltà che ho quando devo dare informazioni su Vite nuove corrispondono alle difficoltà che ho avuto con la scrittura. Il fatto è che per le azioni e le opinioni di Türmer, per il suo punto di vista sul mondo, non c’è mai una sola motivazione. Esistono sempre più chiavi di lettura, che a volte si contraddicono o addirittura si escludono.
Ursula März ha scritto in una recensione che Vite nuove è basato sul «principio della giacca double-face». La giacca double-face «non ha un lato interno e uno esterno, ma semplicemente due lati con pari diritti, indossabili all’esterno, che si possono portare alternatamente secondo l’occasione e le condizioni atmosferiche». E ancora: «Un libro in cui tutto, davvero tutto ha due lati e consente due letture; […] Lo si può intendere come una cronaca attendibile di avvenimenti storici e biografici. E come costruzione di un’enorme macchina cianciante, di cui non credere a una sola frase, perché ognuna è strumento di un’astuta manipolazione».
A volte è una liberazione quando leggo frasi che mostrano il mio lavoro nella luce in cui gradirei vederlo, senza che io sappia formularlo allo stesso modo. E se sapessi farlo, allora esprimerei unicamente una speranza, un desiderio. Fare una citazione da Vite nuove è impossibile.
Bisognerebbe subito aggiungere che questa è solamente l’opinione del protagonista, che però persegue questo e quell’intento, ad altri ha detto cose diverse e magari è pure contraddetto dal curatore del volume.
Già nei primi due libri era stato importante per me lanciare il segnale: questa storia posso scriverla anche in un altro modo. Come nei 33 attimi di felicità gli stili si relativizzano l’uno rispetto all’altro, così le rubriche sotto i titoli dei capitoli in Semplici storie erano pensate come ostacoli all’immedesimazione. Dovevano anche significare: qui c’è uno che fa short story. La struttura di Vite nuove è dovuta a sua volta a uno sforzo di epicizzazione.
Naturalmente la carriera di Türmer, così come lui stesso la presenta, si potrebbe descrivere come un’evoluzione dallo scrittore infelice all’uomo d’affari felice. Türmer afferma di essere felice, perché si è finalmente lasciato alle spalle la ricerca di gloria e di eternità, e ora si sente libero per la vita attiva e il godimento dell’attimo. Ma chi produce così tante lettere nell’arco di mezz’anno non può essere uno che ha appeso al chiodo la scrittura. È forse qui che gli riesce l’opera che aveva sempre cercato invano di scrivere? I tre destinatari – Nicoletta a Bamberga, Johann a Dresda e la sorella di Türmer Vera, che si trasferisce da Berlino ovest a Beirut e poi ad Altenburg – sono per lui tre amori possibili, tre diversi progetti di vita che però non possono essere realizzati nello stesso tempo, anzi si escludono l’un l’altro.
Dare luogo in modo non pretenzioso a questa imponderabilità, questa indeterminatezza, questa incertezza, era la condizione e lo scopo della mia narrazione.
Grazie alla figura del curatore da un lato ho potuto potenziare la finzione – gli epistolari di norma hanno un curatore –, dall’altro ho guadagnato un ulteriore piano narrativo.
Il curatore, che porta il mio nome, ha come ogni curatore i suoi propri interessi e intenti, che però nel suo caso diventano presto manifesti. Egli vede in Türmer un concorrente letterario. In più è geloso della stretta relazione tra Enrico e sua sorella Vera. Questo ha come conseguenza che il lettore non si fida nemmeno di lui. In questo libro non c’è nessun punto fisso, nessun luogo in cui sia celata una verità rispetto alla quale tutto il resto che si dice nel libro è falso.
Stando alla resa dei conti di Türmer con la vita che ha condotto fino a quel momento, egli è qualcuno che voleva vivere, soffrire e scrivere nella RDT, per poi un giorno raggiungere l’ovest nelle vesti di scrittore di successo e dissidente à la Biermann. Egli è contro la RDT, ma per poter vivere il suo sogno, quello dello scrittore dissidente, ha bisogno del mondo diviso in due. Türmer intuisce – e questo è ciò che lo contraddistingue – che l’inaudita, inimmaginabile caduta del Muro dissolve l’oggetto del suo sogno. Invece di passare ad ovest acclamato come dissidente, egli attraversa il confine ciabattando assieme a milioni di altri.
Türmer fa i conti con se stesso anche in quanto afferma che il desiderio di diventare scrittore gli ha rovinato la vita fino a quel momento, e questo perché tutto diventava ai suoi occhi materiale per una storia o un romanzo.
Forse però egli deve esprimersi così affinché il suo presente appaia tanto più radioso. Ciò che conta, infatti, è da quale posizione si parla. Nel caso di Türmer è quella dell’uomo d’affari dal successo crescente.
Tanto Türmer riflette sul passato, tanto irriflesso rimane il presente, come se il mondo capitalistico fosse uno stato di natura nel quale si sia ritornati dopo quarant’anni di sbandamento costituito dal socialismo reale.
Naturalmente appare scabroso fare di uno scrittore il personaggio principale. Tuttavia durante quel quarantennio, molto più del funzionario, la cui notorietà aveva un mero carattere ufficiale, era lo scrittore come sacerdote della parola a decidere ciò che era verità e ciò che era menzogna. La sua mutazione in uomo d’affari è stata per me il cambio di paradigma per eccellenza. Perché l’uomo d’affari, il manager, è la mente del mondo attuale. In ciò scrittore e manager corrispondono.
È stato difficile scrivere del presente, della vita quotidiana dell’uomo d’affari. Se nel caso delle parti rammemorative potevo prenderla molto alla larga, mi riusciva invece difficile carpire un briciolo di poesia alle annotazioni prive di distanza sulla nuova vita quotidiana. Per me questa parte divenne raccontabile allorché riconobbi in Clemens von Barrista un personaggio mefistofelico. Lo spunto mi venne da Herzgewächse oder Der Fall Adams di Hans Wollschläger, un libro impressionante che è un confronto serrato e complesso con la materia faustiana, e soprattutto con il Doctor Faustus di Thomas Mann.
Quel Clemens von Barrista che presto tutti chiamano soltanto il barone, benché non lo sia affatto – è vero però che guida una Chrysler Le Baron –, diventa il consulente personale di Enrico Türmer. Per avere successo Türmer deve solo eseguire ciò che Barrista gli suggerisce. Appena Barrista entra in scena ogni pericolo sembra bandito, la vita di ogni giorno diventa piacevole, il mondo comprensibile.
Molto spesso dopo le letture pubbliche mi è stato chiesto perché avessi tratteggiato Barrista in modo così positivo, perché non lo criticassi.
Barrista incarna ciò che anche oggi è considerato auspicabile a livello governativo: iniziativa imprenditoriale, efficienza, disposizione al rischio, crescita economica, successo. Barrista si arricchisce credendo che questa sia la via più sicura per il benessere di tutti. La cosa inquietante è appunto che a uno come Barrista non passa minimamente per la testa di mettersi in discussione.
Questa acquiescenza indiscussa era nuova nel 1990. Prima di allora l’Est e l’Ovest non si erano messi in discussione soltanto reciprocamente; la legittimità dei sistemi fu contestata anche dalle rispettive opposizioni (a volte legali, a volte illegali). I sostenitori dell’Est e i sostenitori dell’Ovest dovevano giustificarsi o almeno badare alla propria immagine. Tutto questo cambiò con la caduta del Muro.
Il giornale in cui Türmer si cimenta era stato fondato per promuovere la democrazia. Alla fine non resta che un foglio di annunci in cui appare la cronaca della cerimonia d’accoglienza del principe ereditario nel castello di Altenburg prima ancora che questa abbia avuto luogo. Türmer si vede costretto a influenzare lo svolgimento della visita affinché gli avvenimenti reali corrispondano al suo articolo. Di un simile zelo Barrista non può che ridere – a contare è solamente ciò che è riferito dalla cronaca.
A Barrista spetta tutto, sia la metà del vecchio giornale che la metà di quello nuovo, e alla fine persino la compagna di Türmer Michaela. Per non parlare degli immobili. Non solo l’edificio della redazione del giornale, ma anche la nuova abitazione di Türmer è di proprietà di Clemens von Barrista. Egli è il mediatore tra gli altenburghesi e il principe ereditario. Senza di lui, nel giro di poco tempo non funziona più niente.
Dopo aver ultimato la parte epistolare, ritornai al mio punto di partenza, la novella sull’epoca scolastica. Ora finalmente mi riuscì di scriverla come un testo di Türmer, e così anche tutti gli altri testi dell’appendice.
La novella tuttavia non appare in appendice per il fatto di essere stata il mio punto di partenza. A me interessava anche fornire delle prove a sostegno dell’affermazione di Türmer secondo la quale egli aveva sempre scritto. In più le opere di Türmer mi permettevano di aggiungere una variante ulteriore a quanto già descritto nelle lettere. Più importante, però, era per me mostrare come a Türmer la scrittura sfugga tanto più, quanto più instabile diventa la RDT, fino a risolversi con la caduta del Muro. Questo mi dava la possibilità di presentare la letteratura nel suo rapporto con il contesto storico. Cercando di mostrarne il condizionamento, usando però al tempo stesso le sue differenti possibilità stilistiche – da Herman Hesse a Vladimir Sorokin – per la descrizione, speravo di calarmi ancora una volta nell’epoca della RDT, quindi di non vederla dalla prospettiva della sua fine. Ciò che scrissi allora non avrei potuto scriverlo a nome mio, ma nelle vesti di Enrico Türmer era possibile – e, come credo, anche necessario.
***
Di Bolero berlinese. Tredici storie alla vecchia maniera non posso parlare allo stesso modo degli altri libri, perché i tredici racconti sono nati in momenti differenti e sono stati raccolti solo successivamente. Con l’eccezione di Mr. Neitherkorn o il destino, scritto nel 1996 a New York, le storie di Bolero berlinese coprono lo stesso arco temporale di Vite nuove. I primi quattro racconti nacquero mentre ero ancora alle prese con la novella di Titus e la struttura del romanzo. Ero decisamente refrattario all’idea di scrivere il racconto che dà il titolo al libro, Bolero berlinese, nella stessa maniera di Semplici storie. Non volevo continuare a scrivere in quel modo. Ma presto mi accorsi che quella storia non potevo raccontarla altrimenti. Poi però, mentre ci lavoravo, non solo gustai il fatto di non dover avere nessun riguardo per altre storie brevi, bensì avvertii quasi con malinconia una sicurezza che nella nuova strada che andavo tentando non possedevo nemmeno a livello rudimentale. Non che avessi scritto i racconti con una mano sola – è pur sempre un cercare che al primo tentativo non va mai a buon fine, e di rado riesce già al secondo. Tuttavia nel caso delle storie brevi avevo per lo meno un’idea di come andassero le cose, sapevo dove volevo arrivare, cos’era a punto e cosa ancora da completare. Allo stesso tempo cominciai a sospettare di quella stessa sicurezza, perché temevo che quella maniera così familiare potesse degenerare in artificio. Sentii anche che essa m’impediva di entrare in contatto con qualcosa di nuovo. Perché nella scrittura ci si appresta a un lavoro, ci si sintonizza su materia e stile, si diventa particolarmente sensibili a certe onde e oscillazioni, e sordi ad altre. Si percepisce in modo differente, si vede e si pensa diversamente.
Non è che mi fossi vietato di scrivere racconti, ma cercai di dimenticarmene, non volevo più pensare in quella forma. Prendevo nota delle idee che mi si presentavano, finché a un certo punto smisi di averne e interpretai questo fatto come un buon segno.
I primi sei racconti di Bolero berlinese risalgono al periodo prima del 2000. Scrissi Scrittore e trascendenza, come già Mr. Neitherkorn e il destino, al posto di un saggio che mi era stato commissionato. Entrambi i testi, per quanto diversi fra loro, non hanno niente a che vedere con la short story. Essi rinviano fin dal principio a un’intenzione, a uno sforzo di immediatezza. La lettura tardiva di Witold Gombrowicz ha procurato a Scrittore e trascendenza una svolta finale che apparenta questo racconto a quelli di 33 attimi di felicità.
Quando nella primavera 2006 ripresi in mano le idee annotate nei sei, sette anni precedenti, temetti che potessero essere invecchiati e che lo stimolo a scrivere quelle storie fosse andato perduto. Erano ancora veramente necessarie? Quello che non volevo in nessun modo era limitarmi a confezionarle con un mero lavoro artigianale.
Ma gli embrioni del 1999 e del 2000, quelli che sarebbero poi diventati I turbamenti della notte di san Silvestro e Una notte da Boris, si trovavano all’improvviso in un ambiente diverso. Per quanto banale può sembrare, il mondo era cambiato; la società dell’anno 2006 era infinitamente più polarizzata dal punto di vista sociale ed economico di quella del 1999. Benché le idee non fossero nuove, non ero costretto a scrivere dei racconti vecchi.
E ora mi venivano in mente anche nuove storie. Contrattempo al Cairo è la descrizione quasi documentaria di un viaggio, narrata sulla base di una storia d’amore inventata. Niente letteratura o epifania di sabato sera e Fede, amore, speranza numero 23 sono esperimenti. Quanto direttamente si può parlare di qualcosa di inafferrabile? Oggi si può ancora scrivere una storia d’amore in terza persona singolare, e che per di più abbia un lieto fine? Non sono sicuro che gli esperimenti siano riusciti. Entrambe le storie tuttavia sono importanti per l’equilibrio del libro nel suo insieme. La lettura dovrebbe rimanere imprevedibile.
A parte Fede, amore, speranza numero 23 i nuovi racconti sono narrati in prima persona, e così quelli più vecchi, con l’eccezione di uno. Mi interessava raggiungere l’impressione della maggior immediatezza possibile. Per questo i racconti imitano la lingua parlata. La classicashort story sarebbe già troppo stilizzata per questo scopo. Si tratta del tentativo di «far scomparire l’aspetto tecnico-costruttivo della narrazione» (Ijoma Mangold), un’aspirazione che si può intravedere già nella forma epistolare di Vite nuove.
Solo in un secondo tempo trovai il modello letterario per questo libro nei racconti di Gustav Herling, raccolti in italiano nel volume Ritratto veneziano. I racconti di Herling appaiono così privi di affettazione che si vorrebbe credere: sì, dev’essere andata proprio così! Solo a una lettura ripetuta si scopre quanto discretamente i motivi sono trattati e in virtù di quale filigrana sono intrecciati l’uno con l’altro.
Mentre scrivevo, la tradizione alla quale mi sentivo più prossimo era quella del cronista e del narratore orale di storie; era come se dovessi ricominciare dalle origini della narrazione.
Un punto di partenza erano i racconti delle Mille e una notte, dov’è sempre evidente che la narrazione persegue uno scopo – nella fattispecie, distogliere il sovrano dai suoi piani omicidi. Del resto sembra essere indispensabile, se si vuole spiegare qualcosa a qualcuno e convincerlo: invece di argomentare, si racconta una storia.
Non a caso il racconto Una notte da Boris è un’allusione al modello di Sheherazade e anche alDecameron di Boccaccio. Io stesso ero sorpreso dal fatto di scrivere del passato più recente e del presente in questa, come mi parve, vecchia maniera della narrazione orale.
Questa contraddizione ho voluto nominarla già nel titolo: Bolero berlinese. Tredici storie alla vecchia maniera. Se dovessi provare a interpretare questa costellazione, direi: siamo posti a confronto con problemi fondamentali che nell’epoca ‘pre-cellulare’ non erano considerati centrali, come ad esempio la povertà. Ma questa è solo un’ipotesi. Le connessioni tra lo stile letterario e una determinata epoca e un determinato luogo sono, com’è ovvio, assai mediate.
Molti racconti sembrano rivolgersi a un interlocutore – in alcuni c’è addirittura una sorta di apostrofe. L’impulso che mi fa cercare una modalità comunicativa il più diretta possibile ha a che fare anche con il fatto di voler essere ascoltato e di voler raggiungere il maggior numero possibile di lettori. Con i miei racconti non competo soltanto per ottenere attenzione, bensì anche per quella che nelle terze pagine dei quotidiani viene definita «Sua Altezza interpretativa». Quello che voglio comunicare sono le mie esperienze.
Sicuramente questo impulso c’era già da prima. A lungo non me lo sono confessato, perché in esso vi è anche della presunzione. Io stesso oggi preferisco formularlo dal punto di vista del lettore che sono non meno di quanto sia uno scrittore.
La letteratura esiste affinché non si rimanga soli con certe esperienze, con esperienze che non sono comunicabili conversando o in una discussione scientifica, che nella loro universalità e simultaneità trovano espressione soltanto in un racconto, una poesia, un romanzo. La letteratura non è fatta per spiegare qualcosa, ma può e dovrebbe essere usata dalla società per comprendere se stessa. Perché l’immagine che ci creiamo del nostro tempo, del nostro luogo, ha un’influenza su ciò che vogliamo e facciamo. In questo senso considero come la più efficace quella letteratura che descrive il nostro mondo nel modo il più differenziato possibile.
Le differenziazioni diventano tanto più importanti, quanto più fondamentali sono le questioni che vengono sollevate. Io voglio leggere una letteratura che non dia nulla per scontato e ponga le domande fondamentali, una letteratura che si addentri nelle nuove e vecchie convenzioni e ovvietà di questa società, le interroghi e le metta anche in discussione. Una di queste domande sarebbe: viviamo per lavorare o lavoriamo per vivere? In quanto società noi rispondiamo univocamente a questa domanda, e cioè che viviamo per lavorare. Da qui derivano molte altre domande: in quale rapporto si pone l’economizzazione di tutti gli ambiti di vita rispetto alla democrazia? Qual è il rapporto tra il denaro e il tempo dell’esistenza? Perché oggi nessuno parla più di disarmo? Perché il mio dentista deve pensare e comportarsi come un uomo d’affari? La letteratura dovrebbe stupirsi e meravigliarsi molto di più.
L’obiezione che si potrebbe muovere all’efficacia sociale della letteratura suona così: Sheherazade si imbatte in un sovrano che almeno a letto è disposto ad ascoltarla. Ma senza questa disponibilità, si potrebbe obiettare, tutto il racconto delle storie gira a vuoto – poiché quale sovrano presta mai ascolto a delle storie? Questa obiezione tuttavia non tiene conto del fatto che tanto il singolo quanto la società hanno bisogno di storie. A volte queste storie sono persino considerate vere e si consolidano in una religione. A volte gli avvenimenti vengono trasformati in storie per migliorare il loro effetto. Possiamo prendere le storie che fanno per noi dalla Bibbia, da un rotocalco, dal cinema o da un almanacco.
Di fronte alla domanda sull’efficacia della letteratura non possiamo cercare la risposta soltanto in Sheherazade e nel sovrano. Sheherazade non si è consegnata da sola nelle mani del sovrano, ma è accompagnata dalla sorella Dinazard. Dinazard è colei che dà avvio al racconto: «O sorella, ti prego, per Dio, se non dormi raccontaci dunque una delle tue belle storie». Sheherazade risponde: «Con piacere». Quando poi giunge l’alba e Sheherazade ammutolisce, Dinazard sospira: «O sorella, com’è avvincente e deliziosa la tua storia». Questo dà a Sheherazade la possibilità di rispondere: «Questo non è niente in confronto a ciò che vi racconterò domani notte, se sarò ancora viva».
In questo senso anche scrittori e lettori sono fratelli che si trovano nella stessa situazione, che dipendono l’uno dall’altro poiché si tratta di sopravvivere a mille e una notte, e che sanno che neppure mille e una notte sono sufficienti, anche se noi, per questa volta, ce l’abbiamo fatta.
Traduzione dal tedesco di Stefano Zangrando
* * *
L’intervento è tratto da Finzione e documento nel romanzo, a cura di Massimo Rizzante, Walter Nardon, Stefano Zangrando, uscito in questi giorni presso la casa Editrice Università degli Studi di Trento. Il volume raccoglie i contributi del Seminario Internazionale sul Romanzo (tra gli altri, quelli di Eraldo Affinati, Gianni Celati, Antonio Moresco, Ornela Vorpsi, Ingo Schulze). Per informazioni: Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Via S. Croce, 65 – 38100 TRENTO – Tel.: 0461 881777 – 881722 – Fax: 0461 881751 – e-mail: editoria@lett.unitn.it.

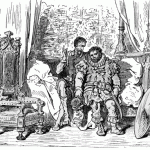 Dittico del male. Ricardo Piglia e J. M. Coetzee - Miguel Gallego Roca
Dittico del male. Ricardo Piglia e J. M. Coetzee - Miguel Gallego Roca Il pugile e il profumo della ginestra - Ingo Schulze
Il pugile e il profumo della ginestra - Ingo Schulze Due vite - Ingo Schulze e Christine Traber
Due vite - Ingo Schulze e Christine Traber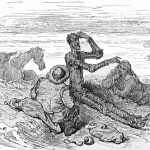 D’Arzo, lo stile di chi è straniero dovunque - Gianni Celati
D’Arzo, lo stile di chi è straniero dovunque - Gianni Celati





















