
Non so, conosco scrittori che fanno man bassa di tutto o quasi quel che vivono – e lo fanno bene, appunto perché sono scrittori. Io invece, che sono sempre meno sicuro di aver imboccato la strada giusta, non ci riesco. C’erano almeno due o tre esperienze, ultimamente, che mi sarebbe piaciuto fissare in parole, sapendo che fin dalle prime battute l’invenzione si sarebbe messa tra i piedi e avrebbe finito per falsare il vissuto – ma è ben così che capita, no? E comunque non l’ho fatto, vuoi perché avevo da lavorare, parecchio ma mai abbastanza da sostentarmi, vuoi perché appunto, come inizio a temere, i miei limiti di, come dire, “scrittore” cominciano finalmente a svelarsi, chiari e obiettivi come una piscina vuota. Che ne farò di tutta la fortuna dell’ultimo anno – la borsa di scrittura a Berlino, l’ospitalità dell’editore Keller e le letture pubbliche in Germania davanti a cento e più persone? Cosa dirò, soprattutto, a Ingo Schulze, che ha creduto in me a scatola quasi chiusa e ora si trova, senza saperlo ancora, ad aver sostenuto un ciarlatano, un narcisista senza argomenti, un velleitario? Ecco, mettiamo ad esempio Ingo Schulze. Schulze è uno che prende quel che gli succede e se lo cova senza fretta finché non appare un personaggio fittizio, saltato fuori chissà come, a volte eccone un altro e un altro ancora, pian piano si svela e chiarisce anche lo stile da impiegare, “adeguato alla materia” direbbe Schulze con Döblin, poi magari accorre persino qualche classico, giusto per non far tutto da soli, nel presente, e la ricetta di base è pronta: si tratta ora di mettersi al lavoro, tentare, costruire, e si sa, tra il dire e il fare… Ma lui è uno scrittore, appunto, e lo fa. Si mette al lavoro e prima o poi eccolo lì, il racconto fatto e finito, il vissuto falsato a dovere. E non si dica che è questione di tempo, che Schulze lo fa perché essendo scrittore affermato ha il tempo per farlo: sciocchezze, lo fa perché è bravo. Anche Giacomo Sartori, per dirne un altro, è uno che lavora sodo e sa come farlo, è questa la bravura, uno che vive di pene e progetti di scrittura e se li cura, li pianta e coltiva e rinnesta e annaffia e alla fine raccoglie il frutto sopraffino, e questo nonostante abbia poi tutto il lavoro di sostentamento, che Sartori è agronomo e docente di agronomia e fa il pendolare tra Trento e Parigi, non so se mi spiego. Hai voglia, poi, di sentirti dire da amici come loro che sai scrivere: cosa se ne fa uno, del saper scrivere, se poi non scrive? Ma soprattutto, che cosa scrive a fare, uno che magari sa un po’ scrivere, se gli sembra che quel che vorrebbe fare e dire lo fanno e dicono meglio già altri? Una volta era diverso: una volta gli scrittori che mi lasciavano ammirato mi accendevano anche, mi insufflavano l’ardore di imitarli, di mettermi sotto, di provarci; oggi invece l’ammirazione, quando si manifesta, è una sbarra che si abbassa di colpo davanti al mio passo sempre più tremolante – e ai miei sensi sempre più intorpiditi dall’informazione. Cos’è cambiato? Possibile che sia soltanto, come a volte mi vien da presumere, una questione erotica? Voglio dire il precoce ma naturale declino di certi ormoni abbinato a una certa assuefazione all’esistenza, insomma un certo calo dell’ambizione? O è proprio l’informazione ad avermi ormai narcotizzato come il più incosciente e ottuso dei piccolo-borghesi? Davvero, ultimamente tutti quelli che frequento e stimo non è che “mi sembrano”, ma sono più intelligenti di me, nel senso proprio che intel-ligono di più, ci vedono dentro, a fondo, meglio: hanno un pensiero che reagisce, che elabora i dati vissuti, diventa critico. Io no. Io ormai l’unica cosa che mi immagino di fare è fissare in parole certe esperienze, poi però non faccio neanche quello. L’esperienza del villaggio turistico, ad esempio. A fine maggio mi sono sposato, in comune, il sindaco ha anche fatto un bel discorso, alla fine ha declamato una poesia di Saba e si è persino commosso, lui, noi sposi un po’ meno ma insomma, ci siamo sposati e poi siamo partiti, mia moglie il nostro pupo e io, per una vacanza, e proprio perché c’era il pupo, che quest’anno fa due anni, abbiamo scelto di andare in un villaggio turistico attrezzato per i pupi. Ebbene, in quei dieci giorni faticosissimi al villaggio ho assistito a varie cose che, se fossi stato uno scrittore, avrei annotato ogni giorno su un taccuino e alla fine sarei tornato, senza dubbio, con appunti a sufficienza per un racconto su una certa Italietta, sulla volgarità e la regressione di un mucchio di citrulli caciaroni che poi tornano a casa e chissà che cosa pensano e votano, se pensano e votano, e magari l’avrei colorito con le febbri intestinali che ci han colti e prostrati uno dopo l’altro, a mia moglie il pupo e me, e forse anche con la mia allergia, che sono l’unico che soffre di allergia ai pollini anche al mare, dio boia, e avrei certo contrappuntato tutta quella miseria tragicomica con la presenza dei cani randagi, in particolare di quello che l’ultimo giorno di vacanza ho visto vagolare tra i tavoli del ristorante mentre un metro più sopra i vacanzieri si abbuffavano smodati e indifferenti, e infine avrei fatto in modo, con palese autoindulgenza ombelicale, che il climax fosse rappresentato dal mio primo e penultimo bagno in mare, nell’acqua freddissima dello Ionio calabro che mi ha galvanizzato in maniera inaudita, che una volta uscito dall’acqua non sentivo neanche un po’ il vento teso sulla pelle d’oca, tanto mi ero ambientato in quel gelo tonificante. Ecco, avrei provato a scrivere una cosa così, un racconto di costume e in costume ben fatto, giusto un po’ autocentrato, quel tanto che l’età ancora mi concede, visto che oggi in Italia a trentacinque anni si è “giovani”, giovani scrittori nella fattispecie, a dispetto di quel fondatore che alla stessa età si definì «nel mezzo del cammin», e magari sarei anche riuscito a scriverlo, il racconto, mosso e fortificato dal modello che in quei dieci giorni ha costituito la mia unica lettura, Ennio Flaiano. E invece cos’è successo? Che a leggere il Diario notturno e poi rileggere Tempo di uccidere, anziché venirmi voglia di scrivere anch’io, traendo esempio e linfa da un maestro dopotutto neanche eccelso, mi è passata la voglia di scrivere del tutto, perché Flaiano a trentacinque anni aveva già scritto una cosa come «La saggezza di Pickwick», una roba di una qualità e un’intelligenza che io posso scordarmele anche a quaranta e oltre. Questo è successo, al villaggio turistico, e così la Moleskine è rimasta tale e quale alla partenza, con l’ultimo appunto del marzo scorso, un appunto ombelicale e quindi inutile, anzi no, un momento, ce n’è un altro, più recente, ed è proprio, guarda guarda, un appunto su Flaiano, scritto qualche settimana fa, mentre leggevo il Diario degli errori, e dice: «C’è un appunto di Flaiano che mi ritrae: “La storia di quei tali che stanno precipitando sorretti da una speranza.” Meglio, sono io a far parte di quella storia. Sono un “tale”».
Questo tanto per spiegarmi, per fugare i sospetti di falsa modestia, che sarebbe la cosa peggiore, senz’altro la più disonesta. Insomma, tutto arranca proprio mentre pareva che stesse andando benone, e dunque è proprio vero quello che diceva ancora Flaiano, che lo disse, mi pare, dopo aver vinto la prima edizione dello Strega col suo unico romanzo, e cioè che il successo è sempre frutto di un malinteso; e dunque anche la mia fortuna dell’ultimo anno, benché come “successo” sia stato assai modesto e comunque invisibile in Italia (ma non è già un lusso eccessivo per la mia mediocrità?) si svela infine come un malinteso – e allora, a questo punto, confesso di averlo sempre sospettato, fin da subito, che tutto era una roba immeritata. E questo mentre altri, cari amici, mi dicevano che bello, vuol dire che te lo meriti, oppure che ti frega, fai la faccia tosta e vai, mentre io, guardando altrove, già mi chiedevo se tutta quella fortuna l’avrei mai inserita nel mio cosiddetto curriculum, come si usa fare oggi, che tutto finisce nel “curriculum”, fesseria delle fesserie: fare le cose anche perché “fanno curriculum” – ma cos’è questa obbedienza al “curriculum”? E fino a che età, poi? Fino a quando uno deve dipendere dal proprio “curriculum”? Trentacinque anni non sono forse un’età già troppo avanzata per avere un “curriculum”? A trentacinque anni uno non dovrebbe essersi fatto una vita anziché trascinarsi dietro al proprio “curriculum”? Il “curriculum”, dico, dovrebbe avere senso fino a venti, venticinque anni e poi via, si parte, si è, e invece tutti sempre lì ad aggiungere, inserire, allungare, gonfiare, sempre con la clausola sui dati personali, fino a trenta, quaranta, cinquant’anni. Ma come si fa, mi domando, a voler ancora avere un “curriculum” a cinquant’anni, a quaranta, a… Sta di fatto che alla fine, anche sul libro uscito da Keller – potevo forse ometterlo? L’epoca abbindola, prescrive, ottunde… E dunque, nel risvolto, ecco scritto «nel 2008 ha ottenuto una borsa di scrittura» eccetera, perché fa figo, perché mica tutti, anzi pochissimi, e chissà che meriti uno ha se gli è capitata una roba del genere – ma quali meriti! Sono un bluff come moltissimi altri anche se ora lo dico a bassa voce, perché sennò sembra che reciti, che menta, che faccia il falso modesto, invece no, vorrei sussurrarlo forte e chiaro, che si sappia, non si ignori, che io funga da modello negativo, da antiesempio, da piccolo emblema del vizio dei tempi, e chissà che almeno così la mia «volontà» non suffragata dal «talento» (ancora Flaiano, maledetto) trovi un certo appagamento in questa luce ignobile, il solo riflettore che io meriti davvero e che dunque ormai vogliomeritarmi: sono un bluff, lo giuro, e se continuo a scribacchiare come in questo istante è solo per vanità e compiacimento, e finché c’è qualcuno che a sue spese mi dà retta io non smetto
Vecchiatto a quanto pare invece no. Vecchiatto è un vero esempio positivo, un antiemblema. Di Vecchiatto mi ha parlato un signore al villaggio turistico, uno che solo al ritorno, incredulo e di stucco come mai, ho scoperto chi fosse. Mi spiego. A far la fortuna dei pennaioli come me ci sono soprattutto due cose: l’incompetenza dei lettori e le coincidenze, che poi basta raccontarle tali e quali a quegli stessi lettori e tutto prende un’aria magica, già romanzesca. Così adesso, se volessi, avrei di che incantare a raccontar come si deve di un incontro al villaggio turistico. Poiché al villaggio non c’erano soltanto citrulli caciaroni. Se mia moglie il pupo e io ci siamo sentiti come pesci fuor d’acqua, c’erano invece altre persone, tutt’altro che volgari e regredite, che parevano passarsela, dopotutto a loro agio, e tra queste una coppia sulla cinquantina. Venivano in spiaggia da soli e lei restava sempre sulla sdraio, un po’ al sole e un po’ all’ombra, serena e sorridente. Lui invece era sempre in piedi, spesso in acqua, e in quattro e quattr’otto è diventato l’amicone di mio figlio, che però fino all’ultimo, timido com’è, non l’ha degnato di un solo ciao. Ma l’uomo non rinunciava, lo chiamava e salutava col vocione e l’accento del sud – il nome di mio figlio fu l’unico che venne fuori, noialtri adulti restammo anonimi –, gli riempiva il secchiello con l’acqua del mare e una volta gli ha portato due o tre palle fatte d’alghe, sfere quasi perfette, un po’ pelose ma belle, gomitoli verdi che mio figlio, seduto nudo sulla sabbia, ha guardato e manipolato con stupore. Così un po’ alla volta ci siamo messi a parlare. Venivano dal salernitano – si sa, in simili circostanze la provenienza è il rompighiaccio della conversazione. Poi dicemmo di com’eravamo arrivati, forse perché lì al villaggio quelli come noi del nord, venuti in aereo, rimanevano isolati, in quell’anus mundi lontano da tutto, senza possibilità di uscire e fare gite a meno di pagare cifre esorbitanti all’organizzazione per le escursioni guidate, e questo ci frustrava. Loro invece erano venuti in macchina e potevano muoversi, in compenso da casa fino a lì ci avevano messo uno sproposito, quattro volte quel che noi avevamo impiegato in aereo da Bologna. « La Salerno-Reggio Calabria » disse l’uomo, «è un girone infernale srotolato». Un giorno poi, quando vide che leggevo Flaiano sotto l’ombrellone, mi disse che anche lui leggeva molto, ma non in spiaggia: «Il mare mi toglie il pensiero, mi resta soltanto lo sguardo». E infatti, spesso, alzando gli occhi dalla pagina lo sorprendevo in piedi sul bagnasciuga, di spalle, le mani puntate su fianchi, immobile e probabilmente zitto, a guardare l’orizzonte. Poi un altro giorno mi parlò di certe sue amicizie che non volle chiamare per nome, ma che parevano confortarlo grandemente nell’«odierno decadimento italico», come lo chiamò. Così ci mettemmo a parlare di quell’argomentaccio, trovandoci a un tratto a sfogare apertamente disgusto indignazione e vergogna, come amici di lunga data, anche se poi, al tramonto, ci salutammo come tutti gli altri giorni, senza neanche conoscerci per nome. Il giorno dopo – la notte c’era stato un temporale e il vento era cambiato – lo trovai all’inizio del mare, l’acqua fino alle caviglie, intento a pescare rifiuti: tirava su buste e pezzi di plastica portati a riva dalla mareggiata, li infilava l’uno nell’altro e li portava a terra, nel bidone del bar della spiaggia. Ecco, se avessi scritto il racconto sul villaggio forse avrei provato a far di questa l’immagine più poetica e toccante, un inno discreto alla morale e all’utopia. E comunque, insomma, la sera di quello stesso giorno, al bar del villaggio, mentre in sottofondo scorreva lo strazio canzonettistico del pianobar, l’uomo mi raccontò di questo attore veneziano del secolo scorso, Attilio Vecchiatto, e lo fece con una proprietà che io adesso non so se saprò riprodurre, ma ci provo, bluff per bluff non sarà certo peggio di quel che ho scritto finora: «Ricorderò sempre una sera d’inverno», iniziò l’amicone di mio figlio, «quando udii bussare al portone del nostro cortile, con forti colpi, come di chi avesse un’estrema necessità d’aiuto o uno stato di nervosismo incontenibile. Mi affacciai tenendo il portone socchiuso, e prima che potessi vedere chi bussava, mi trovai tra le mani un opuscolo dattiloscritto, dove lessi a malapena queste parole: “Sonetti del Badalucco nell’Italia odierna”. Poco dopo, i due personaggi che avevano bussato al nostro portone, seduti in cucina, divoravano tutto ciò che mia moglie si affrettava a mettere in tavola. Si capiva che non avevano mangiato da giorni. Io e mia moglie li avevamo sentiti mormorare con un filo di voce: “Siamo attori, veniamo da lontano. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Scusateci. Potreste darci qualcosa da mangiare?” Così diceva la delicata voce della signora Carlotta, moglie di Attilio Vecchiatto. E lui, anziano, emaciato, vacillante, con un cappello a larga tesa e un consunto mantello d’altri tempi, si fece avanti così: “Io sono l’attore Attilio Vecchiatto. Lei avrà sentito parlare di me, vero?” Al che dovetti mentire in tutta fretta, dichiarandomi un suo appassionato ammiratore: “Chi non ha sentito parlare dell’attore Vecchiatto?” Per fortuna non mi fece domande d’accertamento, dato che non sapevo chi fosse, né che avesse conquistato la sua fama nel Sud America, poi a New York e infine a Parigi – ma mai in Italia , dove di fatto era sconosciutissimo. Ricordo con piacere quel nostro primo pranzo assieme, mentre mia moglie metteva in tavola piatti di maccheroni e salcicce, ceci fritti, castagne, pasticci di mele. I due ospiti ingurgitavano tutto, raccontandoci la loro vita, con le voci che si accavallavano, e scatti d’ira di Attilio quando Carlotta interferiva nei suoi discorsi. Mio nipote Amedeo, allora quindicenne, volle sapere il senso della frase latina nell’opuscolo dattiloscritto con cui Attilio s’era presentato: Umbrarum fluctu terras mergente… Al che Vecchiatto ci spiegò il concetto di questa filosofia, la filosofia di Giordano Bruno : “È l’idea di un’oscurità in cui gli uomini vivono, come un grande mare di ombre che sommergono tutti i continenti piombando le menti degli uomini in una cecità molto difficile da superare”. Ed era» spiegò l’uomo quella sera al bar del villaggio sullo sfondo dello strazio pianobar, «il tema di due tra i suoi più riusciti sonetti, La prima e La seconda lezione di tenebre». Ora, a me a quel punto era già sorta una strana curiosità, perché quel nome, Vecchiatto, mi suonava lontanamente familiare. Non riuscivo però a ricordare dove l’avessi già sentito. L’uomo proseguì raccontando di certi episodi romani della vita di Vecchiatto che però ho dimenticato, troppo fitti e dettagliati per la mia memoria debole. Ma ricordo suppergiù l’ultima parte di quel racconto: «Con la bella stagione» disse l’uomo, «ci è capitato spesso di fare lunghe passeggiate, su per i prati ai piedi del Vesuvio. Attilio era già vecchio, zoppicava vistosamente, appoggiandosi a uno strano bastone fatto di nervi di bue. Carlotta leggeva le carte, con un mazzo di tarocchi. Di sera, quando sedevamo nel nostro cortile per chiacchierare del più e del meno, lei faceva le carte a tutti, tranne ad Attilio, che non voleva saperne di quello che gli sarebbe accaduto. Poi a un tratto, senza dire niente a nessuno, verso la fine del maggio 1987, nei giorni in cui il Napoli di Maradona vinceva il suo primo scudetto e per le strade delle città campane infuriavano rumorosi festeggiamenti, Attilio e Carlotta scomparvero dalla circolazione».
Così finì il racconto dell’uomo, che a quel punto avrebbe voluto recitarmi a memoria alcuni sonetti di Attilio Vecchiatto se mia moglie non fosse accorsa a chiamarmi, la faccia contratta in un’ansia improvvisa: nostro figlio aveva vomitato nel lettino, l’influenza intestinale lo aveva sorpreso nel sonno. Mi scusai, mi congedai in tutta fretta e il giorno dopo, quando arrivammo in spiaggia, la coppia di salernitani non c’era più; non la trovammo neanche al bar o al ristorante: dovevano esser partiti. Poiché tuttavia il sassolino era ormai gettato, vi lascio immaginare il mio sbalordimento quando, rientrati dalla vacanza anche noi, io con il mal di pancia contagiato dal pupo, ho cercato in internet notizie su questo Vecchiatto e, prima ancora di imbattermi nel libro di Gianni Celati di cui mi aveva parlato una volta l’amico Walter Nardon , il quale su Celati ha scritto un saggio, son capitato sul sito di «Zibaldoni e altre meraviglie», la rivista on line diretta da Enrico De Vivo : vi trovai un pezzo appena pubblicato, firmato dal medesimo De Vivo, il quale altro non era che il racconto che avevo ascoltato al bar del villaggio dall’amicone di mio figlio, lo giuro: che l’autore mi rovini se mento. Questo anche per dire che, se fossi stato uno scrittore bravo, avrei fatto in modo che questa agnizione poggiasse su dettagli accuratamente disseminati prima, trasformando la coincidenza vera in un prodigio romanzesco, come saprebbero certo fare, molto meglio di me, Schulze e Sartori e forse anche De Vivo stesso, benché per intanto egli si pregi di aver pubblicato, or ora peraltro, «un libro di racconti, riscritture, narrazioni orali, perfino versi occasionali – qualcosa di molto lontano dalla spirito “romanzesco”, come dice Gianni Celati, che ossessiona la letteratura occidentale moderna». Ecco, alla fin fine in questo frangente, mentre ancora non riesco a credere che Enrico De Vivo abbia donato palle d’alghe a mio figlio, è proprio qui che mi ritrovo a pascer vanità e compiacimento: tra il romanzesco e l’antiromanzesco, tra Schulze e Sartori da un lato e Celati e De Vivo dall’altro, mentre sopra la mia testa, beffarda, pende la spada di Damocle del non-romanzesco di Flaiano. Che angustia! Auguro all’amico Nardon, che entro l’anno pubblicherà il suo primo libro nella stessa collana di De Vivo e da questi diretta, qualcosa di meglio di questo sterile tormento. Gli auguro, insomma, di diventare un vero scrittore.
Testo pubblicato QUI il 21 giugno 2009

 Nel giardino zen del Gobbo Divino. Con una lettera di Gianni Celati del 2013 - Massimo Rizzante
Nel giardino zen del Gobbo Divino. Con una lettera di Gianni Celati del 2013 - Massimo Rizzante La città è finita - Enrico De Vivo
La città è finita - Enrico De Vivo Gabbiani in assemblea - Enrico De Vivo
Gabbiani in assemblea - Enrico De Vivo Ogni anno, ogni volta - Enrico De Vivo
Ogni anno, ogni volta - Enrico De Vivo Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo
Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo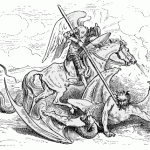 Hermann Broch e il romanzo polistorico
Hermann Broch e il romanzo polistorico Hermano germano
Hermano germano Generation P o la deriva commerciale dello spirito russo (e non) nell’era telecratica
Generation P o la deriva commerciale dello spirito russo (e non) nell’era telecratica





















