
«In mezzo ai campi, qua e là, si scorgeva qualche melo, senza più fiori, con appena un mazzetto di pistilli, eppure sufficiente ad affascinarmi, perché ravvisavo quelle sue foglie inimitabili la cui vasta distesa, simile alla passatoia di una festa nuziale ormai finita, era stata percorsa, poco prima, dallo strascico di raso bianco dei fiori rosseggianti. (…) Guardavo i tre alberi, li vedevo bene, ma dentro di me sentivo che nascondevano qualcosa su cui non riuscivo a far presa, come quegli oggetti troppo lontani che le nostre dita, allungandosi in fondo al braccio proteso, arrivano soltanto a sfiorare per un attimo, in superficie, senza afferrare alcunché. (…) Avvertii nuovamente, dietro il loro schermo, lo stesso oggetto conosciuto ma indistinto, e non riuscii ad afferrarlo. Intanto, man mano che la carrozza procedeva, li vedevo farsi tutti e tre più vicini. Dove li avevo già contemplati? (…) Fui tentato di crederli fantasmi del passato, compagni diletti della mia infanzia, amici scomparsi che facevano appello ai nostri comuni ricordi. Come ombre, sembrava mi chiedessero di portarli con me, di restituirli alla vita. (…) Vidi gli alberi allontanarsi agitando disperatamente le braccia, come se dicessero: Quello che non riesci a sapere da noi oggi, non lo saprai mai più» 1.
Queste pagine celebri della Recherche contengono – promessa di una futura epifania interiore, imprigionata dietro lo schermo di un’apparente sconfitta – uno tra gli annunci che il Narratore del romanzo proustiano riceve intorno alla sua vocazione alla letteratura; l’annuncio di un messaggio di verità racchiuso in se stesso di cui il mondo esterno manifesta, in vitro, solo il simbolo. Lo spettacolo degli alberi di melo spogliati dei loro fiori primaverili è trasposto da Proust come cimitero, di fronte all’impotenza del protagonista di cogliere il segreto celato dalla spianata silenziosa, sulla quale si stagliano, issati verso il cielo, gli arti vegetali di quegli idoli muti come attori di una tragedia antica.
Se i versi di Thomas Eliot, scelti da Giovanni Zaffagnini ad epigrafe di questo volume, traducono l’immagine di un mondo immensamente arido e spoglio all’indomani della Prima Guerra Mondiale («Quali radici si afferrano, quali rami crescono su queste rovine di pietra?» – 2), in una dialettica tra dimensione esterna ed interiore, la pressoché contemporanea introspezione svolta da Marcel Proust si invera esplicitamente nella realtà dell’io. In comune vi è, toposdell’arte occidentale in età moderna, il valore del paesaggio quale specchio di una condizione profonda dell’essere e del mondo nella sua assolutezza.
Il paesaggio è uno dei temi ricorrenti del lavoro di Giovanni Zaffagnini. Meglio, mi pare di intendere, quando si tratta di paesaggio oggetto o spettatore, talvolta vittima, delle mutazioni derivate dall’intervento umano sulla natura così come dei rivolgimenti climatici e geologici. Intendere però la fotografia di Zaffagnini come strumento di denuncia, secondo una poetica a priori, sarebbe un errore. La serie di immagini che viene qui presentata si fonda, al pari di altri lavori del fotografo fusignanese, su uno sguardo tanto distaccato quanto riflessivo sull’oggetto della ricerca, tema che rinvia sempre ad altro rispetto a sé. L’adesione alla proposta di dare voce alla protesta dei produttori ortofrutticoli romagnoli rifiuta le manifestazioni di piazza, in sé ovviamente legittime, per fotografare le conseguenze di un mercato sempre più sfavorevole alla sopravvivenza dell’agricoltura quale risorsa economica reale: i campi-sepolcri, il deserto delle zolle, la terra desolata dei poderi, un tempo fioriti, progressivamente mutati in spianate a perdita d’occhio. Si è sempre detto che nella campagna romagnola non si vedeva mai la linea dell’orizzonte, nascosta com’era dai giardini variopinti dei frutteti e dei vigneti. Negli ultimi anni a chiunque risulta evidente come queste pianure coltivate stiano poco a poco assumendo le sembianze del paesaggio delle terre ferraresi, lande estese, vuote o coltivate a seminativi, su cui d’estate picchia un inquietante sole zenitale e che d’inverno appaiono semplice riflesso del colore di ardesia del cielo.
Gli effetti, nel mercato della frutta, del venir meno dei profitti per gli agricoltori si scoprono quindi nelle metamorfosi del paesaggio. Così le fotografie dei campi raccolte nelle zone di Lugo, Bagnacavallo e Alfonsine hanno in primo luogo il significato di testimonianze mute. Esse colpiscono per il rigore razionale delle inquadrature, dello sguardo lieto di registrare le armonie casuali fra linee verticali (dei pali di cemento, dei tronchi) e orizzontali (dei legni divelti e affastellati in serie come i binari di una ferrovia incompiuta, dei tubi di irrigazione artificiale), coinvolte in equilibrate simmetrie e inaspettati rimandi. Oppure l’occhio indugia sugli alberi-scheletro, con le loro inedite forme a triangolo sghembo rovesciato, sui mozziconi di tronchi-lapidi, ordinati in file parallele che ricordano i cimiteri dei soldati anglo-americani, ma anche sui cumuli dei rami accatastati, che nella memoria di ciascuno possono trovare un’eco singolare e raccapricciante nelle immagini sempre più familiari di macerie e rifiuti o di corpi umani ammassati dopo un olocausto. A ciò seguono le riprese delle tombe divelte, i crateri formati dalle radici estirpate dal suolo, simili a giganteschi polipi morti lasciati sulla rena o ai torsi di statue colossali e millenarie emerse da uno scavo archeologico. Questa seconda serie di fotografie si avvicina all’oggetto offrendo una visione più ravvicinata e cruda della materia: l’ossario si svela nei suoi dettagli, nelle ferite ancora aperte e sanguinanti, in termini non solo figurati, perché col passare dei giorni la corteccia lacerata assume i colori rossicci del sangue coagulato. È qui più forte il senso della violenza, così come dell’abbandono e della morte. I legni scorticati, che trattengono ancora le qualità rugose e incrostate della materia organica in superficie, dell’azione prodotta dagli agenti atmosferici negli anni, possono ricordare la pittura informale italiana degli anni cinquanta e sessanta.
Si ha la percezione di un paesaggio che, variando, impoverendosi, perda la propria identità specifica a favore di un’uniformità incolore e anonima, al fine poco significante: non più campagne reali, caratterizzate dalla tessitura variegata delle colture, ma campagne-periferia; non più giardini che incorniciano le località di piccola e media misura delle province, bensì pianure funzionali a dividere quartieri residenziali e aree industriali e manifatturiere. A queste ultime, in tal modo sempre più visibili in lontananza nei loro torreggianti agglomerati extra-urbani, si contrappongono, isolati e remoti, gli insediamenti rurali, quando ancora abitati.
Su tutto questo invita a riflettere, con molta profondità, la fotografia di Giovanni Zaffagnini, senza intenti di polemica o giudizi. Lo strumento della fotografia raccoglie le immagini dell’olocausto agricolo in corso d’opera (amputazioni ed estirpazioni), con l’interesse di chi non osserva il paesaggio svogliatamente dietro il finestrino di un’auto in corsa, ma si sofferma a guardare da vicino ciò che sfugge all’attenzione di occhi avvezzi ormai solo alla banalità: «Come ombre, sembrava mi chiedessero di portarli con me, di restituirli alla vita». È un invito che giunge gradito, simile a quello urlato dai meli sfioriti al Narratore della Recherche: «Quello che non riesci a sapere da noi oggi, non lo saprai mai più».
Mauro Minardi







 A cielo aperto - Redazione
A cielo aperto - Redazione Scrivere per il gatto
Scrivere per il gatto Un Natale meraviglioso con gli ZiBook di Zibaldoni
Un Natale meraviglioso con gli ZiBook di Zibaldoni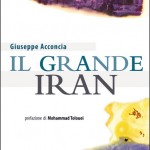 Il grande Iran
Il grande Iran





















