
Bisogna cominciare con il dire che per Hsiao Chin la meta è l’origine.
Agli occhi e alla mente di un europeo, di un occidentale, questo è già un paradosso.
E noi europei e occidentali non sopportiamo i paradossi: sono l’ultimo rifugio prima di capitolare, prima di chiedere aiuto all’analista o a Dio. Vivere nel paradosso, cioè nell’intuizione che la verità possieda due volti, entrambi autentici e irriducibili, non ci appartiene. La legge universale alla quale l’uomo saggio può solo accennare, visto che ogni opposizione si mobilita solo per riaffermare l’eterno divenire non raffigurabile né pronunciabile, non è la nostra origine.
Alle origini del nostro modo di pensare non c’è la saggezza, concepita come umile adeguamento a ciò che si manifesta, ma la filosofia, un amore talmente assillante per la conoscenza che ciò che si manifesta deve essere colto in tutta la sua necessità e oggettività.
Il divenire, fin dall’inizio, è sospetto, menzognero: il fiume delle cose deve essere riportato alla sua fonte, all’Uno, all’Essere, alla Verità, ai principi logici di identità e di non contraddizione. Il divenire deve essere fermato, immobilizzato, trasceso, pensato e detto. All’inizio c’è il Logos, che è allo stesso tempo principio delle cose e parola ordinatrice.
Se penso all’arte delle nostre origini vedo il poema epico, la tragedia e le statue della Grecia classica. Vedo l’Iliade: la storia di un assedio dove uomini e dèi si combattono; vedo l’Odissea: la storia di un viaggio e della nostalgia delle origini; vedo l’eroe tragico, la sua ubris, la sua sfida agli dei, il suo desiderio di essere come loro, di non seguire il fiume delle cose, di vincere la corrente; vedo i kouroie la volontà dell’artista di rappresentare il più realisticamente possibile il volto e il corpo di un uomo.
La storia dell’arte occidentale è la storia di un assedio in cui l’uomo lungo il suo viaggio nostalgico per tornare da dove è venuto sfida gli dei al fine di rappresentare nel modo più perfetto se stesso – proprio come se fosse un dio, proprio come se, come un dio, possedesse la perfetta misura della bellezza.
Ora, se vogliano non dico comprendere, ma avvicinarci all’opera di Hsiao Chin, dobbiamo imboccare un altro sentiero: quello dell’accettazione di ciò che alle origini anche noi occidentali abbiamo chiamato Natura, e accettare soprattutto il suo principio dinamico, il suo fluire ininterrotto che cancella la frontiera tra soggetto e oggetto, e infine immaginare l’artista non come un uomo assediato dalla sua sfida con gli dèi per la conquista della bellezza, ma come qualcuno che dimora sulla soglia e che si fa strumento sempre duttile, e allo stesso tempo fedele, dell’eterno divenire. Dobbiamo cercare di pensare l’arte come quel sentiero su cui stiamo camminando. Lungo il sentiero si possono incontrare uomini, donne, incappare in eventi drammatici o felici, fermarci a guardare le nuvole, una cascata, sfidare alcuni pericoli, ritornare sui nostri passi, sostare sotto un albero, prendere le distanze da un animale che ci minaccia, essere costretti a sospendere le nostre abitudini. La cosa importante è restare disponibili, curiosi, capaci di integrare modi e condotte anche molto diversi tra loro. E soprattutto non sentirci assediati, o in guerra, per imporre il nostro ordine al mondo: l’eterna ubris dell’uomo e dell’artista occidentale. Non ci si può avvicinare all’opera di Hsiao Chin se non ci si è liberati dall’angoscia di decifrare. Per farlo, dobbiamo accettare quello che per la nostra civiltà occidentale è un altro paradosso e che Lao-tsê ripete molte volte in modo diverso ma perseguendo sempre il medesimo intento: «La via è qualcosa di assolutamente vago e inafferrabile».
Come? La via, ovvero la verità, ciò per cui la stessa vita assume un senso ed è degna di essere vissuta è qualcosa che, per la sua stessa natura «vaga», imprendibile, indefinita, ci rimarrà per sempre precluso? Io stesso dunque sono qualcosa di «vago», di «inafferrabile»? Ma allora non ci rimane nulla. Sì, è così. Solo che il nulla di Hsiao Chin non è il deserto del nichilismo occidentale. Non è il punto finale della metafisica, ma il punto di partenza da cui, mentre stiamo camminando, sempre si parte per entrare in sintonia con la Natura, o se si vuole, con quello che una volta abbiamo chiamato Cosmo. Ma ancora: la nostra relazione occidentale con il Cosmo non è quella che, ad esempio, traspare in tutte le opere di Hsiao Chin, in tutti i suoi acrilici, nei suoi disegni su carta di riso, nei suoi inchiostri, nelle sue ceramiche. Il nostro Cosmo è una spiegazione del Caos, è la volontà pervicace di imporre una forma a ciò che è «vago» e «inafferrabile». Aristotele, come prima di lui Platone, sapeva che il Cosmo è figlio del Caos e che a quest’ultimo avrebbe fatto ritorno. Solo che per il greco, come poi per l’uomo occidentale, tale consapevolezza non vince sul desiderio di dare forma, sull’ubris infinita di dare un ordine, per quanto precario, alla molteplicità degli elementi eterogenei sospesi nel Caos.
Per Lao-tsê, e per Hsiao Chin, invece, «la più grande immagine non ha forma».
Da qui la nostra grande difficoltà di dare un nome all’arte di Hsiao Chin. Certo, la sua biografia esteriore ci informa che scoprì molto presto l’arte modernista: Cézanne, Matisse, Klee. Ma può essere che in Klee, ad esempio, si sia stupito di riconoscere l’antica arte calligrafica cinese. Nel suo intenso pellegrinare, in Spagna diventò, ad esempio, amico di Tàpies e di altri artisti “ informali”. Informali? Che cosa significa? Che cosa significa essere “ informale” per qualcuno che cammina su un sentiero alla fine del quale «la più grande immagine non ha forma»? In Italia frequentò Fontana e gli spazialisti. Spazialisti? Che cosa significa essere uno “spazialista” quando lo spazio non è concepito come una dimensione inalienabile e rigida, ma come qualcosa di vivente, percorso da quello che gli antichi cinesi chiamavano «soffio»? Negli Stati Uniti conobbe Rothko e comprese subito di aver trovato un fratello spirituale. Si avvicinò anche all’espressionismo astratto e all’action painting. Ma ancora una volta: che cosa significa “espressione”, “astrazione” per qualcuno per il quale è sempre stato irrilevante il territorio dell’ego e per il quale non c’è mai stato nulla di così reale come il compenetrarsi di ogni essere vivente con il mutare infinito e apparentemente invisibile del Cosmo? E che cosa c’è dietro il gesto di Hsiao Chin? L’enfatizzazione del corpo?
Non c’è traccia di fisicità sulle superfici dei suoi quadri e delle sue carte e tanto meno di lotta esistenziale di cui l’opera sarebbe il documento finale.
Non c’è assedio, non c’è guerra, nessuna Iliade, nessuna Odissea, nessun viaggio della nostalgia, nessuna tragedia, nessun atteggiamento di sfida nei confronti degli dei, nel processo di creazione di Hsiao Chin. Di più: non c’è neppure creazione, nel senso che noi occidentali di solito diamo a questa parola. Creare significherebbe per Hsiao Chin agire, commettere in altre parole un’azione contraria al divenire, mentre compito dell’artista, come di qualsiasi altro uomo, è quello di assecondarlo.
Solo così il sentiero su cui stiamo camminando non avrà fine.

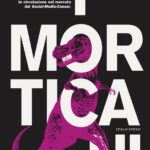 Francesco Maino, o la lingua impossibile
Francesco Maino, o la lingua impossibile Seminario Internazionale sul Romanzo
Seminario Internazionale sul Romanzo Sulla sonata
Sulla sonata Un romanzo veramente europeo
Un romanzo veramente europeo





















