
Giacomo Sartori è uno scrittore trentino che però – non a caso – vive a Parigi. Perché odia le montagne, dato che «impediscono allo sguardo di spaziare e di muoversi a piacimento, di ritemprarsi, di riposarsi. Per non parlare delle idee, che appena nate sbattono contro le pareti di roccia, e muoiono tra atroci dolori» [1]. L’ultimo romanzo di Sartori, intitolato Rogo (CartaCanta Editore, 2014) però, proprio in montagna è ambientato, raccontando tre storie di donne che ruotano intorno al paese di Vigo, in una valle remota coperta di boschi e ai piedi di picchi montani. Tre storie intrecciate nel racconto di Sartori, ma appartenenti ad epoche diverse: quella della “strega” Gheta nel 1627, quella dell’alcoolista Lucilla alla fine degli anni ’70 del XX secolo, e quella dell’anoressica Anna nel 2012. Accomunate da analoghe vicende di infanticidio materno.
Sartori è sempre stato uno scrittore delle devianze. Ha sempre raccontato figure marginali ed inconsapevoli, raccogliendo il filo di coscienze di sé ottenebrate, di esistenze ripiegate su sé stesse, aggrovigliate fino a perdersi nelle difficoltà del rapporto con gli altri. E si è spesso ispirato a fatti di cronaca nera, dalla cui meccanica prende spunto per affondare il bisturi dell’analisi delle patologie interiori, che però portano sempre oltre i singoli personaggi. La sua scrittura segue il filo rosso di una devianza che conduce – come un destino – fuori di sé, allo sfondo di una società essa stessa “malata”, o meglio patogena, che riduce il singolo alla desolazione e lo induce alla deflagrazione in cui il disastro soggettivo si compie, illuminando però – nell’esplosione – la trama dello sfondo sociale. E qui l’ambiente montano è proprio il segno che delinea l’isolamento delle tre donne: l’emarginazione sociale di Gheta e Lucilla e l’alienazione di Anna.
Di Gheta abbiamo solo qualche sprazzo, tipo quelli che emergono dagli atti di un processo per stregoneria. Ci compare davanti come un ammasso di carni devastate dalla tortura, e negli accenni strappati ed indotti alla sua attività di guaritrice e mammana, dedita all’aiuto delle altre donne del posto, mentre sogna che arrivi qualcuno a salvare lei, magari quel suo figlio – cresciuto forte e sicuro com’era il suo padre di passaggio – che poi sotto tortura ammette di aver soppresso nel sonno, ubbidendo a voci che glielo consigliavano. L’immagine di Gheta che brucia sul rogo “appare” come in sogno a Lucilla, ed è il tramite con la sua storia di sballata di paese, impregnata di uno spirito da anni ’70 che arriva fin sotto le montagne, ma poi non regge l’isolamento. Lucilla affronta sempre più spaventata le prospettive di una maternità idealizzata ma di fatto disperante data la sua concreta situazione, fino a che la scomparsa in un incidente del pur ondivago ed irresponsabile compagno alpinista non la fa implodere. Anna invece è una ragazza di buona famiglia che ha completamente alterato la percezione del reale nell’assunzione su di sé delle aspettative famigliari, tanto da non riconoscere la concreta realtà della sua gravidanza e rimuovere anche il parto, travisato come un semplice disagio fisico.
Le montagne, in questo libro, sono proprio un muro di cinta, ed un sudario di ghiaccio. E la maternità un evento che travolge gli equilibri precari e fa collassare la fragilità delle tre donne. L’universo allucinato che racconta Sartori appare come senza scampo, schiacciato dalla semplice meccanica della vita. La psiche un universo oscuro ed incombente, in cui pure una qualche razionalità – ad un certo punto – sembra anche possibile: quella del giovane psichiatra del manicomio criminale che con un paziente dialogo maieutico riesce a far riaffiorare una consapevolezza in Lucilla. Un mondo che vale allora la pena di provare a salvare, una volta tanto, e con grande fatica (e dolore).

 La necessità cieca della tragedia - Stefano Zangrando
La necessità cieca della tragedia - Stefano Zangrando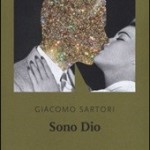 Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo
Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo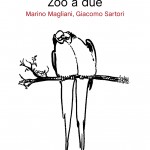 Zoo a due - Redazione
Zoo a due - Redazione





















