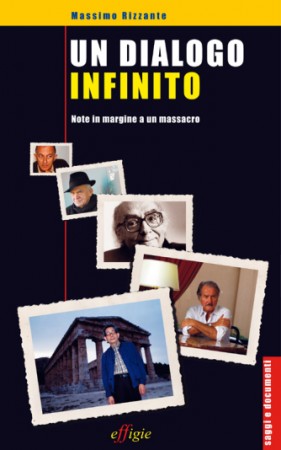
1 .
Negli anni ottanta del secolo scorso ho studiato a Urbino, la città di Raffaello. A quell’epoca frequentavo Palazzo Benedetti, un palazzo rinascimentale situato di fronte al duomo, dove vivevano alcune amiche. Sulla parete di una stanza era stato disegnato – non sono mai riuscito a sapere da chi – un drago. Ho trascorso molte notti in quella stanza. Si può dire che una parte di me, la mia parte poetica, vi abbia ancora fissa dimora. Lì è iniziata la mia personale lotta con il drago che, a differenza del santo della tradizione cristiana, non conduce a nessuna liberazione dal male.
Alla fine degli anni ottanta sono uscito dalla stanza del drago (una parte di me, soltanto una parte). Sono andato a Roma, a Leuven, nelle Fiandre, poi a Nimega, in Olanda, a Granada, a Vienna, a Klagenfurt. A Klagenfurt, nel 1926, era nata Ingeborg Bachmann, la poetessa e scrittrice austriaca morta tragicamente nel 1973 a Roma, dove viveva da diversi anni. Prima di dedicarsi alla prosa, aveva pubblicato due importanti raccolte poetiche: Die gestundete Zeit (Il tempo dilazionato) nel 1953 e Anrufung des Großen Bären (Invocazione all’Orsa Maggiore) nel 1956. Ero fisicamente innamorato di Ingeborg Bachmann, anche se, naturalmente, non l’avevo mai conosciuta: un amore nato da alcune sue foto. Quando sorrideva non riusciva a nascondere la sofferenza. Perché soffriva? L’idea che mi ero fatto è che la Bachmann era una di quelle persone sempre in viaggio, le cui radici affondano più nella loro lingua che in un luogo preciso. Tuttavia le radici della sua arte non prevedono nessuno stravolgimento linguistico. Scrivere, per lei, significava fare del bene, cioè trasformare l’antico in autentico. La sua esistenza era esposta con tale vulnerabilità alla violenza della Storia che il suo grado di compassione nei confronti di chi da quella stessa Storia era stato escluso era pari soltanto alla sua volontà di comprenderlo. Comprendere l’esistenza di qualcuno per una poetessa come la Bachmann significava cercare di immaginarsi il suo dolore. Ed esprimerlo con rigore, fedele in questo al suo maestro e concittadino Musil. Tutto quello che so della lingua tedesca l’ho imparato traducendo una delle sue poesie: Rede und Nachrede (Discorso ed epilogo). Non fu una scelta casuale. Ritrovavo in quei versi le mie notti nella stanza del drago. Così inizia la poesia:
Non varcare le nostre labbra parola che semini il drago
E continua:
Non giungere alle nostre orecchie
fama dell’altrui colpa
parola, muori nella palude
da cui la pozzanghera sgorga
Parola, stai al nostro fianco
più tenera di pazienza
e d’impazienza. Bisogna che questa semina
abbia una fine!
Non domerà la bestia chi ne imita il verso.
Chi svela segreti d’alcova, rinuncia a ogni amore.
La parola bastarda serve all’arguzia per immolare uno stolto.
La parola poetica, per la Bachmann, è una parola di speranza, utopica, ma allo stesso tempo consapevole che la Storia, questa «semina» piena di orrori, non avrà mai fine. Tuttavia, se non si può sconfiggere il «drago» non si deve neppure ripeterne il verso. Il male più grande sta nel volersi liberare dal male, mentre la parola poetica, per quanto aspiri alla purezza, per quanto il suo sogno sia farsi musica, ha il compito etico di accettare il conflitto con pazienza, impazienza, discrezione e senza cedere alla facilità.
Questo comporta per il poeta, come recitano i versi finali della poesia, un sacrificio, un giuramento di fedeltà alla piccola porzione di bene che gli è concessa, a condizione che non rinunci a riconoscere il male. Egli deve mettere la mano sul fuoco che esce dalle fauci del drago. La poesia, in altri termini, non deve aver paura di bruciarsi venendo a contatto con il mondo della prosa, quel mondo che è là fuori, anche qualora dai suoi versi si diffondesse una bellezza molto più desolata, molto meno lirica.
Vieni e concediti,
poiché siamo in conflitto con tanto male.
Prima che sangue di drago protegga l’avversario,
questa mano cadrà nel fuoco.
O mia parola, salvami!
Nel 1990 sono tornato nella mia piccola patria veneziana: sono e resterò sempre un provinciale cosmopolita. L’anno dopo mi trovavo a Parigi, dove sono rimasto qualche tempo.
A Parigi ho fatto molti incontri importanti. Il più importante di tutti è stato quello con Milan Kundera. Sotto la sua direzione, per diversi anni, una volta alla settimana, in modo semiclandestino, si riuniva in un aula dell’École des Hautes Études un ristretto gruppo di lettori di romanzi. Ciò che legava quel- le persone, oltre la loro non appartenenza alla genia degli «agelasti» – categoria umana a cui con il cordone ombelicale hanno tagliato per sempre il senso del comico – era la passione per la bellezza prosaica del mondo, una bellezza che solo il romanzo, secondo quanto mi convincevo sempre di più, può esplorare. E poi un’altra cosa: nessuno, come aveva affermato una volta Ernst Gombrich, si sognava di chiedere alle opere d’arte il loro passaporto… Così scoprii uno dei miei paradossi: sulla soglia della stanza del drago, dove ha fissa dimora la mia parte poetica, c’è un usciere maligno, pieno di lusinghe, tentazioni, ricordi osceni, banalità imprevedibili, il quale pensa che ogni individuo sia intoccabile in virtù della sua infima diversità rispetto a tutti gli altri individui. In altre parole, il custode della mia stanza poetica è un uomo prosaico. Per quanto come poeta non possegga alcuna certezza su quello che scrivo, la mia poesia ambirebbe a coniugare il colloquio con il passato – descrivere un orizzonte dove tutto il passato è presente – a un’investigazione dei luoghi, una sorta di scoperta poetica dei luoghi, che è spesso scoperta di voci poetiche. Ciò significa da una parte mettersi in una prospettiva storicamente millenaria e a volte escatologica (esiste una poesia non escatologica?), dall’altra rinunciare a scavare dentro la miniera della sola tradizione italiana, atto che comporta molti rischi, non ultimo quello dell’eclettismo. Imitazioni, omaggi, traduzioni, commenti posti all’interno di un’opera poetica hanno per me questa funzione: estinguere quel ridicolo monarca chiamato «Io», estinguere quella specie di monarchia chiamata letteratura nazionale. Resto eliotiano (un Eliot illuminato e tradotto da Seféris): «Il sentimento dell’arte è impersonale». E resto gombrowicziano: nel suo Diario, scritto durante gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso in Argentina, afferma che la cultura polacca dovrebbe, per emanciparsi dalla sua «polacchità», abbandonare ogni mito nazionale. Borges, non proprio un poeta e scrittore amato da Gombrowicz, nella stessa epoca pronunciava una conferenza intitolata Lo scrittore argentino e la tradizione nella quale si domandava: «Qual è la tradizione argentina? […] Credo che la nostra tradizione sia l’intera cultura occidentale». Queste parole sono del 1953. Sessant’anni dopo, nel nostro mondo che si vuole così emancipato e multiculturale, non hanno forse assunto un significato ancora maggiore?
4 .
A Parigi ho scoperto poeti che sono diventati per me molto importanti. Tra questi, Czesław Miłosz.
Nell’opera del poeta polacco (1911-2003), ho incontrato qualcosa che in fondo avevo già trovato: una poesia che invece di esprimere sentimenti era una riflessione sulla storia europea.
Fatte le debite proporzioni, anch’io a Parigi mi sentivo un «enfant de l’Europe» (titolo di una sua poesia). Un’Europa che in quegli anni novanta, come cinquant’anni prima, faceva guerra all’Europa. Un’Europa che per festeggiare la fine del comunismo massacrava intere popolazioni e costruiva campi di concentramento. La storia dell’Europa si ripeteva e lo scandalo di questa ripetizione era vissuto a Parigi e altrove come una tragica necessità. Ricordo di aver pensato: se l’oggetto della tua poesia è una riflessione su che cosa significa essere europei nell’epoca della fine del comunismo, la tua ars poetica non può che essere, come affermava Miłosz, «né troppo poesia né trop- po prosa». Inoltre, essa deve avere il coraggio di inglobare le forme più diverse, dalla lettera al ritratto, dal commento alla traduzione, dall’imitazione degli Antichi alla biografia. L’ideale era ed è per me una poesia-zibaldone. Miłosz mi aiutava a disseppellire la «Musa della circostanza» di ascendenza goethiana (autore molto importante per lui). La poesia, mi dicevo, deve aprirsi alla varietà dei contenuti, deve essere cioè in grado di sopportare il peso prosaico della realtà. Ciò non significa che la poesia deve rinunciare alla versificazione, al dialogo con le forme antiche o alla metafora. E neppure al dono dell’attenzione per i dettagli. In un suo saggio autobiografico, La terra di Ulro, c’è un passaggio su cui sono tornato più volte. Miłosz si interroga sul rapporto tra memo- ria e immaginazione. La memoria è sempre stata la madre di tutte le muse.
Da cos’altro nasce l’estasi, in una poesia, in un dipinto, se non da un partico- lare ricordato? E se la distanza è l’essenza del bello è perché la realtà viene purificata dalla distanza […] E la distanza viene raggiunta appunto nei ricordi.
Tuttavia, mi dicevo ancora, l’istante ricordato e il suo svolgimento nel tempo passato non sono la stessa cosa.
Che cosa ricordiamo, scrive Miłosz, di un’azione passata senza l’aiuto del- l’immaginazione che blocca quell’istante strappandolo «alle fauci del movimento? Qual è dunque il potere «capace di ridare vita alle ombre?». Deve essere un’altra memoria «congiunta all’immaginazione».
Questa idea del dettaglio ricordato – essenza del bello –, frutto di memoria e immaginazione, è il miglior viatico a quella poesia di circostanza, fedele alla propria situazione storica e allo stesso tempo in eterno colloquio con la storia passata, di cui Miłosz – come del resto a loro modo Herbert e Różewicz – ha dato prove altissime e di cui io mi sono sempre sentito un «enfant».
Quello che cerco e non trovo nella poesia italiana è il senso storico: una certa empatia con la storia antica e moderna dell’Europa e del mondo; la capacità di colloquiare, come se fossero viventi, con i personaggi più disparati, da Catone l’Uticense all’ultimo dei sudditi di una provincia dell’Impero (di qualsiasi provincia, di qualsiasi Impero); la refrattarietà a coltivare e a far crescere lungo i vetri delle sue serre i rampicanti della follia della Storia.
La poesia italiana è lirica e dolente o è mentale. Oppure, sperimentale! In essa non trovo neppure una vera vena ironica in grado di compatire gli uomini e di fermarsi davanti al mistero racchiuso nei dettagli triviali, osceni, prosaici del mondo: il regno fiammingo dei dettagli, il regno russo dei dettagli, il regno centroeuropeo dei dettagli, il regno di Dio dei dettagli!
Nella poesia italiana mi manca la coscienza della distanza che si misura con la devastazione che il troppo sapere o la brutale assenza di sapere provocano in una natura umana: una coscienza che è respiro naturale e che con un soffio fa crollare il castello di carta della cultura.
5.
Durante i seminari sul romanzo di Milan Kundera la poesia non era un tabù. A causa forse del tema principale di un suo libro, La vita è altrove, Kundera si è fatto una fama di nemico della poesia. Ma non è affatto così. Egli stessoè stato poeta, ha sempre parlato con amore dei poeti cechi Skácel, Nezval, Blatný, è stato un grande amico di Octavio Paz, ed anche recentemente ha dedicato un breve saggio a Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz.
Ora, per Kundera esiste una poesia del romanzo, ma non è quella del poeta affascinato dal proprio io. La «poesia antilirica» che per Kundera è il romanzo moderno non è nemica della poesia, ma combatte fin dalle origini il lirismo: lo sguardo lirico desidera fondersi con il mondo, ma così rinuncia ad osservarlo, ad analizzarlo, a comprenderlo. Ecco, vorrei che ogni mia poesia fosse in grado di contenere una goccia di «romanzo», nel senso kunderiano di «poesia antilirica»: una poesia in grado di mantenere una distanza di sicurezza dall’io.
6 .
A Parigi scoprii anche un altro continente immenso, l’America Latina: il suo romanzo è il più importante della seconda metà del XX secolo.
All’epoca – eravamo a metà degli anni novanta – ho letto un saggio di Octavio Paz, La otra voz, quasi un testamento letterario.
Paz parla della poesia come «antidoto» al mercato. Da dove viene la forza di questo «antidoto»? Per la prima volta, in modo chiaro e ineluttabile, compresi che l’opposizione tra poesia e modernità non è accidentale, ma consustanziale.
Il poeta guarda al passato, a tutto il passato poetico e umano, come una casa aperta. Il suo compito è quello di integrare nel presente, di rendere contemporaneo quell’immenso patrimonio, consapevole che come scrive Paz:
Una poesia può essere moderna per i suoi temi, per il suo linguaggio, per la sua forma, ma quanto alla sua natura profonda essa esprime una voce antimoderna. La poesia esprime realtà estranee alla modernità, mondi e strati psichici che non soltanto sono antichi ma anche impermeabili ai cambiamenti storici.
7.
Non so se siamo alla fine della modernità, già oltre, o, senza saperlo, siamo precipitati all’indietro di secoli. Quello che so è che «l’altra voce», cioè come afferma Paz, la voce che «ha mille anni, la nostra età e tuttavia non è ancora nata», quella voce che ci chiama ma non porta il nostro nome, non deve estinguersi.
[Questo pezzo si trova in Un dialogo infinito di Massimo Rizzante (Effigie, pagg. 258, euro 19)]

 Una solitudine senza solitudine - Massimo Rizzante
Una solitudine senza solitudine - Massimo Rizzante Scrivere tra le nuvole - Enrico De Vivo
Scrivere tra le nuvole - Enrico De Vivo Nessuno va dove vuole - Stefania Conte
Nessuno va dove vuole - Stefania Conte Nel giardino zen del Gobbo Divino. Con una lettera di Gianni Celati del 2013 - Massimo Rizzante
Nel giardino zen del Gobbo Divino. Con una lettera di Gianni Celati del 2013 - Massimo Rizzante Scuola di calore /2
Scuola di calore /2 Il debutto di una società post-umana
Il debutto di una società post-umana Scuola di calore /1
Scuola di calore /1 Dell’amicizia.
Dell’amicizia.






















Splendida pagina, ricca di suggestioni e capace di riconciliare con la scrittura.
Grazie.