Da un ann’e mezzo, mio adoratissimo Carlo, incorpavo questa voglia qui, di venirti a trovare. Sai, son’uno di quei tombarol’impenitenti, morbosi verso le locazioni di morte degli scrittori, specie se poco o nient’impulpitati, quell’audaci penne sul margine. Per cui, pensa che ti ripensa, nonostant’una nottataccia poco dormita sulla groppa, nell’avvio infuocato d’un pomeriggio di fine agosto duemilatredici appigliai l’animo alla risoluzione e via, dritto alla stazione di Porta Garibaldi.
Precisiamolo subito: son’uno che si intriga di molestare la carta a badalucco, da decenni. Seppur stagionatuzzo, autore dilettante direbbesi oggi, qualcosa che, immagino, alle tue orecchie aristocratiche suona proprio sgorbio; come, esiste una forma diversa di scrittura da quella di chi “scrive per diletto”? Carlo mio, oggi le cose non stanno così. Se ti “diletti” d’annerire la carta, agli occhi del mondo sei portator’insano di pressappochismo e selvatico artigianato, afflitto, in sovrappiù, da una vorace atrabile. Aggiungo: vado smargiassando da troppo tempo particolari “perversioni”, che tu, con tutt’il cuore lo spero, se non apprezzare le potrai quanto meno compatire, certe lusinghe luminiscenti di lingua e d’immagini, per capirci. In quest’epoca tra l’insufflante rigurgito realista (la cosa a te non farà specie, tu che hai dovuto confliggere con i Verga, i Capuana; nell’epoca d’oro del “realismo”, però) e l’arcillustre americanità d’accatto — due letterarie malie che tant’affatturano l’Italietta, provinciuccia del grand’impero, nel passaggio dallo stramorto Novecento al secolo nuovissimo (certo, c’era la romanzerìa parigina ai tempi tuoi; con ben altra dentatura, va detto, a petto dell’odiern’americanofilìa) — eppoi, mettici pure, certuni Savonarola apocalittici ed eraclitei, che si piccano, pifferando sghembi com’il profeta Isaia, di arruolare ancora una volta la letteratura per salvar’il mond’e l’umanità tutta, in mezz’a quest’oceano bizzoso e vociante, dunque, com’uno spuntapenne, avanzo mediocre d’usi e costumi fuori moda, mi trovo a naufragare, goccia di inchiostro persa nella burrasca. Perciò capirai bene che l’appalesata alla tua tomba ai miei occhi caccia un odore forte e inequivoco di malinconios’affratellamento; risarcitoria, su, perché negarlo, nella sotterranea speranza di riconfortarm’in parte dalla decisa sensazione che lo stato in cui mi trovo non sia proprio quello che è: un inconfondibile batticulo, una culatterrata di quelle senz’appello.
*
Al telefono m’era stato detto di scendere alla stazione di Corbetta-Santo Stefano Ticino e da lì “c’è il bus che porta davanti al cimitero, il numero….aspetti, sì, quattro”. Vai a fidarti degli sconosciuti; appruato alla stazioncina (due binari, passaggi’a livello; di qua Santo Stefano, di là Corbetta) a una passant’inbiciclettata, compagna nell’attesa dell’alzata di sbarra, chiesi com’arrivar’al cimitero e quella, candida candida, sortì così: «Da qui a Corbetta c’è un chilometro e più a piedi, e poi vai sulla statale e da lì…autobus? Quale autobus?».
Il bruseggio dei pioppeti mi cantilena voci indecifrabili, placido dio del sonno dentro questo spiano prossim’al Ticino, come se marciassi, un elmo di parole e il pettorale di ricordi, vers’il remotissimo paese dei Cimmeri, il tuo domicilio fra le nebbie, Carlo. Non fosse per cert’echeggiare di motoraglie, lo smargiasso d’uno o due garzoncelli, scampati ancora per un po’ alle scolastiche galere in questa tardiva dimora di feri’estive, mi crederei un paladino, agito da chissà quale “amoros’inchiesta”.
Sai, mentre ti vengo incontro, parlo di te con lei, la bestia infetta che da una vita mi lima le carni e senz’ustionarle incendia queste mani: è più d’un vortice, un buco nero in grado di calamitare tutt’e tutti. Se è in buona, l’universo sano te lo fa lampeggiare fra le dita manco foss’una luminaria di paese, ma se ringhia e abbaia, be’, allora è tal’e tanto il suo campo gravitazionale che niente, nemmeno quelle poche cose buone ch’ho fatto nella vita, neppure quelle si salvano. Altro che “amoros’inchiesta”, penso: qui è questione di non ripetere l’errore di Bradamante, che, pur istruita dalla maga Melissa, scelse di salvare il suo falso Ruggiero invece di ucciderlo, e finì per inghebbiarsi nelle caligini del castello d’Atlante fin’a che non s’appresentò, col suo corno arcitruonante, Astolfo, il liberatore. Ecco, mio carissimo Carlo, io quell’errore lì, il passo falso di Bradamante, proprio lo vorrei evitare; anche se questa mia visita di oggi è parte di quell’errare, un vagabondaggio sbagliato, tortuosa sinusoide che rimastica se stessa. Preparerà, ne sono certo, ancor’una volta la beffa capricciosa di Angelica, la cecità assurda della ricompensa che premia Medoro e disprezza il sacrifico e la dedizione di chi fatica e suda: “O Conte Orlando, o re di Circassia, vostra inclita virtù, dite, che giova?”.
D’altronde so bene che la bestia malata, che mi crepa e mi strazia, va nutrita: non posso lasciarla marcire di fame perché mi sbranerebbe, ma neppure poss’impinguarla tanto da farl’obesa, perché altrimenti si sdraierebbe su di me, soffocandomi. Questo mi tocca, quest’equilibrio di digiuni e banchetti, di cibo salutare, per carità niente minutaglie o avanzi, il giusto calore di fibre e vitamine al solo scopo di non mortificarla, ma neppure di metterl’a sedere di nuovo sopr’il suo trono, da dove mi tiranneggia a gusto suo, da troppo tempo. Trovare l’alchimia, magari, che cambi il tossico in miele e gl’artigli in carezze: dimmi, tu l’hai conosciuto quel giorno, l’ore della tregua senza la disfatta, la resa prima dell’ultima sventura?
Proust, nella Prigioniera, a proposito della morte dello scrittore Bergotte dice che ci portiam’addosso un fardello di obblighi contratti, chissà, in una vit’anteriore, un’irragionevolezza di leggi sconosciute cui obbedire perché qualcosa dentro ce l’ha insegnate, una canea rabbiosa di comandamenti che fanno sì che, pur cadavere, Bergotte continui a non morire. Ma prima, esangue e moribondo, tu scrivi e nel farlo trovi ancora linfa, pur proseguendo, giorno per giorno, a dissanguarti.
Il distacco, l’istante fervido dell’addio, che t’avrà ghiacciato le vene, tu l’hai provato, non è così? Lo sento leggendo le prose di Amori, il tuo congedo pubblico dalla letteratura. Dentro c’è un ripiegamento malinconico e solare, privo del mercurio che altrove hai seminato senza risparmio; l’eleganza sovran’e silenziosa d’un’ametista, la lucentezza di ciò che levigat’e diafano si seppellisce da vivo, continuando a mandare lampi da un oltremondo, incomprensibili per i più.
Ecco l’interminabile budello d’asfalto, condito da campi di granturco alternati a filari di villette: la tanto bramata “statale”. Mentre Febo mi martell’in testa, domando di te; devo aver elett’il giro più lungo, molto, ma molto lontano dal centro del paese, è evidente. Tornar’indietro non si può, tropp’ho camminato finora. Pazienza per le mie gambe sfrante: è prassi del periferico la circumnavigazione del semplice. Star’alla larga dalla via più breve, dal fuoco comun’a tutti.
D’altra parte è la tua idea di letteratura: lo sviarsi, l’indirizzo costantemente centrifugo, rispett’all’irrazionale mania centripeta che sempre signoreggia. Prendi anche la sublime lezione di Montaigne: per sei mesi mi son’attardato nel suo corpo, è stat’un maestro, una guida, un secondo padre per me. Quasi una segnaletica, per riprender’un immagine proustiana; un ingarbuglio misterioso e silente di simboli e indicazioni che mi consentono d’essere letti così: sei sul giusto sentiero, per quanto deserto e buio e muto, vai avanti, non ti sfiduciare anche se la tua voce non trova mai eco, anche se le tue parole non conoscono fratellanza. Quel suo capitoletto, brevissimo, nel secondo libro, dedicat’unicamente ai pollici, ci pensi, Carlo; è qui la chiave ricca dell’autentic’ardore, qui l’architrave d’una cattedrale di parole che voglia sopravanzare l’inessenzialità connaturata ad ogni presente, il vaniloquio del “qui ed ora”, del “presto e in fretta”, dell’“utile e giusto”. Non c’è divario fra utile e innecessario, il confine è annullato: la scrittura che studia se stessa scrivendosi è la sola, unica possibilità di indagine del mondo, l’egoismo sommamente immorale che rifiuta il dogma moralistico dell’utile. La letteratura “utile” per il mondo cerca sempre un centro di gravità, non si dirama ma si concentra, si fonda sulla necessità e sul sintomo e non sul valore in sé, sulla profondità ch’è rischio, sul rischio ch’è solitudin’e assenza di risposte, sul tempo misurato non con la tua stupida vita, non con questo presente, la già marcita rinomanza che ti introna e lusinga. Carlo mio, tu lo sai bene: la letteratura che perseguono costoro è letteratura che “serve”, è letteratura schiava. Solo perché strumento di indagine instancabile di sé, solo come metodo di ricerca senza procacciarsi una ragione o una collocazione, men che meno un risultato certo, soltanto quando la parola usata è inutile, sol’allora ha davvero valore. E invece, ancora oggi, stiamo qui a vergognarci di scrivere per il desiderio unico di farl’e punto, a contristarci se scrivendo disertiamo la “realtà”, patendo per il prurito frivolo di scombiccherare carte mentr’il mondo patisce crisi guerre e cataclismi (sempre diversi e sempre uguali), con quest’artificio, un caleidoscopio di finzioni, pretendendo di perorare la causa del “cambiamento” perché non ci basta la cura di noi stessi, la letteratura ci appar’un piacere disonesto, una sgorbia attitudine da parassiti, una segreta colpa da espiare, un peccato di vanità da scontare con l’esercizio dell’altruismo, poco più d’un otre flaccido da gonfiare con l’interessamento per le sorti del mondo. Pensa te: dire la “verità” usando la finzione, copulare facendo il voyeur, illudersi d’aver’il dominio sulla menzogna vischiosa e l’ambigua opacità ch’ogni parola irrimediabilmente porta con sé, un ordigno fedigrafo, queste belle lettere, da cui si pretende la sacralità del demiurgo, ripudiando l’ironia e il disincanto del giullare, l’amarezza furiosa del condannat’a morte, il compianto velenoso dell’orfano. Com’è che hai definito l’ironia? “Quell’arte che con le lacrime agli occhi sorride”. Altra cosa dai santoni e i profeti, ben diversa dai gozzovigliatori e gli arruffapopolo, gl’uni sposat’agl’altri, talvolta. I vasi sileni, così chiama un tuo lontano progenitore, Rabelais, la sua opera; talquale la faccia scarduffata e bislacca d’un Socrate, che dentro tien’in custodia certe preziosità sconosciute senza farne sbafantìo, però. Senz’atteggiarsi da predicatore: l’ultimo degl’ultimi luterani che sermoneggiano.
Ne sono arciconvinto, sai, e da moltissimo tempo: il ver’amore per la letteratura nasce solo dal disprezzo, perché solamente svilendola e sbeffeggiandola le restituisci quell’umana dignità di fragilissima cosa. Diffido di chi non ha mai provato un sano odio per l’inganno e la menzogna dell’artificio letterario: ne ha amato e posseduto la superficie, tenendosi alla larga dai suoi abissi.
Stremato m’approssimo al luogo. Una panchina; mi siedo. Respiro; per un bel mezzo mi mett’a scrutare l’avant’e indietro di vivi in visit’ai morti. Non faccio altro che respirare e guardare, sedut’all’ombra, credo, d’un tiglio.
Apro questo breviario corpulentissimo che mi port’appresso, un Baedecker per disorientarmi: un’opera, che la legga o la scriva, se non mi confonde e mi smarrisce è un viaggio che non vale la pena d’essere affrontato. Le tue Note azzurre, mio amatissimo Carlo; me le sfoglio ancora e ancora, cerco le pagine già a lungo tormentate, torno indietro, mi fermo, incantesimato pensadoti lì, oltre quella cancellata.
La n.4818, ad esempio: “È una repubblica, la letteraria, in cui ciascuno vuol essere re assoluto”. Eppoi quella sugli scrittori in voga: contentiamoci, Carlo mio, dell’esaurimento nervoso per le “troppe protratte meditazioni”, a petto degli scrittori medagliati, esauriti sì, ma di intelligenza, per non aver mai meditato nulla.
Lo inserro. Mi fa troppo male pensare come s’infartuò questo libro mastro; l’ictus, che ti inebetì nella primavera del novecento otto, t’incancrenì anche la destra. Penso a quelle note, due, fra tutte, lancinanti; il ritorn’a Milano, morto il tuo Luigi Perelli, quand’il passato è una terra devastata da un nemico perfid’e oscuro, che recalcitra, spergiura e insulta, e soprattutto l’altra, due anni prima della tua morte, prossima al colpo che ti ferì. La mia testa, non volendo, frastuona ancora, nel rimbombo mi flauta quelle poche frasi che ho serbato per soffrirne, che non dimentico al solo scopo di ridestare la cenere dentro gli occhi, sul palmo delle mani: “Ho 58 anni (e ne avrò 59 ai 27 di marzo) e sono in continuo peggioramento…tra poco, forse questione d’anni o di mesi, mi dissiperò, e ridarò le mie spoglie alla terra…ero nato alle lettere, alle scienze archeologiche, ma non ebbi coraggio di tendere ad un unico scopo l’arco della mia mente…molte grandi, molte belle cose disegnai, molte abbozzai, nessuna ho compiuta”.
È tempo d’alzarsi. Ti vengo a cercare.
*
«Dossi, sì…Carlo Dossi, è uno scrittore…».
Dentro la guardiola fortissim’è l’odore d’aglio; si mescida al sudor’e al caldo, smorzat’appena da un ventilatorino che s’affanna in un angolo. I due, russi o rumeni, restano di princisbecco, ripetono di nuovo:
«…morto…sicuro? Poco tempo, allora?»
Macché: più di un secolo, nel novecentodieci.
«No possibile…non trovo…»
Entro; indago il monitor, di fianc’a una brandina sfatta. Sì, è vero; nessun Carlo Dossi. Ma avrà una cappella gentilizia, figuriamoci. Rimbeccano: le cappelle sono in un elenc’a parte e Carlo Dossi non c’è.
Esco. Le gambe e l’insonnia mi bestemmiano. M’illumino:
«Cerca Pisani…non Dossi…sì, esatto: Alberto Pisani, la famiglia Pisani…».
Che tiro mi stavi giocando: eccoti, la quarta da sinistra. Da vivo, mi sovviene, facevi lo stesso quando pubblicavi come “Carlo Dossi” ma ti battezzavi pubblicamente “Alberto Pisani”: più d’uno fu menato per il naso, credette a due scrittori diversi, eggià.
Vicin’all’ingresso si slingua un gatto, goduriosamente, con dovizia indugiando sulle parti basse, spaparanzat’al sole. Pochi metri più in là, la barbuta faccia d’un bonomasso viene torturata da una matrona, che lustr’e arcilustra con uno straccio quell’ovale, la fotografia incravattata dell’uomo sopr’una lapide; per molto, moltissimo tempo una furia, vedessi, che ha tutta l’aria di volersi far condonare qualcosa oppure la fregola d’una punizione oramai stantiva, consumat’in segreto e adesso goduta senza delizia alcuna.
Nel Campionario tu distinguevi nettamente la gloria dalla reputazione: la prima si fonda sul “dubbio amore della posterità”, una lotteria che fa ricchi i “non nati e immeritevoli eredi”, un premio estratto dopo la morte del vincitore, mentre la reputazione è l’usufrutto del presente, capitale e interessi inclusi, tanto che non ne rest’un spicciolo per i posteri. Ha un sapore di morte l’amore della gloria; parlando del pittore Elstir, in All’ombra della fanciulle in fiore, si dice qualcosa di simile. Quant’è triste questo pittore, che ha preso l’abitudine di situare le sue opere “in un’epoca in cui egli stesso non sarà più che polvere”; è costretto a riflettere sul nulla, l’idea della gloria ha il sapore della tomba. Un sapore rancido.
Scrivo me stesso, scrivo per nessuno: l’unica scrittura possibile, l’anacronista. Quando hai pubblicat’a tue spese e in privato, nel novecentosei, quel frutto tardivo, di compensazione e riepilogo, che è la Fricassea critica, ti dilettasti a spernacchiare le boccucce sapienti come quelle plebee: “colui, che non scrive per pochi, finisce presto a non essere letto da alcuno”. Proust, nel Contro Sainte-Beuve, la pittura in modo ancora più drastico, tu l’approvi, ne sono certo: “c’è una sola maniera di scrivere per tutti: scrivere senza pensare a nessuno in particolare, per quello che si ha in sé di essenziale e di profondo”.
M’annaso contro tutto questo ferrume. Il vetro m’opacizza lo sguardo; di tombe, appigionate l’una sull’altra, ne scorgo diverse. A sinistra, Paola Pisani Dossi Caccia Dominioni, morta nel 1986, sotto Franco Alvise Giuseppe eccetera eccetera, c’è un’epigrafe, poi, celebra il restauro nel novecento ventitré, eppoi su in alto, a destra, Giuseppe Pisani Dossi, tuo padre, “l’intemerata laboriosa vita”, sotto di lui Ida Pisani Quinterio, tua madre, e più in basso il “nobile uomo” (già, eri un conte, mica no): Alberto Carlo Felice Pisani Dossi.
patrizio alessandrino
letterato diplomatico archeologo
vivo
accrebbe gloria al nome degli avi
morto
permane lume eccitatore a’ nepoti
Siedo sui gradini. Lascio che il sudore e la pena si disfacciano, poco alla volta. Imprevista tenerezza nel corpo, ora. Un istante sospeso, acrobatico passeggia nell’aria; solamente fumo, sembra, benedetto, però, da un vent’immaginario che lo rapisce e lo scompiglia per farlo leggero, stemperando quest’arsura.
Non c’è realtà da scrivere, Carlo, tutto questo non esiste, tu ed io lo sappiamo. Vorrei leggerti delle pagine, parole non mie, parole che ti dicono quello che già sai, ma consentono a me di rimanere qui, in questa veglia stanca, ascoltandomi senza provare ribrezzo per me stesso.
“Cercherò di tradurre la mia povera anima, se non sarà morta nel frattempo” scrive Proust a Maurice Barrès, nel marzo mille e novecentoquattro. Lo rammenterà bene, anni dopo, raccontando della sosta, e che sosta, prima dell’ingresso al ricevimento Guermantes, nel Tempo ritrovato. Se la realtà è questa, questa che vediamo, “un tempo cattivo, una guerra, un posteggio di carrozze, un ristorante illuminato, un giardino in fiore”, se questa è la realtà da raccontare, be’, allora la letteratura è solo un “fuor d’opera”, un accidente inutile, vacuo, un artificio insensato. No, non è questa la letteratura, perché la realtà, quando scrivi, non esiste, non è mai esistita: “il libro essenziale, il solo libro vero, un grande scrittore non deve, nel senso corrente del termine, inventarlo, bensì, visto che esiste già in ciascuno di noi, tradurlo”.
Scrivendo tradurre se stessi, per un’intera vita: pensa a Montaigne. Se qualcuno ti dice “stai avvilendo le Muse, amico mio, se te ne servi per gioco e passatempo”, be’, costui non sa quanto vale “il piacere, il gioco e il passatempo”. Vivo per me stesso, i miei disegni finiscono lì, dice: ma è un piacere non privo di pericoli la parola scritta, dolorosissimo, come tutti i piaceri.
Aggiungo: il più doloroso proprio perché il più etereo. Giustificarlo non ha senso. Non si giustifica il desiderio. Non chiedi scusa per il fatto di respirare.
Perché il piacere, mi dico, è l’unica misura del dovere, se t’accingi a sporcare la carta. Quello che gli metton’intorno per puntellarlo è soltant’un fiacco pretesto: che sia la posa statuaria del ministro di culto o la malcelata iattanza del modestino oppure il bieco tornaconto oratorio, logoro mercenariato da sgualdrine ammantate del rossore più verginello come del più malandrino trasporto da barricaderi.
Basta, ho ricamato a sufficienza, Carlo mio. Quest’ennesimo fiore di carta. Lo lascio qui.
Mirabolanti, fragili fiori. Simili a quelli che si portan’ai morti.
Dentro c’è l’amore non detto, l’affetto non dato, il ricatto del rancore e della malinconia, tutt’un caos di pietà e dispetto e speranza e malanimo e, poi, dietr’uno spento sorriso colmo di comprensione, il più languido terrore che tu possa mai immaginare.





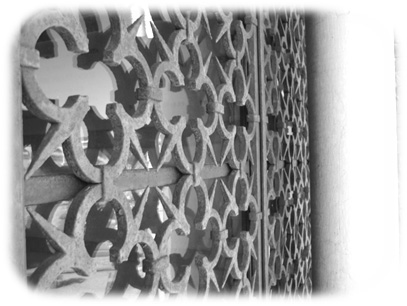
 Cassiodoro/ 1 - Danilo Laccetti
Cassiodoro/ 1 - Danilo Laccetti Sallustiana/ 1 - Danilo Laccetti
Sallustiana/ 1 - Danilo Laccetti Nella neve perenne/ 2 - Danilo Laccetti
Nella neve perenne/ 2 - Danilo Laccetti La scrittura nel dietroscena
La scrittura nel dietroscena Tadmor
Tadmor Calame persta
Calame persta Pavese/ 1
Pavese/ 1 Pavese/ 9
Pavese/ 9





















