
GIOVANNI ACCARDO: Il tuo esordio è all’insegna di Tolstoj, un grandissimo romanziere ma anche un educatore, visto che nel 1859 fondò una scuola per i contadini a Jàsnaja Poljana. Approfittò di un viaggio in Europa per accompagnare sulla Costa Azzurra un fratello ammalato di tubercolosi, per visitare scuole, discutere con pedagogisti, raccogliere persino i quaderni degli scolari, senza tuttavia trovare quello che cercava. Era convinto che il progresso del popolo russo dovesse nascere dall’istruzione. Per Tolstoj la scuola doveva diventare un luogo di libera formazione e l’educatore non doveva esercitare nessuna forma di autorità e nessuna influenza ideologica. Insomma, l’unico criterio della pedagogia era la libertà e l’unico metodo l’esperienza. In questa concezione c’è molto della tua idea di scuola.
ERALDO AFFINATI: Esistono libri che si leggono una volta sola e quelli che ti restano dentro come cicatrici interiori, fiamme perennemente accese. Spesso ci ritorni: loro sono sempre uguali,tu invece non sei più lo stesso. Ripercorri così le stagioni della tua vita. Guerra e pace è stato per me uno di questi libri: non a caso ho esordito con Veglia d’armi. L’uomo di Tolstoj (Marietti 1992; Mondadori 1998). Leggerlo in gioventù può risultare determinante. Ricordo che non riuscivo a staccarmi dalle sue pagine, giorno e notte. Credevo di essere Andrej, idealista kantiano, l’ufficiale ferito sotto il cielo di Austerliz. Solo col tempo compresi che il mio personaggio era Pierre: l’uomo che si sporca le mani nella Mosca incendiata. Stavo dalla parte del generale Kutuzov, anche se Napoleone mi affascinava. Tuttavia, se avessi dovuto scegliere fra il vecchio generale stanco e disilluso e il figlio dell’Illuminismo francese, non avrei avuto dubbi: ero già segnato dal giudizio sprezzante che Giacomo Leopardi aveva formulato nei confronti delle “magnifiche sorti e progressive”. Se oggi ripenso a quel formidabile romanzo, prima ancora del paesaggio russo, che ho poi realmente conosciuto, quasi inseguendo l’emozione letteraria, mi viene in mente la stanza vuota della mia adolescenza, cioè il luogo in cui divoravo l’opera. Leggevo disteso a letto, ogni tanto mi alzavo e aprivo la finestra: il panorama era triste. Un casamento spoglio, grigio, privo di ogni attrattiva. Non avevo amici. Non parlavo con nessuno. Avevo abbandonato la pratica di qualsiasi sport. Lasciavo che le giornate scorressero su di me rinunciando a fare progetti. Ero stato conquistato dal genio del maestro di Jàsnaja Poljana.
GIOVANNI ACCARDO: Nella tua letteratura c’è una grande tensione morale ed etica che fa dello scavo nella memoria e della ricerca nella storia uno dei nodi centrali della scrittura. Cercare nella storia e scavare nella memoria non significa compilare cronache o resoconti, ma tentare di risalire il fiume che conduce alla sorgente dell’essere umano, spiegandone comportamenti e reazioni, soprattutto quando l’uomo si trova di fronte all’orrore o vive l’esperienza del limite; un’attività prossima a quella dei grandi etno-antropologi che mi fa pensare ai viaggi di Malinovsky o a quelli di Levi-Strauss. Per te scrivere non è mai inventare, o almeno non completamente, la scrittura, al contrario, si alimenta dell’esperienza, che non è solo quella tua, ma quella della tua famiglia, i tuoi genitori, tuo nonno e la tua famiglia ideale, ovvero gli scrittori amati.
ERALDO AFFINATI: La scrittura per me è l’ultimo anello di una lunga collana di esperienze, emozioni, idee, errori, sconfitte e vittorie. Non dovrebbe mai essere strumentale, subordinata a qualcos’altro, ancella o servitrice dell’idea, dell’azione, o della trama narrativa. Per me la letteratura non è un’alternativa alla vita, semmai è l’intensificazione dell’esperienza. Non potrei mai “inventare” una storia a tavolino, per scrivere ho bisogno dell’esperienza.
GIOVANNI ACCARDO: E proprio dall’esperienza nasce Campo del sangue, il libro che nel 1997 ti ha rivelato al grande pubblico, sorta di diario del tuo viaggio ad Auschwitz,dove memoria familiare, esperienza personale, lettura di libri s’intersecano. A farti da guida sono stati alcuni dei libri fondamentali per capire la Shoah.
ERALDO AFFINATI: Ho compiuto il viaggio da Venezia ad Auschwitz nell’estate del 1995, cinquant’anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con mezzi volutamente poveri: a piedi, in autobus, in autostop, in treno. Intendevo guadagnarmi un ritardo rispetto alla meta che avevo scelto. Chiesi a due miei amici, Plinio Perilli e Eusebio Ciccotti, di venire con me perché volevo uscire dall’individualismo tipico dello scrittore. Si tratta di un’esigenza che ho sentito anche al momento della scrittura, quando, tornato a casa, ho provato a mettere mano agli appunti presi durante il percorso. È stato in quella fase che il libro, tassello dopo tassello, ha preso corpo come un mosaico, attraverso il confronto tra la mia voce e le centinaia di cronache che avevo letto: dai testi famosi di Primo Levi e Robert Antelme, alle testimonianze di Améry, Semprun, Wiesel, Borowski e moltissimi altri, compresi i grandi cronisti del gulag, da Gustaw Herling a Aleksandr Solzenicyn. Quello che avevo scoperto, avanzando fra l’Austria, la Slovacchia e la Polonia, non riguardava una sola persona ma chiamava in causa tutti noi, come cittadini appartenenti alla generazione dei reduci di pace, per l’appunto, i nati dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Campo del sangue mi ha lasciato un senso di coralità di cui avevo oscuramente bisogno, una sensazione che ho provato soprattutto dopo l’uscita del libro, quando ho cominciato a presentarlo nelle scuole italiane. Parlando coi ragazzi mi sono reso conto dell’importanza che assume la consegna del testimone del ricordo. Con la scomparsa dei protagonisti diretti della Shoah, se non ci saranno altri individui pronti a raccoglierne la memoria per trasmetterla ai più giovani, ciò che accadde nel cuore dell’Europa civilizzata, lo sterminio industriale di milioni di esseri umani colpevoli soltanto di esistere, potrebbe essere dimenticato.
GIOVANNI ACCARDO: Tema centrale del tuo libro è quello della responsabilità collettiva e individuale, cui ritorni con un altro libro che ha ancora il suo cuore nella Germania nazista e ancora una volta si alimenta di una ricerca che è quasi un pellegrinaggio nei luoghi in cui visse il protagonista, mi riferisco a Un teologo contro Hitler (Mondadori 2002), il libro sul teologo Dietrich Bonhoeffer ucciso dai nazisti a Flossenbürg.
ERALDO AFFINATI: Dobbiamo pensare a un concetto di responsabilità nuova, non soltanto giuridica, quella di cui parla ad esempio Dostoevskj quando scrive: «Io mi sento responsabile non appena un uomo posa il suo sguardo su di me». Questo tipo di responsabilità fu disattesa ad Auschwitz ed è ancora oggi disattesa da molti di noi, perché quel tipo di responsabilità, che io chiamerei assoluta, è pre-sociale, pre-morale, pre-giuridica, viene prima di tutti i sistemi e distingue l’uomo dall’animale. Se tu ti senti responsabile dello sguardo altrui, è come se ti sentissi responsabile anche dei contesti nei quali operi, non soltanto della tua professione. A quel punto puoi evitare l’ingiustizia, perché è facile reagire quando l’ingiustizia capita a noi ma è più difficile quando riguarda un principio che ritieni oltraggiato, quindi qualcosa che non riguarda te stesso ma magari la persona che ti sta vicino o addirittura uno sconosciuto. Ecco la ragione per cui prima dicevo che Auschwitz riguarda l’oggi, non ieri; perché questo tipo di responsabilità, che è la vera responsabilità umana, lì non c’è stata. Il modello di Dietrich Bonhoeffer è stato per me molto significativo, non tanto per il suo gesto eroico di contrapposizione frontale al nazismo, quanto per le indicazioni che egli ci ha dato assai prima di salire sul patibolo di Flossenbürg. Stiamo parlando di un uomo cresciuto in una famiglia aristocratica, non particolarmente religiosa (il padre era agnostico), il quale mise a disposizione dei più deboli il suo privilegio, non esitando a sporcarsi le mani pur di partecipare alla vita sociale del suo tempo. Un individuo pieno di vitalità, intelligenza e passione che invita a pensare Cristo in forme assolutamente nuove, nel secolo dell’infamia, immaginandolo Padre amorevole ma non troppo possessivo, desideroso semmai che l’uomo si assuma le proprie responsabilità, senza evaderle nel Suo nome. Ho inseguito i fantasmi di Bonhoeffer nei luoghi in cui lui visse o soltanto transitò: da Berlino a Roma, da Stettino a Monaco fino a New York, che ho visitato appena un mese dopo la tragedia delle Twin Towers. Fra targhe commemorative, libri, testimonianze e fotografie credo di aver realizzato con lui quella che Ugo Foscolo chiamava una “corrispondenza d’amorosi sensi”, la “celeste dote” che il grande poeta attribuiva agli umani. Se oggi riuscissimo a realizzare questo tipo di responsabilità assoluta, avremmo realizzato l’unica vera rivoluzione, fra tutte quelle fallite nel Novecento. L’insegnante e lo scrittore hanno proprio questa responsabilità, quella della parola per esempio: io sono un insegnante e come insegnante cerco di mettere in pratica questo tipo di responsabilità perché quando entro in aula e parlo con i ragazzi, mi accorgo e so perfettamente che quello che dico può incidersi in modo indelebile nella percezione dell’adolescente che ho di fronte. Lì davvero eserciti una responsabilità assoluta.
GIOVANNI ACCARDO: Dalla tua esperienza di insegnante è nato il romanzo Secoli di gioventù (Mondadori 2004), un libro dove compare proprio il tema della responsabilità come incontro con lo sguardo dell’altro, ma dove ritorna il nazismo, attraverso uno studente naziskin.
ERALDO AFFINATI: Il narratore di quel libro è una trasfigurazione di me stesso. Il libro nasce da un incontro reale, nel senso che il personaggio di Rosetta è la sintesi fantastica di alcuni miei alunni. La scintilla che ha dato origine al libro coincide con la scintilla che aveva negli occhi uno di questi alunni quando mi disse che facendo degli scavi vicino casa sua, avevano trovato i resti di alcuni soldati tedeschi della Seconda guerra mondiale. Da questo episodio reale ha avuto inizio il romanzo:dagli occhi di Rosetta. Solo l’incontro con l’altro permette al tuo io di mettersi in gioco, di aprirsi e scoprirsi, di conoscersi e capirsi nel profondo. È la lezione, tra gli altri, di Levinas. Facendo l’insegnante sono costretto a mettermi in gioco, a giocare con i ragazzi a carte scoperte, senza barare. Negli anni ho compreso che il rapporto tra il professore e gli alunni può essere l’avanguardia, il paradigma di tutti i rapporti umani. Io vorrei parlare con gli uomini così come dialogo con i miei alunni, riuscendo a essere autenticamente me stesso.
GIOVANNI ACCARDO: Ancora dall’esperienza di insegnante nasce un libro che ritengo cruciale nella tua produzione, La città dei ragazzi (Mondadori 2008), frutto dell’attività di insegnante nell’istituto professionale che c’è all’interno della “Città dei ragazzi”, la comunità educativa fondata nel secondo dopoguerra da un sacerdote irlandese, monsignor Carroll-Abbing, per dare un tetto agli orfani italiani. Venne concepita come una repubblica gestita dagli stessi ragazzi, i quali eleggono un sindaco, hanno una moneta locale, insomma si autogestiscono. Un tempo erano italiani,oggi sono in grande maggioranza stranieri: minori non accompagnati che vengono dall’Asia, dall’Africa e dal mondo slavo. Tra l’altro hai scelto volontariamente di andare ad insegnare nella “Città dei ragazzi”: come mai?
ERALDO AFFINATI: Volevo guardare negli occhi questi ragazzi, capire chi sono, conoscere le loro storie, mettermi in gioco personalmente, misurare la febbre del nostro mondo. Grazie a questa esperienza straordinaria ho potuto capire che la scuola italiana corrisponde soltanto in minima parte alla sua immagine mediatica. Vedo professori che non si limitano a svolgere il mansionario, che si mettono completamente in gioco, che rischiano. Ed esistono ragazzi e ragazze che sono come spugne, pronte ad assorbire l’acqua che tu riesci a versare. Le televisioni e i giornali non hanno gli strumenti percettivi in grado di intercettare questa potenza e si riducono a trasmetterci i segnali dell’inquietudine quotidiana, della violenza, della stupidità, senza rendersi conto del colossale mutamento che sta avvenendo. Le teste dei ragazzi sono cambiate. Gli adolescenti ragionano in forme nuove, diverse da quelle di un tempo. Hanno concentrazioni d’altro tipo. Sviluppano connessioni logiche associative più che deduttive. Possiedono energie segrete. Provano emozioni nascoste. E noi siamo ancora lì, coi vecchi schemi ideologici totalmente inadeguati. I ragazzi afghani, magrebini, africani e slavi mi hanno insegnato che, dopo essere caduti, ci si rialza in piedi. E si continua a correre.
GIOVANNI ACCARDO: Il libro racconta anche il viaggio che hai fatto insieme a due tuoi allievi, Omar e Faris, in Marocco, la terra da cui sono fuggiti poco più che bambini. Perché hai voluto riaccompagnarli a casa, nella loro terra d’origine?
ERALDO AFFINATI: Volevo diventare straniero come sono loro qui da noi. Solo così avrei potuto capire davvero quello che provano. Alla sorgente del fiume, non alla foce. Quando ho conosciuto, nel deserto arabo, le loro famiglie, ho visto l’amputazione spirituale che questi adolescenti subiscono. Già in quel viaggio c’era dentro di me don Milani, anche se io non lo sapevo.
GIOVANNI ACCARDO: Insegnando a questi ragazzi, difficili sia per ragioni linguistiche che sociali, ragazzi soli e senza famiglia, hai sentito il bisogno di elogiarli, prenderne le difese, mettendo in discussione una scuola che boccia i più deboli, o per dirla con un altro dei tuoi “maestri”, don Lorenzo Milani, una scuola che fa parti eguali fra disuguali. È nato così Elogio del ripetente (Mondadori 2013). Chi è il ripetente e perché hai avvertito la necessità di elogiarlo?
ERALDO AFFINATI: Il ripetente è spesso un alunno con problemi familiari o personali che di certo non va giustificato, ma noi adulti dobbiamo capire che, se lui sbaglia, non lo fa mai da solo, bensì sempre insieme agli altri. Assumere il suo punto di vista, come ho fatto io in questo libro, significa interrogarsi su ciò che non funziona non soltanto nella scuola italiana, ma anche nella nostra società. Il ripetente, paradossalmente, può regalare le maggiori soddisfazioni all’insegnante che sia in grado di restituirgli un po’ di fiducia in se stesso. Questi studenti spesso non hanno mai avuto di fronte adulti credibili. Sono cresciuti nel vuoto dialettico, eppure conservano una grande capacità di rinascita. Il peggiore dei miei studenti compie comunque un passo in avanti rispetto alla situazione familiare da cui proviene. Sono stato anch’io un ragazzo difficile, figlio di due genitori orfani e che non erano andati a scuola. Anch’io, come gli studenti che racconto, non avevo le parole per capire me stesso e la mia storia. Studiare mi ha dato le parole.
GIOVANNI ACCARDO: Vorrei ritornare al tema della responsabilità. Credo che uno dei compiti essenziali della scuola non sia quello di preparare i giovani al mondo del lavoro, semmai di educarli alla vita, facendone cittadini maturi, consapevoli e responsabili, abituandoli a riflettere e ragionare sui problemi che quotidianamente incontreranno, senza farsi prendere da quegli isterismi che abbondano nei talk-show televisivi. Come si fa a rendere responsabili gli studenti, soprattutto quelli difficili?
ERALDO AFFINATI: Bisogna conquistare la loro fiducia. Essere amici e maestri: cioè da una parte abitare il mondo adolescente, dall’altra conquistare la distanza necessaria per incarnare i limiti che il ripetente non sa rispettare. Purtroppo l’insegnante oggi è rimasto da solo a fare questo perché i quindicenni che ha di fronte sono lusingati dai miti del successo, della bellezza, della sanità e soltanto dentro l’aula dovrebbero essere concentrati, rigorosi, attenti. Ecco perché nella solitudine del professore si rispecchia quella del ripetente. Ma se anche noi, come lui, ci abbandonassimo allo sconforto, andrebbe alla deriva un’intera generazione.
GIOVANNI ACCARDO: Come possiamo appassionarli allo studio o alla lettura, dove, stando ai dati OCSE, gli italiani sono messi piuttosto male?
ERALDO AFFINATI: È necessario trasformare la lettura da compito scolastico a esperienza conoscitiva. Io racconto i tentativi che ho fatto, a volte spericolati, come quando convocai gli studenti in una libreria di Roma per fargli comprare Se questo è un uomo di Primo Levi. Feci l’appello di fronte agli scaffali sotto lo sguardo incredulo dei clienti. Erano ragazzi di borgata che non avevano mai affrontato un testo completo. Vederli fare la fila alla cassa è stato uno spettacolo. Dentro di me ho sentito un brivido: mi sono reso conto che noi stiamo vivendo una crisi etica, prima ancora che economica.
GIOVANNI ACCARDO: Da questa lunga esperienza con gli studenti difficili, ma soprattutto con i minori non accompagnati che arrivano da tutti le parti del mondo, è nata l’idea di fondare la “Penny Wirton”, una scuola di italiano per stranieri.
ERALDO AFFINATI: Penny Wirton e sua madre è un racconto di Silvio D’Arzo in cui il protagonista fugge di casa per sottrarsi alla vergogna di non avere avuto un padre nobile, per poi tornare e ritrovare nell’amore della madre la dignità della propria condizione umana e sociale. Penny Wirton è la metafora di ogni immigrato che ha lasciato le proprie radici, che ritrova l’amore della madre nell’apprendere una lingua che non è la sua, non è quella materna. La Penny Wirton è una scuola senza classi, senza voti, senza registri, basata sull’uno a uno. I docenti sono volontari che prestano gratis la loro opera,a fondo perduto, potrei dire. All’inizio eravamo io, mia moglie, Anna Luce Lenzi (con la quale ho scritto Italiani anche noi, manuale di apprendimento dell’italiano pubblicato dalla casa editrice Il Margine di Trento) e pochi altri. Oggi siamo centinaia, non solo a Roma, anche in Calabria, in Veneto, Toscana, a Milano e a breve forse anche a Bolzano.
GIOVANNI ACCARDO: Una scuola che ricorda molto quella di Barbiana fondata da don Lorenzo Milani, i cui insegnamenti tornano spesso nella tua opera e nelle tue riflessioni. E proprio a don Lorenzo hai dedicato il tuo ultimo libro, L’uomo del futuro. Sulle tracce di don Lorenzo Milani (Mondadori 2016). Mi viene in mente quello che diceva Pavese a proposito de La luna e i falò, quando affermava che era il libro che si portava dentro da più tempo. Forse si può dire la stessa cosa per questo tuo libro.
ERALDO AFFINATI: Io, prima ancora di aver letto Lettera a una professoressa, ho sentito la presenza di questo grande educatore negli occhi dei miei studenti. In trent’anni di insegnamento, soprattutto negli istituti professionali, era come se Romoletto e Santino, insomma i miei ragazzi più indisciplinati e ribelli, mi avvertissero: prof, guarda che fra qualche anno dovrai occuparti di lui. E così è stato. La prima volta che ho pensato di scrivere il libro è stato di fronte alla salma di Mao a Pechino, lì ho pensato a Pipetta, il compagno comunista di San Donato di Calenzano, al quale don Lorenzo spedì forse la sua lettera più bella, secondo me uno dei gioielli della letteratura italiana. In quelle righe scritte di getto il priore, nel momento in cui dichiarava il proprio appoggio alla lotta di classe contro i ricchi, annunciava il suo tradimento di cristiano radicale, quasi intuendo la degenerazione burocratica e liberticida a cui sarebbe andato incontro il Sol dell’Avvenire. Poi sono andato nei luoghi di don Lorenzo: Firenze, Milano, Montespertoli, Castiglioncello, San Donato di Calenzano, Barbiana. Volevo rievocare lo spirito del priore, ma in fondo, attraverso di lui, ho parlato anche con me stesso.
GIOVANNI ACCARDO: Hai costruito il libro alternando ai luoghi di don Lorenzo altri legati alla tua esperienza e alla sua autobiografia letteraria: Hiroshima, Volgograd, Benares, Berlino, il Marocco, il Gambia.
ERALDO AFFINATI: Tante volte nei miei giri intorno al mondo ho conosciuto educatori isolati, maestri di frontiera, docenti appassionati, disertori, teppisti, emigranti, persone che, in un modo o nell’altro, mi hanno fatto venire in mente don Lorenzo Milani. Ricorderò sempre quando, in India, sulle rive del Gange, un manipolo di ragazzini mi trascinò dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. Entrai frastornato e vidi come queste sorelle imboccavano i disabili, i malati, i reietti. Nel momento in cui ho deciso di scrivere un libro sul priore di Barbiana, ho voluto rievocare la memoria di incontri per me indimenticabili.
GIOVANNI ACCARDO: Qual è l’insegnamento più importante di don Lorenzo?
ERALDO AFFINATI: Ognuno di noi dovrebbe intervenire quando sente dentro di sé l’oltraggio di un principio in cui crede. Naturalmente questo non è possibile, ma se tu, di fronte all’ingiustizia e al sopruso, torni a casa indifferente, resti escluso dallo stadio etico. Sei confinato nella retrovia polverosa, insieme agli uomini d’azione, governati dagli istinti o dalla propria ideologia. Se invece credi di poter risolvere tutto erigendo un alibi interiore, magari allo scopo di non poter pagare il prezzo del risarcimento nel caso in cui commetti un danno, allora sei un intellettuale del Novecento, uno che crede nell’atto gratuito, nel pensiero fine a se stesso.
GIOVANNI ACCARDO: Quanto è lontana la scuola di oggi da quella immaginata, teorizzata e praticata dal priore di Barbiana?
ERALDO AFFINATI: Nella sua struttura essenziale a me sembra distante anni luce, ferma al suono della campanella, all’aula chiusa, alla lezione frontale, ai programmi da svolgere, ai voti da assegnare, ai test da riempire, ai moduli da compilare. Questo non significa che non esistano luoghi di sperimentazione appassionata, docenti capaci di coinvolgere i loro studenti, dirigenti in grado di mettere le mani in pasta. Ma il lavoro da fare è ancora tanto. Del resto don Milani non ci ha lasciato un metodo da praticare, ma uno spirito da vivere. Era il primo a sapere che Barbiana sarebbe morta insieme a lui. Per questo io sono andato a cercare i suoi eredi – inconsapevoli – nelle contrade del mondo.

 Traumi e vittime nella letteratura contemporanea - Giovanni Accardo
Traumi e vittime nella letteratura contemporanea - Giovanni Accardo Intervista a Romolo Bugaro - Giovanni Accardo
Intervista a Romolo Bugaro - Giovanni Accardo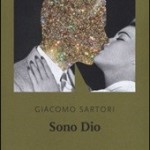 Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo
Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo
La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo Scrivere per comprendere il mondo
Scrivere per comprendere il mondo





















