
Una solitudine senza solitudine (Effigie, 2020) raccoglie le poesie scritte negli ultimi trent’anni da Massimo Rizzante. È composto da tre raccolte edite, Lettere d’amore e altre rovine, Nessuno, Scuola di calore e da una quarta inedita, Benvenute, vertigini! La sua poesia non sembra affondare le radici nell’humus italiano. Sarà perché l’autore si è formato all’estero, o perché non è mai riuscito a intrattenere un buon rapporto con il suo paese, o ancora perché fin da ragazzo è perseguitato dalla convinzione che restare ai margini di una cultura sia l’unico modo per rigenerarla. Ecco cosa ha detto una volta: «Quello che cerco e non trovo nella poesia italiana è il senso storico, la capacità di colloquiare, come se fossero viventi, con i personaggi più disparati, dal primo dei poeti di Roma al più anonimo dei sudditi dell’ultima provincia dell’ex Impero sovietico. Quel che trovo nella poesia italiana, invece, è la refrattarietà a coltivare e a far crescere lungo i vetri delle sue serre i rampicanti della follia della Storia. La poesia italiana è sempre stata eloquente, lirica, o sperimentale! In essa non vi ho mai scorto una vera vena ironica in grado di compatire gli uomini o di fermarsi davanti al mistero racchiuso nei dettagli triviali, infimi, osceni, del mondo: il regno fiammingo dei dettagli, il regno russo dei dettagli, il regno centroeuropeo dei dettagli, il regno di Dio dei dettagli! Nella poesia italiana mi manca la coscienza della distanza che misura la devastazione che il troppo sapere o la brutale assenza di sapere provocano nella natura umana: quel soffio che fa crollare in un batter d’occhio il castello di carta della cultura». Che cosa aggiungere? Che il custode della poesia di Massimo Rizzante è un uomo prosaico che desidera estinguere quel ridicolo monarca chiamato «Io». Per l’autore, in altre parole, la poesia è sempre «poesia di circostanza», fedele alla propria situazione storica e allo stesso tempo in dialogo con tutte quelle del passato. E, a causa di questa fedeltà, non deve temere di bruciarsi venendo a contatto con la varietà delle forme e dei contenuti. La sua sfida, infatti, non è quella di fondersi con il mondo, ma di comprenderlo.
In anteprima esclusiva per i lettori di Zibaldoni e altre meraviglie, presentiamo alcune poesie tratte dalle quattro raccolte che compongono Una solitudine senza solitudine, ringraziando l’autore e l’editore per la gentile concessione.
Da Lettere d’amore e altre rovine (1989-1998)
Offen Bach
in primo piano frangetta, sullo sfondo neve, purezza
a sinistra il profilo aquilino del secolo, a destra l’Europa
poi, sulla cresta di una roccia, scivoli sulla pronuncia:
dizione imperfetta! così ricominci dall’età della pietra
più miope di una mosca bianca a due palmi dalla vetta
guarda! hai una cordicella appesa al chiodo dell’infanzia
con cui scendere in fretta spargendo lacrime di gioia
sei salvo! – non dare retta al regista della montagna –
come il figlio prediletto nel grembo di erode
stazione termale, luminosa anticamera della morte
con vista su laghetto grigioperla, prato amaranto, viole
al centro in topless una gorgone, glutei immusoniti, vene varicose
lillà, coppie assiepate come ruote sgonfie, contorsioni
di cani, mercedes blindate, tate teutoniche in pose statuarie
mimose, mosche carnarie, eternità a nove teste, cuffiette bianche
se sei vivo è per contare all’infinito i semitoni
discendenti, le tegole sul capo, le mele di newton
le gocce di tranquillante, tutte le offerte votive della gravità
anus dei, anus mundi! esclamano in coro gli ortodossi
davanti a un’icona con i baffi: ovazione di fringuelli nel sottobosco
anche se quest’autunno le foglie non possono cadere più in basso
allo scacco matto, il re stramazza al suolo come un cavallo
ora il posto dei testicoli è vicino a un sacchetto di sambuco,
scavo una fossetta nel letto, compongo la mia sagoma di fuco
lecco ancora un po’ di miele dalla celletta dello spirito:
ma non chiedere al secolo gremito né al grinzoso insetto
di strapparsi dal petto il loro aculeo, se in cirillica solitudine ti ho amato
*
Da Nessuno (1999-2006)
conoscevo ancora me stesso
quando la prima fuggì scalza dal letto
la seconda corse a perdifiato
la terza, nuda, spalancò la porta di casa
la quarta fu un intervallo
poi non ricordo
fu Troia o la giovinezza ad andarsene a fuoco?
la quinta ritornò in sogno
la sesta, da morta, mi pose una precisa domanda
la settima, una pietra sopra
*
Da Scuola di calore (2007-2012)
Iman
sulla strada per ourika siamo come uccelli
notturni che si strappano le ali a vicenda
fino a quando il becco affonda in un organo cieco a molti
soprattutto a coloro che sono stati ciechi a lungo
così l’amore ci chiama. E da uccelli notturni
dobbiamo trasformarci in talpe, scavare cunicoli
e, se necessario, saziarci di tenebre senza poter risalire
in superficie. E questo per un giorno, o per sempre
o in cani che girano su se stessi un numero di volte
pari ai loro anni, moltiplicato per le cagne in calore
che hanno posseduto e che ora ubriachi cercano di ricordare
prima di trovare una posizione in cui dormire
o in mariti puntuali che all’ultima chiamata
s’avvicinano zoppicando al letto dell’amata
posando la testa sul suo inguine: per questo esisti
per sottometterti all’infinito ai miei errori
per questo esiste un incubo chiamato ourika
dove, risalendo a piedi nudi il torrente, mi lascio alle spalle
accampamenti di cicogne, registi in cerca di comparse
scheletri mezzi sepolti alle pendici dell’atlante
e un branco di pesci in guerra per qualche briciola
di pane gettata nella vasca da una coppia di innamorati
dall’occhio feroce di bambini annegati
che non smettono di chiedere, chiedere, chiedere
*
Da Benvenute, vertigini! (2013-2019)
poi si entra nello stato di grazia,
dove non ci sono né leggi né corti di giustizia,
né tribunali né tanto meno folle inebetite o comizi,
del resto, nessuno, essendosi dall’inizio votato
a una causa persa, se la sente di manifestare in piazza,
nello stato di grazia, infatti, non ci sono sbirri, oligarchi,
nuovi ricchi, elogi a despoti senza macchia,
inutili comitati di pubblica salvezza: chi si ammala
muore e chi muore rinasce, prende le forme
di suo figlio in fasce, vibra qualche pugnetto in aria,
grida, poi tace, certo, terrorizzati dal risveglio,
si può impazzire: ma come sopportare tutte
quelle manfrine sul libero arbitrio?
lo stato di grazia, infatti, è in penombra,
bisogna imboccare con la luna nuova quel sentiero
nel sottobosco, circumnavigare il lago, sostare
sotto il ciliegio, temere il peggio, qualcuno, ad esempio,
laggiù sembra annegare, anche se con il passare degli anni,
diventando impossibile capirsi, e modificandosi
perfino i contorni dei volti, è sempre più buio
e una frase basta ad accusarsi, e poi i preliminari,
con l’età si teme la mancanza di scrupoli
e il crudele galateo della natura: le cose
sono fatte per svanire, tutto continuerà come sempre…
felici allora coloro che persuasi
che la guerra durerà sino al prossimo solstizio,
invocano tiranni a liberarli dal castigo,
felici coloro che non sono mai entrati,
che non sono nati, che non hanno mai conosciuto
un corpo capace di ferirli da lontano,
che aspirano al progresso del genere umano

 Saggi Inventati - Enrico De Vivo
Saggi Inventati - Enrico De Vivo Tramonto a Oriente - Massimo Rizzante
Tramonto a Oriente - Massimo Rizzante Versi verdi - Alberto Volpi
Versi verdi - Alberto Volpi Verso l’al di là che ci costituisce - Massimo Rizzante
Verso l’al di là che ci costituisce - Massimo Rizzante Liz
Liz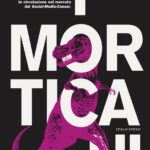 Francesco Maino, o la lingua impossibile
Francesco Maino, o la lingua impossibile Literaturistan
Literaturistan





















