
Y100, Organi sottovuoto, resina polivinilica, 2009
III. FLAUBERT DRY
Attraversammo scalzi la nuova oasi urbana OGM (Il buono deve ancora venire®), un sentiero di erba soffice che solleticava le piante dei piedi e di aiuole dai fiori profumatissimi. Il distretto finanziario al di là del fiume, ancora impacchettato nel Nastrolunare, emanava vapori languidi nella landa desolata di un tramonto incandescente. L’odore dolciastro dei fiori mi metteva sete. Una voglia di alcol, una smania di sapori amari. JD sbadigliò e si stropicciò gli occhi. Infilò le scarpe e puntò il dito verso l’insegna del Flaubert Dry.

L’éducation sentimentale era un pre-dinner a base di bourbon e Martini servito in un’ampolla a forma di mammella. Qualcuno lo ordinava per l’ampolla, un contenitore leggero e che si maneggiava con le stesse attenzioni di un bicchiere da cognac. Il liquore fluttuava e schiumava sulle pareti di cristallo, fuoriuscendo a spruzzi da un capezzolo. L’éducation si beveva in una luce soffusa, mentre le onde sonore delle chitarre elettriche si propagavano dai diffusori attraverso le sale aperte, sui banconi di legno laccato, le chaise-longue leopardate, i quadri astratti del genere color-field painting. Le cameriere si muovevano con la rapidità di anticorpi nel sistema arterioso del locale, entità corporee inaccessibili, ispiratrici di desideri che loro stesse non avrebbero potuto soddisfare. Donne dai seni materni, in minigonne di pelle e lingerie Wolford, con il pittogramma del locale tatuato sulle cosce (quattro graffi cicatrizzati che ricordavano un’artigliata).

Il Flaubert Dry era un esempio di spazio multiforme. L’interior design incitava alla violenza. Tutto era affilato, ma carezzevole, un luogo che ispirava desideri di elevazione e distacco. I clienti si specchiavano su modanature dorate, su lamine e superfici barocche, in cerca di qualità fisiche che non trovavano, inconsapevoli che la bellezza non sopporta repliche né riflessioni.
Mi ero attaccata alla mammella e cominciava a girarmi la testa. JD sfilò un sigaro dall’humidor di un venditore che si aggirava per il locale acconciato da demone in perizoma (il corpo scolpito, la faccia butterata, il cranio con due escrescenze all’altezza dell’osso parietale), un grosso bozzolo confezionato con il fior fiore del tabacco cubano. Educatamente me lo fece accendere. I Led Zeppelin cantavano Babe, I’m gonna leave you a volume critico, indebolendo le mie difese emozionali. Sugli scaffali erano schierati eserciti di liquori policromi, sapientemente retroilluminati. I ventilatori ronzavano, spargendo una brezza variabile e fradicia. Altri due sorsi e mi misi a singhiozzare.
Come un animaletto ferito, capivo solo quello che provavo. JD s’incuriosì. Lo dimostrò fissandomi in modo analitico, la testa piegata, gli occhiali da sole spinti sulla fronte.
Che cos’è? chiese.
Adesso passa.
Chiamo qualcuno. Se vuoi posso farlo.
JD non era abituato a prendere sul serio quello che la gente diceva e si allontanò senza aspettare la mia risposta. Un minuto dopo era di ritorno in compagnia di una ragazza. È straordinario, pensai. È straordinario che abbia portato la persona giusta.
Ciao bambina, mi salutò la ragazza.
Ciao Remedios.
Che cos’hai? Aspetta, non dire niente, prima ti asciugo le lacrime.
Posso farlo da sola.
Non mi costa niente aiutarti. Vieni qui, fatti guardare.
Conoscevo Remedios da tutta la vita, un rapporto fatto di similitudini. Eravamo nate lo stesso giorno alla clinica Zuckmayer. Avevamo frequentato il liceo a Coira (la stessa classe), e ai tempi dell’agenzia dividevamo un appartamento a Paddington, a due passi da Marble Arch. Ci serviva un posto dove stare, perché l’aria di Milano mi procurava dei pruriti che i medici non riuscivano a diagnosticare. Ci assomigliavamo, eravamo alte uguali. Avevamo lo stesso peso, la stessa taglia. Confesserò una cosa. Avevo voglia di abbracciarla. E per farlo mi sarei sbarazzata volentieri di JD.
Remedios era calore. Aveva un viso ovale e treccine bionde da madonna. Accanto a lei provavo una precisa fiducia nel significato delle cose, o la certezza che ne potessero avere uno. Anche se, come in quel momento, passava accanto a noi un centauro dadaista con il corpo zebrato, i movimenti svagati, l’aria un po’ ottusa.
Remedios stava cercando sul mio viso un segno rivelatore. Il senso del disagio, l’argomento della crisi. Glielo leggevo negli occhi. Mi asciugò le guance, la stoffa del fazzoletto tamponò la pelle quasi senza sfregarla. Il corpo della mia amica sprigionava un aroma inconfondibile, l’essenza odorosa delle “conversatrici”.
Conversare, parlare per mestiere. Avere a che fare con i desideri di felicità della gente. Trovare argomenti di conversazione funzionali a un Victorine o a un Madame Arnoux, strutturati long drink da meditazione. E i clienti fissi, i clienti nuovi, gli uomini soli, le donne deluse, a interpretarli, a sostenerli. Per quel genere di lavoro serviva l’energia di un giaguaro. Come in un circolo virtuoso, Remedios se la procurava attraverso il piacere di parlare.
Riprese il fazzoletto e me lo appoggiò sulle guance. Quindi fissò attentamente la pelle per apprezzare il risultato del suo lavoro.
Sembrava assorta.
È qualcosa che non avresti dovuto fare, mi disse. Non qui. Non a questa ora di sera.
Non dovevo?
Remedios valutò la distanza che ci separava da JD e ritenendola inadatta a una conversazione intima gli chiese di lasciarci sole.
Perché? si stupì JD. A Vera piace se la sto a sentire.
È vero, bambina?
Credo di sì, Remedios.
Lei ci fissò uno alla volta.
Voi due vi conoscete da molto? chiese.
Saranno un paio d’ore, risposi.
Pensi che la presenza di JD valorizzi quello che dici? Mi chiedo, a beneficio di chi?
Tuo, immagino.
Ma io non ho bisogno che JD ti valorizzi, Vera.
Non stiamo parlando dei tuoi bisogni, intervenne JD. La gente non l’ascolta. È questo che ti sta dicendo la tua amica.
Stai parlando con me, Vera. Io non sono la gente.
Ma se fossi una estranea, Remedios. Immagina di non conoscermi. Oppure immagina di perdere la memoria. Non ti ricordi chi sei, dove abiti, se Parigi è in Francia o sulla Luna. Perché dovresti dare ascolto a una come me?
Già, perché?
JD lo conosci, dissi. Se lui mi ascolta, lo farai anche tu.
Se non mi ricordo di Parigi, perché dovrei ricordarmi di JD?
È questo il punto, esclamai. JD lo vedi dappertutto. Ti guardi attorno ed è appeso ai muri. È uno di famiglia. Di lui ti fidi.
È questa la tua idea?
È così che funziona.
Remedios mi scostò una ciocca di capelli dalla fronte. Si comportava in quel modo fin da bambina. Non materna, ma stregata dalla tessitura delle cose.
Perché la gente si accorga di me ho bisogno di JD, ripetei. Lui e il suo cane sono quello che abbiamo in comune io e uno sconosciuto. La sola ragione per non ignorarci.
Remedios si mise a sedere e accavallò le gambe, una successione di gesti che mi spiegai come il segno di una volontà interpretativa. La fissavo, aspettando che riprendesse a parlare. Le sostanze commestibili che avevo assimilato nel corso della giornata, quasi tutte letali in modo non significativo, mi procuravano torpore, tristezza, un’accidia che fluttuava come un velo sulla realtà.
JD agitò la mammella per farci capire che era vuota.
Vi ordino da bere, disse Remedios. Io e te, Vera, prenderemo una Tentazione di Sant’Antonio.
Che cos’è? chiesi
Soda con l’aggiunta di rosso Congo, un colorante insapore. Ai clienti con cui parlo dico che è Campari.
Vorrei un’altra mammella, disse JD sbadigliando. Questa volta con una ciliegia al maraschino.
Pensai ad alta voce. La ciliegia passerà dal capezzolo?
Remedios scoppiò a ridere. Un suono vibrato, uno sbuffo d’aria sotto pressione. Il petto sussultava. Risi anch’io. Per non cadere dagli sgabelli ci aggrappammo l’una ai fianchi dell’altra. Mi chiesi se anche JD si stesse divertendo. Con sorpresa notai che fissava l’unghia di una mano, la mente sgombra da inquietudini. Quell’agglomerato di cheratina lo interessava sul serio. Muoveva il dito circolarmente, pazientemente, con l’unico scopo apparente di tenere occupata l’esasperante avidità dello sguardo. Decisamente, lo spettacolo non valeva la fatica cognitiva a cui mi costringeva.
Nel frattempo alle spalle di Remedios si materializzarono tre uomini. Immagino che attirassero la mia attenzione perché sembravano i soli a domandarsi dove si trovassero. Contai tre teste, sei gambe e cinque braccia, associando la mutilazione di uno dei presenti alla frattura del mio piede. L’uomo senza braccio aveva l’aspetto di un leader per anzianità. Parlava quasi senza muovere le labbra, come se la lingua in cui si esprimeva fosse impastata di argilla. Se quei tre avessero indossato completi scuri, con le mostrine, e camicie inamidate, forse avrei capito subito di cosa si occupavano. Invece vestivano in jeans e maglietta come la maggior parte dei clienti. Manifestavano una indifferenza simulata. In realtà valutavano con attenzione la funzione e la distanza tra le cose. Tracciavano linee di demarcazione tra aree di influenza, esaminavano ingressi, vani, vie di fuga, sommando e sottraendo da un valore critico volumi significativi di aria condizionata. E tutto questo in relazione alla dislocazione dei clienti, al loro modo di agire, alle loro espressioni, forse persino al loro stato d’animo.
La svolta arrivò inaspettata. Il più grasso del gruppo rifilò una pacca sulla natica al centauro dadaista e strizzò l’occhio alla telecamera di vigilanza, realizzando un documento da cineteca sui temi della determinazione violenta e dell’indifferenza verso la sfera privata. La musica si arrestò, anche se non c’era alcuna ragione perché questo accadesse. I sensi cominciarono a operare su un livello di energia subliminale. Gli uomini si diressero verso un tale che sorseggiava un bicchiere di mescal di spalle al bar, solo e indolente.
Ho qualcosa per te, Gabriel, disse il grasso, appoggiandosi pesantemente al bancone.
Gabriel era un ragazzo alto, con un pizzetto appuntito, cesellato, nero di capelli, la carnagione olivastra. Indossava abiti da uomo d’affari e tastava la piccola noce del nodo della cravatta come per assicurarsi che fosse stretta a suffcienza. Il grasso sfilò una mano dalla tasca e l’arrestò a mezz’aria, lasciando cadere una massa viscida e informe. Gabriel sorrise e scosse la testa. Era chiaro che giudicava quel gesto una mancanza di stile. Sopra il piano umido luccicava una pallina giallastra, una specie di uovo di quaglia con dei filamenti a un’estremità.
Capii che si trattava di un bulbo oculare quando l’uomo senza braccio ci appoggiò accanto un minuscolo rene. Una scossa nervosa cancellò i limiti fisici del corpo, la coscienza si amplificò oltre l’involucro epidermico, indicandomi che nel locale esisteva altra vita cerebrale oltre la mia. Ero in mezzo alla gente, e la gente mormorava, arretrava, si ammassava. La sala piombò nel buio. Le sole fonti di luce risparmiate dal collasso nervoso dell’impianto elettrico furono una lampada da tavolo puntata su Gabriel e lo scaffale dei liquori.
Che roba è? domandò Gabriel, voltandosi verso l’uomo senza braccio. Che roba sarebbe?
Prove, rispose l’uomo senza braccio.
Prove? Che genere di prove? Ehi, amici… amici, io mi occupo di frattaglie. Compro e vendo interiora. Sono nel ramo dei visceri edibili come altri in quello della carta da macero. Dovete credermi, la gente va pazza per queste cose.
Zitto, gli intimò il grasso. Zitto, coglione.
Vicino a me qualcuno piangeva. Una voce chiese: Chi siete? Chi sarebbe questo Gabriel?
L’uomo senza braccio si voltò. L’oscurità aveva maglie così strette da ridurre la visuale alla linea dei primi tavoli.
Gabriel è un trafficante di organi, rispose in tono mite l’uomo senza braccio. E queste sul tavolo sono le prove che abbiamo raccolto.
Cristo, esclamò la stessa voce dal buio, non vi fa schifo portare in tasca quella roba?
Il grasso si voltò e fissò l’oscurità. Anche il terzo uomo fece un passo in avanti per capire da dove provenisse la voce.
Adesso ce ne andiamo, annunciò l’uomo senza braccio.
Fu una distrazione fatale. Gabriel s’impossessò delle prove, le ingoiò e si sciacquò la bocca con un sorso di mescal. Quando il grasso se ne accorse, il ragazzo lo inchiodò ai fatti con un rutto cupo e prolungato.
Il grasso lo afferrò per la gola. Santissima Madre di Dio! gridò.
Gabriel rideva e si divincolava, cercando con le dita gli occhi del suo assalitore. Riuscì a liberarsi, era agile e si dileguò nel buio.

Le luci si riaccesero senza preavviso. La musica riprese da dove si era interrotta. L’aspetto del locale era quello di una camera da letto illuminata nel cuore della notte. Clienti-spettri, sonnambuli, lemuri. Facce scioccate, corpi in cerca di un sostegno. Per tutti era importante riconoscersi come entità corporee, con un volume rispettabile, un peso adeguato, la consistenza di un corpo vivo.
Con gli omaggi della casa, gridò l’uomo senza braccio e s’inchinò, chiamando Gabriel, il grasso e il terzo uomo accanto a sé.
Il barman passò una spugna sul piano del bancone e si rimise al lavoro. Ammucchiò bicchieri e ghiaccio tritato, mescolò gin a succo di ostrica, macerò foglie di menta, riempì i frullatori di fragole.
Mio Dio, Remedios, piagnucolai.
Ssst… fece lei. Non agitarti, bambina.
È orribile, non è vero? sentii dire alle mie spalle. Be’, JD, come te la passi?
Avvertivo il ruggito prodotto da uno sforzo. Uno sbuffo dall’odore animale tra i capelli. Chiunque avesse emesso quel suono si stava issando su uno sgabello, pesante, goffo, maestoso.
Mi voltai. Dietro di me un gorilla aspirava il contenuto di un tumbler da hot drink riempito di rum. Una montagna di pelo con jeans al polpaccio e una camicia aderente.
Da quale set vieni, Elvis? gli stava chiedendo JD.
Da quello di una nuova utilitaria, rispose il gorilla. Faccio la parte di uno scimmione che pesca a mani nude in un torrente del Québec. Agguanto salmoni come un orso e li ributto in acqua perché non so che farmene. I pubblicitari mi hanno decontestualizzato e in faccia esprimo il disordine mentale che questa situazione mi procura.
La gente si domanderà che cosa ci fai in un torrente del Québec.
Già, che cosa ci faccio?
JD lo fissò con aria interrogativa.
Orpelli tecnologici, strumentazione inutile, gridò Elvis, emettendo un latrato orribile. Il messaggio dello spot è che ne puoi fare tranquillamente a meno. La trazione integrale? A cosa ti serve in Rue de Rivoli nell’ora di punta? E i sedili in pelle? E il navigatore satellitare? Che te ne fai di tutte quelle spie, di quei segnali acustici da bestia in calore? Io adoro il caffè nero e mi rimpinzo di club sandwich vegetariani. Ecco quello di cui mi devo ricordare mentre pesco salmoni nel Québec. Questa utilitaria è una macchina che fa solo la macchina. Ha un volante, tre ruote e un motore. Nient’altro, e rivolgendosi a Remedios domandò, che cosa bevi, bambina?
Campari, rispose lei.
Soda colorata, la corressi senza volerlo.
Elvis sembrò disorientato, ma subito scoppiò in una risata primitiva.
È la conferma di quello che sostengo da mesi, affermò. Viviamo in tempi sospetti. È finita l’età dell’astrazione e comincia quella dell’indefinito. Ne parlavo con Joseph Stiglitz proprio l’altra settimana. O forse con qualcuno che gli assomigliava. Il mercato, non ci sono dubbi, dimostra una capacità di adattamento di tipo biologico. Esiste una evoluzione della specie economica con trend che si allungano come colli di giraffa. Il mercato ha caratteristiche evolutive decisamente vincenti. È onnivoro e paga le menti migliori della nostra generazione per raccontarci un mucchio di balle. Tu credi a quello che dicono i pubblicitari? Be’, JD, io sì. Ho metabolizzato le nevrosi del commercio e sono diventato vulnerabile.
Ci fissò con un accenno di esaltazione. La sua espressione antropomorfa sbocciava come un fiore sterile da modi rozzi e scontrosi.
Che cos’è veramente, chiesi sottovoce a Remedios.
Lo scimmione? Che importanza ha?
I clienti si stavano rilassando. Conversavano, ripreso a bere. La visione di frammentazione meccanica a cui avevamo assistito aveva ormai il sapore di una esperienza virtuale. Una cameriera posò sul bancone due mammelle. JD ne prese una e la vuotò. Ero in uno stato di euforia che valorizzava il mio innato spirito di imitazione, così afferrai l’altra mammella e feci lo stesso.
Ne ordinammo una terza.
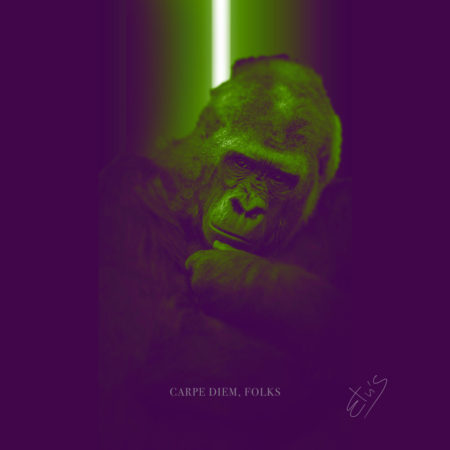
Quanto mi interessa questo ragazzo, disse Elvis, accarezzando bruscamente la testa di JD. Mi piace guardarlo. È bello, ben proporzionato. Il pubblico lo adora. Le scarpe che porta ai piedi da due anni all’asta varrebbero petrolio. Personalmente trovo stimolante vederlo spianato sui manifesti al vertice dei palazzi, la faccia che rattoppa il tessuto urbano. Lo vedo e penso, ecco quello che si dice un campione di modernità. Guadagna cifre da capogiro senza rimetterci in salute. Una riflessione, JD. Non pensi che considerati i modesti progressi della tua specie in campo metafisico negli ultimi tremila anni, la giustizia sia una virtù destinata all’estinzione? Dopotutto a chi potrebbe interessare, diciamo tra un paio di generazioni, se per una cifra stratosferica raccomandavi ai tuoi fan una bevanda gassata che provoca obesità, invecchiamento precoce e assuefazione?
O se avevo un testicolo solo?
Vi ho mai detto, ragazze, che lo scorpione di JD muove l’aculeo?
Non potei trattenermi dal sorridere. Dici sul serio?
Vediamolo, JD, fece Remedios. Per favore.
Senza scendere dallo sgabello, JD sollevò il bordo inferiore della T-shirt e si sbottonò i pantaloni. Remedios e io trattenemmo il fiato. Come non ammirare il corpo nudo dai pettorali alle anche, l’intrigo pelvico in cui convergevano intrecci su intrecci di fasce muscolari? L’aculeo era nascosto tra i riccioli del pube, là dove si allungava la coda segmentata.
State a vedere, ci disse Elvis.
Il ciuffo cominciò a ondeggiare e frusciare. L’aculeo si muoveva, danzava, continuando a restare nascosto. Uno spettacolo incantevole e vagamente indecente. Avevo l’impressione di guardare un cespuglio, aspettando che un tasso o una lepre balzasse fuori.
Nessuno sa come ci riesce, mugugnò Elvis, raschiandosi la gola.
L’importante è che ci riesca, considerò Remedios divertita.
Elvis adora le stravaganze del villaggio globale, disse JD, riabbassando la maglietta. Non è vero, vecchio mio?
Credimi, ammise il gorilla, questa è roba da monografia.
Ruggì e si diede una rapida grattatina in testa. Quindi tolse dalla tasca posteriore dei jeans un Moleskine e prese appunti a matita, meticolosamente, con la grossa mano sinistra stretta ad artiglio. JD e io, in una sorta di botta e risposta, vuotammo la terza mammella. Remedios accese una sigaretta ai chiodi di garofano. I clienti, raccolti intorno all’uomo senza braccio, erano contagiati dal suo tono confidenziale.
Quando ebbe finito di scrivere, Elvis si chinò verso JD. L’espressione del muso mascherava un interesse educatamente morboso.
Toglimi una curiosità, gli disse sottovoce. Quando hai capito l’importanza del tuo segmento di mercato?
Vuoi sapere quando?
Sì, JD, mi piacerebbe.
JD riaccese il sigaro e disse: È stato la volta che un paio di ricercatori staccarono un assegno perché entrassi in una sala d’incisione insieme ad alcune ragazzine.
Mi sembra di vederle. Erano sudate?
Una traspirazione abbondantissima all’olio di jojoba. Le guardavo e avevo voglia di strizzarle. Gridavano, volevano un pelo delle mie braccia, fili del pullover che avevo addosso. Volevano gocce del mio sangue e ciocche di capelli. Persi più di un’ora in negoziati. Alla fine arrivammo a un compromesso. Una dedica autografa con cuoricino su un seno. E pensare che lo scopo della ricerca era quello di inibire i loro pudori e svelarne i sogni adolescenziali. Tutte intelligenti, le migliori della loro classe. Eppure si erano messe in testa un mucchio di assurdità. Secondo loro potevo memorizzare quello che dicevano. Non su un supporto digitale, ma nella mia mente immortale, nella mia materia grigia onnipotente. I ricercatori erano esterrefatti. Dopo gli autografi le obbligarono a parlare una alla volta. Se non avevano niente da dire le lasciavano pensare. Sviluppavano gli argomenti con esaltazione. Cronache intime, drammi passionali, delusioni, violenze. Opinioni sull’amore, opinioni sul sesso. Esperienze estreme, sconvolgenti. Non potevo credere che delle adolescenti arrivassero a tanto. Poi un ricercatore chiese a una biondina che idea si fosse fatta dei posteri. Si sarebbero ricordati di lei? Tra cento, tra mille anni. Lei rispose di sì. Era disposta a scommettersi Mungojerrie, il suo gatto tuttofare. Grazie a JD, disse. Grazie a JD che tiene a mente quello che dico.
Lo immaginavo, rise Elvis soddisfatto. Bella forza! e prese nuovamente qualche appunto.
L’uomo senza braccio, circondato da un crocchio di bevitori che aumentava di minuto in minuto, stava dicendo: Provo a capire la minaccia del manzo infetto, il protovirus mangia-cervello, sapete, ma lo sforzo di astrazione annacqua ogni volta il senso del pericolo.
Lo senti? chiesi a Remedios.
Oh, è un attore straordinario, mi disse lei. Uno dei caratteristi più noti nei film di spionaggio ai bei tempi del muro di Berlino. Ma ecco Oz, l’artefice di questi spettacoli. Qui lo chiamiamo tutti così, come il meraviglioso mago di Frank Baum. Vi presento Oz, ragazzi. Il creativo più pagato del distretto finanziario.
Oz s’inchinò, dimostrando un certo senso del palcoscenico. Era un uomo basso, con in testa un cono di capelli ricci. Indossava un paio di pantaloni attillati in pelle di iguana, un capo cool tra gli aborigeni urbanizzati.
Si può sapere perché ti inventi certa roba? lo aggredì Elvis, battendosi i pugni sul torace.
Oz non si scompose. Sorrise comprensivo. Si limitò a farci vedere quello che aveva in mano, un cuore pulsante che spruzzava del liquido venoso.
La mia ultima idea in fatto di coreografia da cocktail, ci spiegò.
Perché certa roba? ringhiò Elvis. Perché, Oz?
Oz fa soltanto il suo lavoro, lo difese Remedios con un tono di rimprovero.
Oz provò a giustificarsi. Abbiamo capito che parlare mette sete e che la sete fa sciogliere la lingua. Non so se cogliete la circolarità del sistema. Be’, il nostro compito è quello di alimentarla.
Gli snack salati hanno fatto il loro tempo, aggiunse Remedios. È questo che Oz intende dire.
Crediamo nello spettacolo come catalizzatore della sete. Ieri abbiamo inscenato un’aggressione letale. È andata bene, c’è stato il bagno di sangue che tutti si aspettavano. Un killer di colore sui trent’anni, alto, taciturno, non integrato. Ha massacrato la nostra stagista di Amburgo senza battere ciglio.
Ma perché arrivare a tanto? gridò il gorilla. Perché il trash?
Vogliamo i loro soldi, amico, e per averli dobbiamo esaltarli.
Li ascoltavo e sentivo crescere un desiderio. Ripetevo in sequenza a me stessa le parole ansia e assenza, ansia e assenza. Infine capii che quel bisogno trovava una localizzazione fisica nel diaframma. Inumidii le labbra con la lingua. Adesso sapevo di avere sete. Non una sete qualsiasi, ma di Yellow Pit Bull. Ricordai di avere visto un distributore automatico proprio in fondo alla strada.
Farò due passi, dissi. Ciao, Remedios. Elvis, piacere di averti conosciuto.
Il gorilla mi fissò. Inclinò la testa all’indietro, dilatò orrendamente le narici, batté i pugni sul petto. Dagli angoli della bocca colò una schiuma biancastra che schizzò dappertutto.
Vieni qui, dammi un bacio, mi disse Remedios.
Bacio bacio, dissi, e premetti le labbra sulla sua bocca.
Fuori dal locale il buio manteneva solo a squarci la sua solidità. JD fissò il cielo. Era come una stoffa slabbrata. Non brillava una stella, nemmeno lontano dall’alone di luce lunare. I livelli di esasperazione prospettica suggeriti dalla verticalità dei grattacieli erano enfatizzati dall’inquinamento luminoso. La navetta della metropolitana percorreva la sopraelevata, i finestrini marmorizzati dai neon. Nello stesso bagno di lacca si materializzavano a tratti i fari delle ultime auto dirigenziali.
Il distributore automatico si trovava sul marciapiede, accanto al semaforo di un viale a grande scorrimento. Emanava una luce interiore che agli altri erogatori mancava del tutto. Il lampeggiante di una macchina della polizia chiazzava le travature di un gasometro, una pulsione stroboscopica che mi accecò, facendomi inciampare sul cane di JD.
Fissai l’animale accucciato ai piedi del distributore, la lingua palpitante, gli occhi umili, innocui.
Credo abbia sete, dissi.
JD si strinse le spalle.
Avevo finito le monete. Avvicinai la carta di debito al sensore del distributore. E adesso, JD, chiesi, che cosa intendi fare?

 Presiden arsitek/ 27 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 27 - Angelo Angera L’America è ancora una terra di grandi romanzieri - Ian Poggio
L’America è ancora una terra di grandi romanzieri - Ian Poggio Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera Nella neve perenne/ 1 - Danilo Laccetti
Nella neve perenne/ 1 - Danilo Laccetti Fetish/ 1
Fetish/ 1 Fetish/ 4
Fetish/ 4 Fetish/ 2
Fetish/ 2 Fetish/ 5
Fetish/ 5





















