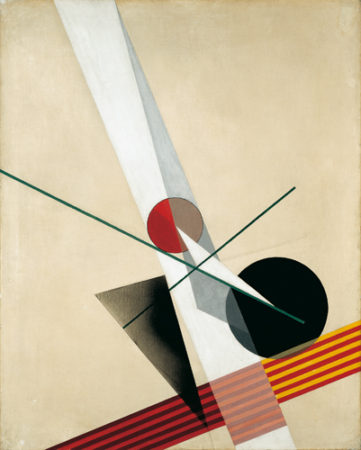
1. Una curva nasce da un punto e gli gira intorno diverse volte, facendosi sempre più spessa. Il movimento è a elica: un cerchio più ampio si sovrappone di volta in volta al cerchio sottostante. Avviticchiandosi al vuoto centrale incombente sul punto, la linea avvolge lo spettro di un cono. Il primo giro comincia adagio, anzi pianissimo. Due bacchette picchierellano sulla membrana di un tamburo senza quasi farsi udire. Questa cellula ritmica ritorna identica nei giri successivi, ma a volume più alto e con maggiore intensità; il tema si ripete in crescendo, accompagnato a ogni rotazione da nuovi strumenti, convocati d’urgenza dalla forza ostinata del tamburo. «Stai mica parlando del Bolero?» chiede uno. «No, sto rileggendo E quindi uscimmo a riveder la gente di Gabriele Di Luca, un libro di variazioni».
Alla fine gli strumenti prendono il sopravvento sul tema, il tamburo non si sente più.
2. A prima vista si tratta di un diario: scritto tra l’11 marzo e l’8 aprile 2020, durante la prima fase della chiusura totale decisa dal governo italiano per contenere il contagio del coronavirus, E quindi uscimmo a riveder la gente è un volume stampato dalla casa editrice alphabeta di Merano nel mese di maggio scorso. Il testo si compone di un prologo, di ventotto serie di dieci frammenti – ognuna delle quali è stata pubblicata una prima volta con cadenza giornaliera sulla pagina Facebook dell’autore – e di un epilogo. Il titolo del libro salda l’ultimo verso dell’Inferno dantesco con l’auspicata conclusione dell’emergenza sanitaria, affidando al rimpiazzo del termine “stelle” con la parola “gente” il compito di precipitare il cono rovesciato dell’Inferno nella primavera del 2020: le “stelle” lasciano il posto alla “gente”, ai tempi del Covid-19 l’inferno metafisico diventa inferno sociale. Nella sua coniugazione al passato remoto, il titolo inscrive la lettura del libro in un futuro anteriore per ora soltanto vagheggiato. Visti da lì, da un tempo postremo, i frammenti di E quindi uscimmo a riveder la gente acquisiscono il valore di una testimonianza: sono le minime annotazioni del taccuino massimo cui si allude nel sottotitolo (“Diario dalla Grande Reclusione”), efficacemente inzeppato di maiuscole e in grado di richiamare d’acchito alcuni eventi-crinale degli ultimi cento anni: la Grande depressione del 1929, la Grande recessione del 2008.
«Cerco di organizzarmi,» ci avverte l’autore nel prologo all’indomani dell’annuncio del lockdown «magari scriverò un diario, pubblicando ogni giorno sulla mia pagina Facebook una sorta di “decalogo”. Qualche notizia, la frase di un libro, un contributo di alcuni miei contatti che mi sembrerà particolarmente bello e significativo».
Nei primi mesi del 2020 il virus penetra nelle nostre case, negli uffici, in fabbrica, nelle carceri, nei bar; con una rapidità non misurabile si diffonde nelle corsie degli ospedali, negli ospizi, tra i banchi di scuola, all’università; con noi si imbarca su un aereo, prende posto nella cabina dei passeggeri, decolla, attraversa oceani, atterra, scende in strada e si rimette in marcia; va a tavola quando ci andiamo noi, è con noi mentre dormiamo, ci laviamo i denti, beviamo whisky, passeggiamo. Contemporaneamente al diffondersi del virus, si propaga la materia linguistica del Covid-19, il tema senz’argine, onnipresente e pervasivo almeno quanto il virus. Ciò che in quei giorni non è possibile o che è molto difficile fare sul piano della realtà, vale a dire contenere adeguatamente il virus, Di Luca lo fa sul piano estetico: prende il tema-monstre, smisurato, strabocchevole, tragicamente ubiquitario, divenuto in poche settimane più popolare di Gesù Cristo e della coca-cola, e lo incassa nelle forme chiuse del decalogo. Qui viene in mente, tra gli altri, il Manganelli dei «cento piccoli romanzi fiume» di Centuria, che affidò alla misura di un foglio poco più grande del normale il compito di limitare ogni singolo racconto, sottraendo il libro a una possibile «espansione incontrollata». L’operazione di Di Luca è più o meno la stessa, ma è di chiara marca ironica: i dieci frammenti che formano ciascun decalogo non hanno nulla di normativo, sono piuttosto comandamenti laici svuotati della loro funzione precettistica e dunque gusci vuoti di una Legge in balia del tema che straripa, generati da quello stesso tema, parti di quel tema, messi lì non per opporre resistenza al tema-fiume – debordante, innumerevole – ma per mostrare la sua attitudine a esondare.
3. Gabriele Di Luca, livornese classe 1967, insegnante, editorialista, collaboratore della casa editrice alphabeta di Merano, polemista pertinace, traduttore, vive in Alto Adige da oltre vent’anni. Il suo primo libro, E quindi uscimmo a riveder la gente, poggia su una pila di volumi inesistenti: una biblioteca della dispersione disseminata in migliaia di articoli di giornale, post su Facebook, interventi in decine di forum e poi di blog, messaggini composti come massime, presentazioni di libri, mail scritte agli amici quando le mail non erano ancora diventate uno strumento antiquato se non addirittura preistorico di comunicazione. Questa biblioteca spettrale, scritta da Di Luca nel corso degli ultimi vent’anni e votata alla magnificenza dello spreco, è una biblioteca della dispersione perché è fatta di una scrittura che ha la stessa sostanza della parola orale; è cioè una scrittura volatile, che nasce moritura, con le ore e i giorni contati, sorella cagionevole della scrittura longeva di cui sono fatti quasi tutti i libri – non solo quelli brutti o quelli collocati un metro più in là rispetto alla linea che demarca il campo visivo dello spirito del tempo –, i quali possono vantare un’esistenza media di sei mesi sugli scaffali in penombra di quattro librerie, a dimostrazione che anche l’eternità è disciplinata con contratto a tempo determinato.
L’aspetto più interessante dell’autore di E quindi uscimmo a riveder la gente è proprio la ponderosa volatilità della sua scrittura: Di Luca scrive messaggini come se fossero aforismi destinati a Giulio Einaudi; se invece progetta la stesura di un libro, lo studia nei minimi dettagli, ma facendo in modo che possa essere pubblicato a puntate su Whatsapp. Leggendolo, si ha l’impressione che Di Luca sia attraversato da una corrente di parole che può indifferentemente entrare in un libro o nel commento a un video su YouTube. La sua è una scrittura ibrida, che aderisce in maniera uguale, egualmente convinta e partecipe, al mondo dei libri e a quello dei social. Dopo aver letto E quindi uscimmo a riveder la gente si esclama:«Be’, questo si è formato su Internet, si vede. È uno fresco, che padroneggia la scrittura rapida, uno che chatta di continuo col problema del momento». Leggendo un suo post su Facebook, invece, si dirà immediatamente: «Questo ha il passo giusto, il tono giusto. È veloce ma profondo, proviene dal mondo dei libri, di sicuro. È cresciuto a pane e Flaiano, prosciutto e Kraus». Non è escluso però che Di Luca abbia semplicemente raccolto, attualizzandolo, uno spunto di Italo Calvino. Nel capitolo “Rapidità” delle Lezioni americane, lettura indispensabile per qualsiasi scrittore che si cimenti con la misura breve, l’autore di Palomar e Le città invisibili si dice convinto «che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca di un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile». Mi sembra che Di Luca non abbia fatto altro, ma sostituendo debitamente, in armonia con la qualità dei tempi, i termini “prosa” e “poesia” con le parole “libri” e “post”.
Nei vent’anni che precedono la pubblicazione di E quindi uscimmo a riveder la gente, lo scrittore toscano si è esercitato nei sottogeneri della prosa breve (dall’aforisma, all’apologo, al microritratto, alla short story), adeguando la sostanza della sua scrittura ai nuovi social media che via via si susseguivano, sperimentando quotidianamente quello che negli anni Sessanta del secolo scorso veniva chiamato “il totale linguistico”, una scrittura dei cento temi e dei mille registri, che può passare da un momento all’altro dal turpiloquio al cammeo, dall’insulto ulcerante alla chiosa impeccabile di un testo di Piero Camporesi. Indipendentemente dal mezzo con cui si esprime, la scrittura di Di Luca è costantemente in contatto con il cavo dell’alta tensione di una modernità vitalissima e irritante, attraversato da una scarica estetica che alterna di continuo alto e basso, ricercato e popolare, aulico e trash: entrandoci in rapporto, si ha la certezza di stare contemporaneamente in un testo di Rodolfo Wilcock e in una puntata della Zanzara di Radio 24, di vivere in un tempo in cui la bellezza, disponibile in ogni supermarket a prezzi da discount, copula senza orgoglio né vergogna con il raccapriccio.
4. Il laboratorio di parole di Gabriele Di Luca ha molti ingressi. Per imboccare il più vistoso, si può eseguire un esercizio mentale. Facciamo finta che E quindi uscimmo a riveder la gente sia un oggetto esclusivamente quantitativo. Il numero di pagine contenute nel libro, circa duecento, è il risultato di trenta giorni di lavoro. Considerando che per Di Luca questa non è un’eccezione, bensì la norma, è sufficiente prendere quelle duecento pagine e moltiplicarle per dodici; si ottiene così la quantità di scrittura prodotta da Di Luca in un anno. Infine si moltiplica per venti quel mezzo scaffale di pagine scritte in un anno e davanti a noi appare, nei suoi contorni spettrali, la biblioteca della dispersione di cui parlavo prima. Questo esercizio mentale, privo di intenti didascalici, ci dice che per Di Luca la quantità coincide con la qualità, oppure, detto in maniera più chiara, che nella sua scrittura la quantità è un generatore di qualità. In un certo senso Di Luca si libera dell’ossessione della qualità non cercandola, ma dimenticandosene scrivendo, scrivendo continuamente.
5. Può capitare che il presente, imbizzarrendosi, secerna scrittura come sebo, parole come muco impiastricciato sull’evento mentre accade. Si potrebbe dire che la materia di cui è fatto E quindi uscimmo a riveder la gente è una scrittura a cavalcioni sul presente, o il presente in groppa alla scrittura. Nella sua dimensione corporea, il racconto dell’adesso assume una forma perifrastica («Sto avvenendo,» dice «sto succedendo»), vale a dire una postura grammaticale a quattro zampe, con il ventre vicino al suolo, gli occhi dritti nelle brezze; e lo fa in un corpo di parole programmato per sudare, andare al trotto, palpitare, anche sporcarsi. Certa scrittura giornalistica, soprattutto di inchiesta, nasce così, come molte pagine di blog e di diario: si compone di appiccicatura del presente, muco del qui e ora, una materia qualitativamente neutra, cedevole al massimo grado, dalla quale è possibile ricavare una gamma innumerabile di opere, comprese pressappoco tra una storia d’amore scritta con gli emoticon e Gli ultimi giorni dell’umanità. Nel libro di Di Luca questa sostanza è rintracciabile ovunque in forma impura, impastata con la materia polverosa di cui trabocca il canone decentrato del frammento. Il tema del coronavirus assume di volta in volta la forma dell’aforisma fulminante, dell’impressione a caldo, della storia polifonica di una quarantena, della notizia falsa che il giorno dopo diventa vera, dei dati ufficiali sulla diffusione del contagio, della domanda “Quando raggiungeremo il picco?”, del racconto drammatico dalla corsia di un ospedale, di esistenze pigre acquattate in un tempo sfatto, del pannolino con la scritta “Andrà tutto bene”, della conta dei morti, della mascherina come salvazione, del guscio d’immagine strappato a un rotocalco, dell’aneddoto che non si può dimenticare, del diario intimo, dell’arlecchinata quotidiana dei virologi, del Libro degli amici, della rassegna stampa spolverizzata di ironia, della mascherina come vertice di una carriera, della citazione dotta, della foto di un livornese alla finestra che nel periodo della “grande reclusione” pesca nel canale sotto casa con una gamba a penzoloni. Il libro di Gabriele Di Luca, tra le altre cose, ha il merito di mostrarci il discorso plurimo sulla grande pandemia come un conglomerato di frammenti. Un frammento è sempre vero, anche se quello successivo lo contraddice. «Questo significa essere irresponsabili,» direbbe Cioran «ma in tal caso lo si è al modo stesso in cui è irresponsabile la vita». (A proposito: i comunicati stampa del premier Conte sono frammenti tra frammenti? Leggendo il libro di Di Luca si capisce che per avere una risposta univoca è meglio chiedere a dieci autori di frammenti appassionati di virologia).
Se dal racconto del presente come muco affiorano di tanto in tanto i baffi umorali di Flaiano – uno ridevole, l’altro atrabiliare – non è escluso che un pensiero di Hölderlin dialoghi a distanza di poche pagine con un commento di Veltroni pubblicato sul «Corriere»: il colloquio giova a entrambi; Veltroni entra in contatto con l’elemento eterno e invariabile della bellezza, mentre Hölderlin, nonostante i duecento anni di distanziamento sociale che lo mettono al riparo da Veltroni, diventa urgentemente contemporaneo e preferisce cautelarsi indossando la mascherina. Il presente carica la tradizione del frammento, la potenza ubiquitaria del frammento elettrizza il racconto del presente. Questa doppia carica fa sì che quello di Di Luca sia un presente in esubero, amplificato, un presente in eccesso che esorbita continuamente dal presente, in grado di schiantare il soffitto come il destriero di Kafka che scalpita da cent’anni trale righedei Quaderni: «Guardammo stupiti quel cavallo gigantesco. Aveva sfondato il soffitto della nostra stanza. Il cielo nuvoloso scivolava pigramente lungo la sua sagoma possente e la sua criniera frusciava al vento».
6. Di Luca è abilissimo nella lavorazione del frammento. Se in lui predomina l’umor bilioso, riesce sempre a fare in modo che il frammento si mostri al lettore dalla parte in cui la linea di rottura è più tagliente. Il frammento diventa allora lo strumento privilegiato del sarcasmo (la parola deriva dal greco antico “sarkazein”, che significa “lacerare le carni”). Quando invece è di umore malinconico, Di Luca prende il frammento e se lo gira tra le dita fino a individuare la sfaccettatura che riflette con maggiore efficacia la luce crepuscolare. I suoi frammenti più riusciti sono però quelli che potremmo definire cubisti, piccoli testi in grado di mostrarci, in una sola immagine, più punti di vista insieme. Questa capacità di cogliere il nesso grazie al quale, osservando la testa del nostro interlocutore, riusciamo a vedere con un solo sguardo la pustola rossastra che gli sporge dalla fronte e il punto della nuca su cui una mosca verde è intenta a pulirsi le zampette, non è molto dissimile da quella che nel 1938 Musil battezzò “ironia costruttiva”: «Ironia è presentare un clericale in maniera da colpire, oltre a lui, anche un bolscevico; presentare uno scemo in maniera tale che l’autore improvvisamente senta: ma questo in parte sono io». Tutto questo sarebbe inutile se Gabriele Di Luca non padroneggiasse la tecnica squisita del montaggio.Per essere un bravo scrittore di frammenti non basta essere in grado di lavorare ad arte i singoli testi; occorre possedere la competenza quasi cinematografica di metterli in sequenza come se fossero le inquadrature di un film, o di un unico Senso, ma lasciando intravedere sotto quella compattezza, che è un’omogeneità prettamente estetica, la frammentarietà dell’insieme, vale a dire la linea di rottura che separa un frammento dall’altro. Prima ho scritto che E quindi uscimmo a riveder la gente ci mostra il discorso plurimo sulla grande pandemia come un ammasso di frammenti. Ecco, se ogni frammento è il brandello di un sapere o di un mondo – sembra dirci Di Luca confezionando un racconto ben fatto che mette insieme un comunicato stampa della Protezione civile e un pensiero di Leopardi, a sua volta appiccicato alla dichiarazione di un virologo cucita addosso a un aforisma di Cioran –, un insieme di frammenti è innanzitutto una giustapposizione di brani prelevati, anzi proprio strappati via, da mondi diversi che non comunicano.
7. Extra-testualità. Un’altra caratteristica della scrittura di Di Luca è la propensione dadaista al ready made, un’accortezza disinvolta e spregiudicata nell’individuare l’oggetto trovato –la frasedi un amico, di un contatto su Facebook – che andrà poi ricontestualizzato e dunque risemantizzato attraverso un’idonea operazione di montaggio. Questa caratteristica fa il paio con un’altra abilità dell’autore toscano: una maestria che verrebbe voglia di definire “innata”, se questa parola avesse un senso, nell’asportazione chirurgica della citazione dotta da un testo preesistente; la capacità rapinosa, predatoria, di appropriarsi delle voci degli altri per inserirle in una rappresentazione corale del tutto nuova. Ci muoviamo insomma nell’ambito dell’intertestualità. Un intertesto, come è noto, è un testo contenuto in un altro testo sotto qualsiasi forma (citazione, pastiche, rifacimento, plagio). Rispetto al libro di Di Luca, per esempio, sono intertesti un pensiero di Kafka o un post di Marco Lenzi prelevato dalla sua pagina Facebook. In circostanze cognitive improntate a immaginosa euforia, si potrebbe dire che una serie di intertesti forma lo scheletro del testo. L’intertesto non si vede: è per l’appunto uno scheletro nascosto sotto la polpa narrativa che lo sovrasta. Nel caso di Di Luca sarebbe allora più corretto parlare di extra-testualità, perché i testi predati non solo si vedono, ma vengono esibiti in bella mostra. Gli intertesti sono allora extra-testi. Lo scheletro della scrittura di Di Luca è in realtà un esoscheletro, come quello degli insetti. È la corazza di un coleottero su cui campeggiano, incise a caratteri minuscoli, sei parole di Karl Kraus: «Le più crude invenzioni sono citazioni».
8. Modificando di un nonnulla uno spunto di Calasso, si può dire che il potenziale romanzesco della musica, come di ogni altra disciplina rigorosa, è illimitato. È però sempre la musica a scegliere. Il Bolero ha deciso di farsi eseguire da Di Luca, non viceversa. Affinché l’operazione riuscisse era necessario procurarsi un’orchestra; poi un oboe d’amore, tre sassofoni e un gong.
9. Resta da chiedersi: perché la scrittura del molteplice, dei mille rivoli, a un certo punto si disciplina per entrare in un libro? Come mai Di Luca distrae l’attenzione dalla biblioteca della dispersione e comincia a scrivere E quindi uscimmo a riveder la gente? Me lo sono domandato diverse volte senza riuscire a rispondere, probabilmente perché la domanda era posta male. In fondo a Di Luca, fatte le debite proporzioni, è successo quel che accadde a Karl Kraus scrivendo Gli ultimi giorni dell’umanità: a un certo punto un vulcano di parole, una massa fluida di virgole e lemmi che schizzano in tutte le direzioni, entra così com’è in un collo di bottiglia tematico, in un restringimento epocale che non può evitare. La scrittura di Kraus si infila nel grande imbuto della prima guerra mondiale, quella Di Luca nella strozzatura tematica del coronavirus. Sarebbe tuttavia fuorviante sostenere che l’autore di E quindi uscimmo a riveder la gente è passato da una scrittura dei mille temi a un unico tema. Semplicemente, prima del Covid-19 Di Luca scriveva di tutto, poi ha continuato a farlo, perché nei mesi di marzo e aprile del 2020 il tema del coronavirus era tutto, era l’unico tema di cui si potesse parlare.
10. Ogni libro reclama un numero imprecisato di definizioni. La prima che mi viene in mente per E quindi uscimmo a riveder la gente è: Il taccuino di un globe-trotter dedito alla mappatura dell’immobilità (in sottofondo si sentono le note del Bolero di Ravel in una famosa esecuzione dell’orchestra sinfonica di Montreal).
11. Non c’è niente di più bello che andare fuori tema. Lo si può fare semplicemente uscendone, alla maniera di Robert Walser: si inizia a scrivere un saggio per una rivista di chimica dal titolo I radicali liberi, ma dopo dieci righe si passa a raccontare la storia dei “Radicali” di Pannella e non si smette più. Un altro modo per andare fuori tema è addentrarsi troppo nel tema, entrarci così tanto da cancellare il tema con gli strumenti che si erano scelti per metterlo in luce. Ci si infila nel tema con tutto il corpo, come si farebbe indossando una tuta da sub, e poi si comincia a girare in tondo. Il tema si attorciglia, ruota su se stesso, fa mille giravolte, si ubriaca delle proprie rotazioni, rigira, alla fine casca giù. Si potrebbe anche dire: ripetizione variata del tema come cancellazione del tema, come fuoriuscita dal tema. Nell’esercizio di questo movimento circolare Thomas Bernhard è stato il maestro insuperabile.
12. Leggendo E quindi uscimmo a riveder la gente si avverte di continuo la necessità di aderire al tema del coronavirus e contemporaneamente l’urgenza di uscirne. Il libro è attraversato da due tensioni stilistiche contrapposte: una centripeta, l’altra centrifuga. La prima esige massima fedeltà al tema, l’altra reclama l’urgenza della fuga. La struttura a elica del libro dipende soprattutto da questo. Il basso ostinato della cronaca suscita il colpo d’ala stilistico che azzarda la deviazione, poi arriva la rassegna stampa che lo rimette in riga. Durante la prima fase del lockdown eravamo tutti d’accordo con Wittgenstein, sebbene soltanto a metà: «Su ciò di cui non si può parlare – l’evento esorbitante, la Grande Reclusione – occorre tacere, ma a patto che se ne parli e se ne scriva fino allo sfinimento, e soprattutto che non si parli e non si scriva d’altro». A un certo punto il tema assoluto ha fatto irruzione tra i temi e si è accaparrato tutto, ingombrando ogni intervallo. In quella fase il coronavirus non era soltanto l’unico tema su cui si potesse conversare, era il tema come inevitabilità, il tema predatorio e totalizzante che tutti avevano bisogno di trattare. Qualche mese dopo lo scoppio della prima guerra mondiale Karl Kraus sentenziò: «Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia». Poi mise giù la testa e scrisse le ottocento pagine de Gli ultimi giorni dell’umanità.
13. «Basta, voglio uscire».
«Uscire da dove?».
«Dal tema».
«Non se ne parla, resti qui».
«Adesso me ne vado».
«Tu non ti muovi».
«Ma devo andare in bagno. Posso?».
«No, la vita è qui».
«Anche fuori, però».
«Intendi dire fuori tema?».
«Sì, fuori tema».
«Allora niente da fare, anche il fuori è qui».
14. Quante volte, leggendo un romanzo ben fatto, abbiamo l’impressione che si tratti di un’ineccepibile operazione di sartoria, con tutte le cuciture a posto, il polsino al termine della manica, l’occhiello perfettamente orlato affinché il bottoncino d’osso vi si infili senza sforzo, il colletto messo là dove ci aspettiamo che sia! “È proprio un bel romanzo” si sente dire. “Sì, ma troppo”. E allora andiamo a cercare lo sbrego, il taglio profondo nel récit dal quale fuoriescono, se siamo fortunati, le note di diario, le divagazioni, le liste della spesa, gli appunti presi a un corso di elettrotecnica, i materiali vitalissimi della politica e dell’odontoiatria, pensieri decisivi formulati in un vespasiano; e poi programmi informatici in grado di raccogliere un milione di sciocchezze al minuto entrando in competizione con Bouvard e Pécuchet.
Il senso della realtà, potremmo dire, presta soccorso al senso della possibilità: ogniqualvolta il romanzo è vizzo – quando il plot si irrigidisce e la pagina si tramuta in cartapecora – , ecco venirgli incontro le scorie di lavoro, la notizia dell’ultima ora, i materiali limacciosi che fino a un attimo prima non trovavano spazio sulla scrivania. Ha così inizio un complicato lavoro di amalgama, al termine del quale, se si verificheranno decine di circostanze fortunate, verrà aggiunto un libro perfetto alla biblioteca dell’imperfezione. Insomma, il diario entra nel romanzo e lo vivifica, ma può accadere anche il contrario: in E quindi uscimmo a riveder la gente, per esempio, è proprio il romanzesco a rinvigorire le annotazioni di un taccuino a rischio di soffocazione. Nella forma diaristica come senso della realtà, bilanciata da un senso della possibilità che è polvere finissima ricavata dal canone decentrato del frammento, a un certo punto irrompe l’elemento romanzesco impersonato dall’avvocato Augusto Nicotra, il quale potenzia a poco a poco il senso della possibilità fino a emanciparlo dal ritmo serrato del diario. (La polvere, o il senso della possibilità, in questo caso è una declinazione dello stile: si deposita tra le righe di una nota di taccuino rendendola inconfondibile).
15. La struttura a elica di E quindi uscimmo a riveder la gente è un meccanismo narrativo equilibrato fino a quando l’occorrenza di aderire al tema del coronavirus e la necessità di allontanarsene hanno lo stesso peso: su un piatto della bilancia ci sono i numeri aggiornati sulla diffusione del contagio; sull’altro piatto, allineato al primo, ecco invece le tecniche letterarie della misura breve acquisite da chi ha lungamente masticato e infine ingerito l’opera omnia di Cioran. Fintantoché la tensione centripeta (l’aderenza al tema come inevitabilità) è bilanciata da una tensione centrifuga di pari intensità (il bisogno di fuoriuscire dal tema), il libro di Di Luca è un testo perfettamente bilicato tra senso della realtà e senso della possibilità. L’equilibrio regge per 54 pagine, poi appare Augusto Nicotra e l’andamento a elica del libro subisce una torsione: la forma-diario, seppure colmata dal tema totalizzante del coronavirus, si sgonfia capitolo dopo capitolo per lasciare sempre più spazio all’enfiamento del senso della possibilità, alla tumefazione progressiva del romanzesco. Letto così, il testo di Di Luca è un libro trans-genere: si comincia a sfogliarlo persuasi che si tratti di un diario, ma non appena se ne conclude la lettura si ha la certezza di avere per le mani un romanzo.
A pagina 89 si legge: «Una delle cose più difficili da fare: scrivere anche d’altro, soprattutto mentre si continua a scrivere di questo. Ma potrebbe diventare una questione di sopravvivenza». Augusto Nicotra è dunque l’emanazione di una sopravvivenza, il personaggio che permette a Di Luca di evadere dal tema del coronavirus pur rimanendone soggiogato.
16. (Bressanone, 5 novembre 2020 – L’inizio di un’altra quarantena). E quindi uscimmo a riveder la gente è anche un libro di panchine. Ci sono le panchine transennate di piazza Municipio a Bolzano e c’è la panchina di Valentino Liberto, «luogo d’attesa, punto di osservazione, ma anche meta prediletta di tutte le anime in pena». E poi c’è quella non detta, non so se reale o immaginaria, in ogni caso taciuta dall’autore eppure visibilissima, su cui sostano i due vecchi ritratti a pagina 17: «In piazza Madonna, stamattina, c’era una coppia di anziani. Sono passato sei ore dopo ed era ancora lì. Ho chiesto loro in tedesco (sembravano ed erano di lingua tedesca) se stavano bene, se avevano bisogno di qualcosa. La donna mi ha risposto: “Es geht uns sehr gut so” (stiamo benissimo così)».
Ma la panchina che fa capolino nella memoria del lettore per non uscirne più si trova in via Bottai a Bolzano, dimora instabile di Riccardo, clochard eracliteo convinto che «il virus è un’opinione». A chi gli domanda: «Come stai?», lui risponde sempre: «Benemale, grazie». In quei giorni di primavera Riccardo appare, dispare, ricompare; è «un fantasma assorbito dalla spugna del sole».
Tutte queste panchine, non importa se apertamente o per vie segrete, dialogano con la panchina di Musil collocata una volta per tutte nel quinto capitolo dell’Uomo senza qualità, la quale ha il potere di trasformare chiunque la evochi in un «viandante che si segga su una panca per l’eternità pur presentendo che si rialzerà quasi subito». Dal mese di marzo del 2020 non facciamo altro, ma con più confusione e meno poesia: ci alziamo, passiamo da una panchina all’altra, ci risediamo, ci rialziamo, poi ci mettiamo a sedere su una panchina ulteriore. Distrattamente paventavamo la seconda ondata di coronavirus; ora ci grattiamo la testa poco sopra l’orecchio, discostando il filo della mascherina; con l’altra mano restiamo aggrappati al cellulare e in meno di un’ora guardiamo i risultati della Premier League, la faccia di Unamuno, due ballerine di can can, i primi dieci titoli del catalogo di Bach, striature arancio fiamma sul teschio spaccato dell’America, scarpe da trekking, il finale preteribile di un video pornografico, decapitazioni, le ultime dal Grande Fratello vip, gli aggiornamenti sulla diffusione del contagio.
Alzandosi e risedendosi, o nell’atto di spostarsi da una panchina a un’altra per poi tornare sempre alla panchina che si era lasciata, troppe persone muoiono, altre impazziscono. Quasi tutti non ci capiscono nulla, molti dicono di capire tutto, alcuni si siedono e si rialzano come se niente fosse, altri ancora non ce la fanno più. Allora viene voglia di ricorrere a Kraus, per concludere: «La vita va avanti. Più del lecito».

 Se la campana suona per tutti - Vera Gheno
Se la campana suona per tutti - Vera Gheno Sfasature - Luigi Di Cicco
Sfasature - Luigi Di Cicco Di mosche e di farfalle - Gianfilippo Capotosti
Di mosche e di farfalle - Gianfilippo Capotosti Leggere al tempo del Collasso
Leggere al tempo del Collasso Saverio e la manutenzione della museruola. L’allevatore confonde le acque, vale a dire il discorso
Saverio e la manutenzione della museruola. L’allevatore confonde le acque, vale a dire il discorso Troppa veemenza. Al termine dell’invettiva, apparizione di un martin pescatore
Troppa veemenza. Al termine dell’invettiva, apparizione di un martin pescatore Tra i porci.
Tra i porci. 





















