
(Dal Quaderno di Discipline Grammaticali per l’Infanzia dell’alunno L. Decor, Classe delle Chiocciole, Aula della Fontana del Pio Istituto di S. Satiro per la Gioventù di don Giorgio Giorgio)
“So che stai scherzando!” “È andato da quella parte” “Nessuno mi può battere!” “Via, non facciamo i cattivi” “E tu non fare la spia” “Ma perché capitano tutte a me?” “Qui dietro non c’è niente” “Non dovrei dirlo, però…” “Adesso come farò senza di lei?” “Mi sa di essere veramente grasso” “Questa sì che è bella!” “E adesso come faccio?” “Gambe in spalla!” “Che spavento!” “Sarà poi vero?” “Farò finta di niente” “Giorgio e Sarahs sono amici”
C’è una macchia di vino sul materasso e un buco sulla tua camicia, C’è un buco sul materasso e una macchia di vino sulla tua camicia, Sono contento di partire ma mi dispiace che tu soffra, Sono contento che tu soffra ma mi dispiace di partire, C’è un topo nel muro e una cicala sull’albero, C’è una cicala nel muro e un topo sull’albero, Se vuoi dormire conta le pecore, Se vuoi contare le pecore dormi.
Letto, letto di un fiume, letto per dormire, ho letto un libro, anagrammi: lotte, tolte, l’etto
Arco, arma medioevale e sportiva, parola geometrica, arco alpino, anagrammi: roca, orca, caro, ocra, acro
Sella, sella per cavalli, sella per biciclette, tipo di carne, egli sella il destriero, anagrammi: l’elsa
Calcio, sport, pedata, minerale, io calcio un barattolo, anagrammi: colica, laccio
Ratto, topo, uomo che si nasconde <sic>, anagrammi: torta, rotta, trota
“Si vede che non hai ascoltato quello che ti ho detto” “Ti ho già detto sì tre volte” “Sì lo ammetto: certe volte preferirei sarmene <sic> da solo” “E così mi si accusa di aver tradito la tua fiducia!” “Eh sì! Devo ammettere che mi sei mancato” “Il cielo si fa con la stagnola” “Si rimirava allo specchio in continuazione e non si accorgeva di sprecare gran parte del suo tempo”
“Non riesco a farmi nessun amico in questa scuola” “Sei un asino! Guarda il tuo compito: è un’allucinante concentrazione di errori” “Un’oscura ragione ha spinto quell’individuo a lasciare la sua famiglia” “M’è parso di sentire dei passi” “Vi aspetto la prossima estate a casa mia”.
Fatele un po’ di posto,
È un uomo tutto d’un pezzo: m’è apparso
Di colpo davanti e ha fatto un accordo.
Giochiamo ancora insieme, d’ora in poi
Uscirò anch’io, qual è
La risposta giusta? Non è rimasto
Nessun amico, è stata
Un’inutile attesa.
“Io ho undici anni” “Non farmi brutti scherzi” “Il lupacchiotto ha sentito il richiamo dei suoi simili ed è scappato nei boschi” “Ci hanno regalato archi e frecce come Robin Hood” “Perché hai pochi amici?” “Streghe, maghi e orchi popolano le fiabe dei bambini” “Hai sbagliato tutto” “Pronto signora? Sono Gigi; sì, signora, sono proprio Gigi” “Ti presento Otto. Otto è fortissimo. Esso è un pastore tedesco.”
Io loderei temerei servirei
Io osservo il paesaggio
Tu accusi sempre me
Egli ricava vantaggi da tutto
Verrà anche lui a danza?
Noi non abbiamo sempre ragione
Voi camminate troppo in fretta
Sapranno loro cosa si deve fare
Tu loderai temerai servirai
A cinque anni io ero un fifone: lo dicevano tutti e non me ne vergognavo nemmeno. Avevo paura di moltissime cose: ragni, buio, ladri, etc. Non riuscivo a smettere di tremare davanti a tutto. Aspettavo di crescere. Era l’unica speranza, per guarire dal mio malessere. Mia mamma voleva portarmi da uno specialista ma avevo paura anche di lui.
Io ho una casa, tu hai una casa: chi di noi non ha una casa? Allora tutti ce l’hanno.
“Tu sei uno strano tipetto: non ci sei mai e all’improvviso salti fuori dal nulla” “Sei proprio un bel ragazzone: robusto e compatto” “Ho salutato la mamma, ho fatto colazione e ho ripensato al mio sogno” “Dopo quella gita in Kanada <sic> i tuoi muscoli si sono talmente rinvigoriti che sono duri come il legno” “Sono andato a Venezia, città bellissima” “La fioritura delle rose è assai colorata” “Non ho alcuna voglia di scherzare” “Guardate quello, non assomiglia a Rambo?” “I parassiti infestano questa pianta tropicale” “Un famoso regista dirigerà la commedia” “Non giocare con quelle lame, o ti taglierai” “Togliti quella ridicola maschera!” “Devo lavarmi via ogni impurità spirituale” “Non pulire ogni cosa, sempre; sembri un ossesso!” “Non cercare di difenderti: sei finito”,
Mi chiamo Luijgi, ho undici anni, sono alto 1m10cm e finora mi sono rotto una volta il piede destro e una volta la clavicola sinistra, mi sono slogato due volte una caviglia e altrettante il polso, ho avuto la scarlattina e gli orecchioni e credo in Dio.
“Tentai di difendermi con delle bugie, purtroppo ci riuscii”.
(Fine dell’estratto)
***
(Dal diario di L. Decor)
22/1/****. S. [Sarahs (n.d.r.)]? Evitare il pensiero come fosse un pugno in faccia. Non si è fatta viva. Non importa, tanto non tornerò mai a leggere queste parole. G. [non identificato/a; per certa venuzza devozionale del resto del documento taluno credette indovinabile un Giorgio Giorgio dietro l’iniziale… Riferiamo l’ipotesi per mero amore d’archivio, ma gli indizi paiono davvero troppo tenui, né si hanno notizie che L. Decor sia mai tornato nel pio Istituto di S. Satiro dopo aver compiuto i 13 anni] dice che se la amassi non penserei sempre a lei perché ogni tanto dovrei pensare almeno un pochino a me stesso. Me, intanto, non c’è anima viva che mi pensi, de me nemo cogitat tamen sum, se si fa eccezione per la mia famiglia, ma sono poi proprio certo dell’eccezione, che poi che dovrei farmene del loro pensiero, e questo vale per tutti, che dovremmo farcene tutti quanti del pensiero e più di tutto di quello altrui, non serve a niente se non a [illeggibile]. Lo smog di Schwarzschwarz è altrettanto nocivo che il fall-out di una bomba atomica. Per le strade ci sono cartelli che invitano le persone a non uscire di casa. Bisogna usare maschere antismog, forse persino maschere antigas. Il regime austroamazzonico lancia grotteschi proclami sull’aria tossica parificatrice. Piove sul giusto e sull’ingiusto. Non so perché scrivo queste cose. Davvero farei davvero meglio a cancellare tutto, e vale anche per gli altri. Tutto vale anche per gli altri. Da una finestra nell’appartamento vicino proiettano un film sull’asfalto del marciapiedi ai piedi del palazzo con una specie di proiettore portatile, come una grossa torcia. La punti su una superfice qualsiasi e vedi il film. Più ti allontani con la tua torcia proiettore, più la scena si allarga e i colori sfumano. Le persone calpestano i protagonisti cercando di capire il pezzetto di storia in cui sono capitate, poi proseguono per le loro faccende. Mi sento come chiuso in una cassa da morto, il rumore delle palate di terra sempre più remoto e irrimediabile. Per un cane la punizione peggiore è venire chiuso in una stanza da solo, con una parola dolce e una carezza. Mi stancherò di lei perché sono già stanco a morte di me. Il rumore delle patate. Da dentro la cassa da morto s’innalza il mio canto di tacchino.
7/2/****. Anche oggi al lavoro mi sono sentito male. Una giovane donna di Schwarzschwarz è stata fermata da o ha lei fermato due poliziotti. No. Ecco. Gli abitanti di un condominio di Schwarzschwarz hanno fatto una segnalazione alle forze di polizia riguardo una ragazza che viveva nel loro condominio ed era scomparsa da otto anni. Scomparsa nel suo appartamento. I poliziotti hanno trovato la donna rannicchiata nel salotto ormai ridotto a una discarica. Rannicchiata nel ciarpame, la chiamavano e non rispondeva, finché praticamente ci sono inciampati addosso. La madre quando è stata contattata dalle autorità è caduta dalle nuvole, ha detto che si occupava lei di portare quotidianamente il cibo alla figlia. Mentre parlavo sono stato preso da una specie di freddo diffuso e senza brividi, misto alla sensazione che il mio me cioè tutto quello che io sono potesse polverizzarsi, disfarsi in sabbia di clessidra da un momento all’altro. Un ragazzo dietro di me stava sistemando in un armadio bottiglie di plastica vuote. Sentivo ovunque sabbia fredda ovunque scorrermi ovunque attraverso OVUNQUE. È decisamente più mirabile osservare il tempo come sabbia che cade piuttosto che come lancette che girano e strisciano su se stesse e una sull’altra. Che nell’orbita ricorsiva del quadrante il tempo conservi o ritrovi la propria eternità è una volgarissima illusione, intanto il meccanismo richiede la manutenzione di uno specialista e poi l’eternità è per essere precisi la morte del tempo e non una sua qualità. Il vetro di una clessidra, “viceversa”, potrebbe anche durare oltre la scomparsa della razza umana sebbene naturalmente nessuna mano allora girerebbe più la clessidra, ma anche così resterebbe una mirabile immagine del tempo. L’ho già detto, ma avevo promesso a me stesso di. No. Sapremmo riconoscere l’oggetto di una civiltà aliena? Avrebbe sempre gli stessi connotati richiesti per essere definito “oggetto”? Posso immaginare un’intelligenza aliena o angelica che di fronte a una clessidra riterrebbe si tratti di un oggetto naturale? Che riconoscesse subito la ragazza senza scambiarla per altro ciarpame?
13/2/****. Pensieri violenti verso A. [forse Adra, all’epoca poco più che diciassettenne (n.d.r.)], paura che possa tradirmi e soffiarmi l’idea [allusione al progetto del film dal Tour du monde en 80 jours, mai realizzato (n.d.r.)]. Soffiare l’idea. Soffiare, gote che si gonfiano come allegorie barocche dei venti, voilà un soffio e voilà l’idea si gonfia come una mongolfiera che atterra nel giardino del vicino. Il pensiero delle crudeltà che potrei infliggergli come ad esempio bloccarlo mentre mi incrocia in un vicolo e spingerlo contro un muro e sfondargli il cranio a testate, disperate spietate testate che gli facciano sbattere la nuca contro il muro fino a sfondargliela; resterebbe in piedi morto, la nuca fracassata appiccicata al muro, le cervella a fare da adesivo? Urlare a tutti polmoni vicinissimo a un orecchio fino a fargli scoppiare un timpano, strillare come una sirena fino a sentire sotto il palato il profumo metallico del sangue. Succhiargli via gli occhi dalle orbite. Da diverse ore un punto della tempia sinistra, vicino all’occhio, tremola come se fossi un androide in cortocircuito. La nave di Phileas Fogg, il cammino di non conoscenza di Passepartout sono rimasti occultati da una nube di violenza stolida su A., che mi ha impedito di fare un qualsiasi pensiero sensato.
Phileas Fogg che per continuare la navigazione brucia nella caldaia della nave che lo trasporta i pezzi stessi della nave che lo trasporta, Phileas Fogg che brucia A. nella caldaia dell’Henrietta, spingendolo ancora più giù nelle braci con un remo da gondoliere, Phileas Fogg l’assassino del tempo, il moltiplicatore dei giorni, pronto a ripartire daccapo non appena rimesso piede in Inghilterra, come una lancetta, Phileas Fogg l’avversario del sole. Capovolgere la clessidra e spaccarla in bocca a A., ricaricare l’orologio mentre dalla bocca spaccata di A. cola una pappa scintillante di sabbia impiastricciata di sangue e pezzetti di vetro. I riflessi del sangue si mescolano al canto degli uccelli. Phileas, Phileas, Phileas… L’idea che A. abbia parassitizzato, fin da subito, con i suoi diligenti e pignolissimi appunti, [illeggibile].
14/2/****. In fondo non saprei bene nemmeno io cosa volere da lei, il mio desidero ormai ha preso la forma di un esercizio meccanico, desidero una figura che si chiama S. ma che non ha ormai più un bel niente della vera S. e se proprio devo immaginare un corpo per questa figura è un corpo grigio, metallico, da manichino di posa e senza nemmeno gli occhi e la bocca ma anche così continuo a volerla mia e piango almeno una volta al giorno come un altro si eserciterebbe al violino o al salto della corda. L’occhio continua a tremare. Non riesco a smettere nemmeno di pensare ai topi di V. [allusione non ulteriormente ricostruibile a uno degli innumerevoli pasticci di Valmarana che portarono al naufragio del film], ed è sicuramente anche il doppio manifesto [vedi nota precedente] l’origine delle mie paure quando si tratta di fare qualcosa con qualcun altro e quindi anche del mio odio senza confini per A., un odio quasi meraviglioso per quanto è sconfinato e ancora, e ancora e ancora di più del male, prima di rompergli o subito dopo avergli rotto i denti contro i gradini di una fontana vorrei che A. strisciasse ai miei piedi gridando ad alta voce grondante denti e gengive e lacerandosi il petto come non ho mai visto fare ma qualcuno l’avrà pur fatto una volta o l’altra e quindi una volta per tutte lacerandosi fisicamente il petto riconoscesse di essere un mio parassita, mio, mio, piango mentre lo scrivo, tutto è così sconfinato, mio, che vive del mio sangue, in modo che poi quando lui lo abbia riconosciuto e abbia implorato il mio perdono io sia libero di sfondargli la testa a calci senza pietà, un mio parassita che ha preso anzi rubato rovinato una dopo l’altra tutte le mie idee e quindi tutta la mia vita perché cos’è ormai la mia vita se non un buio nido di idee nere e deformi come ragni o come vipere, tutte le sue idee migliori vengono in realtà da me, sono strisciate fuori dal mio nido nere come lancette di orologi, e alla fine proprio un attimo prima che morisse vorrei che non solo io non solo lui ma tutti lo sapessero anche gli altri chiunque essi siano, sì, come per un matrimonio, sì, che tutta la società lo dicesse, dicesse eccolo, il parassita, eccolo il ladro, tutta la società lo additasse mentre a furia di calci lo trasformo in una pozzanghera di carne.
15/2/****. Al liceo la vecchia insegnante di latino con il taglio di capelli e anche il naso da Cleopatra tirava indietro il collo gozzuto e nitriva “socìììììììetas!”. Pronunciava la ci come una zeta, “sozìììetas”. Nella sozìììetas si è sottoposti a un ininterrotto diuturno giudizio universale che però non è mai universale perché ricomincia sempre daccapo ogni volta che la sozìììetas ferma i suoi infiniti occhi su di noi e proprio perché non è universale ci logora e vermina, più dell’inferno ci logora, più del paradiso ci vermina, e non siamo neancora <sic> morti ossia questa è l’unica immortalità, un logoramento e un verminare che non arrivano mai alla fine, resta sempre ancora un pezzettino da logorare, come con Achille e la Tartaruga solo che noi non siamo né l’uno né l’altra, siamo la pista su cui “corrono”… e la condanna a non riuscire mai più a ritornare, come ci era stato promesso, polvere come polvere alla polvere, ecco il giudizio universale della sozìììetas. Tutto quello che facciamo è esposto e insieme viene esposto, cioè è esposto a noi tutto quello che le persone pensano di noi, e quindi noi crediamo di poter modificare quello che gli altri pensano solo passando attraverso gli altri, cioè è sempre un altro quello che ha la verità ossia che ha il controllo di una verità, magari poi neanche vera, di una verità su di noi, noi in quanto noi e noi perciò siamo su di noi automaticamente bugiardi perché la verità che poi comunque è falsa ce l’hanno gli altri. E alla fine che poi non è mai una fine ovvero è sempre fin dall’inizio e di continuo la fine del mondo, e alla fine scenderanno i like dai cieli di stagnola a separare i giusti dagli ingiusti fino alla prossima volta. A furia di cercare di rendere reali le favole ci ritroviamo a “vivere” in un testo sacro da noi fatto realtà. La realtà di un testo sacro non è nient’altro che un presepe. Quanta tecnologia è il risultato del desiderio di vivere in un mondo fatato in cui non è più decente credere? E quando uno smette di credere, ecco che tenta di portare a realtà. Provi a realizzare le cose perché non ci credi più, se ci credessi veramente non avresti bisogno di fare nulla. Se la amassi veramente.
12/3/****. Ti prego salvami. Non so nemmeno a che dio sto scrivendo. Sempre più spesso mi sorprendo nella posizione in cui sorprendevo mio padre proprio come se mi sorprendessi due volte, lo sorprendevo e percepivo la sua disperazione e il suo odio per noi così tanto forse da vivere e bruciare tutto quell’odio su di me per amore di mio padre. Appollaiato sul water a scrivere dentro una casa vuota: il gabinetto è l’unico posto in cui riesco a trovare un po’ di pace perché è l’unico posto dove devo andare, dove non è possibile non andare. Solo quando io devo, io ho pace. Ti prego salvami. Non so che dio sto pregando e questo è un male anzi è il male, sei libero anzi liberissimo di non conoscere te stesso ma cosa ti accadrà se non sai qual è il dio che stai pregando? Il continuo panico che qualcuno rubi o abbia già rubato prima ancora che l’abbia avuta l’idea che io ho avuto finisce per cancellare l’idea che ho avuto. Non riesco a smettere di tremare. Modellino del mio appartamento realizzato con la pignoleria di una casa di bambole e, intagliata con altrettanto rabbiosa meticolosità, una statuina di me appollaiato sul water a scrivere, e sul piccolissimo quaderno lo spettatore dell’esposizione che per capriccio volesse–– Ora che ho in mano la penna le formiche di ferro smettono di scendere lungo le sbarre del mio letto almeno per un po’. Microscopici ticchettii di ragni lungo le sbarre di ferro del mio letto mi svegliano come un ronzio elettrostatico o una pioggia invisibile, un inferno momentaneo privo di interesse per gli altri e proprio per questo tanto più tremendo. Come l’elettrostatica sulla superficie dei vecchi schermi catodici lungo tutto l’interno del cranio, tra il cranio e i meandri della materia grigia, un formicolare per cui non c’è spazio e che spreme lungo i meandri nuvole gialle piene di denti. I gabbiani di Venezia agitano ali di tacchino sui cesti d’immondizia. Quando smetterà di sprofondare Venezia, i suoi campanili di piegarsi sopra le case, i suoi isolati di contrarsi su sé stessi scintillando come grani di zucchero inghiottiti nella schiuma del cappuccino. Tesori che sprofondano nella melma. Arriveranno a salvare il salvabile ma la città sprofonderà. Inizieranno a costruire sui tetti di Venezia una nuova città. Quante volte è già stato fatto come per i villaggi preistorici. Quante infinite volte è già stata salvata. Il salvabile come uno dice pieghevole o estraibile o deducibile, quasi l’essere salvato fosse un optional in più, una capacità che ci renda più interessanti e accessoriati. Salvabile da cosa. Osservare aggrappati a un’ultima stereotipa tavola di legno un elicottero americano che solleva le pesanti statue d’oro azteco che tu contempli quando chiudi le palpebre, che le sollevi e le trasporti in una nuova melma lontana, via da Venezia. Disegnare la scena su un’anfora greca, l’elicottero, le rovine e il trono azteco come antichi dèi ed eroi. Chiudi le palpebre e vedi denti vegetali che ti si avvinghiano intorno con volute di fumo che sono in realtà anche loro gorghi di melma perché quando chiudi gli occhi o come un’altra Venezia sprofondi dentro di te di melma vedi che sei e che la città non finirà mai di sprofondare un’infernale sequenza di Venezie una costruita sopra l’altra e la prima ormai così sprofondata da essersi fusa con il centro della terra come un vaso di vetro malriuscito che viene di nuovo spinto nella fornace e torri orientali che fondono come candele di cera ritornando nel nucleo incandescente dove tutto ciò che esiste è da sempre condannato a esistere, ancora. I gondolieri urlano tra le fiamme come i primi diavoli venti secondi dopo la Creazione.
13/3/****. Angelo con ali di tacchino spennato. Gigantesche ali di tacchino spennato. Salgo le scale trascinando da una stanza all’altra gigantesche ali di tacchino spennato e la loro puzza di macelleria. Gigantesche inutili ali di tacchino spennato che si ostinano in slabbrati sbatacchiamenti come cubetti di anguilla appena tagliati e ancora palpitanti. Ali di tacchino avvolte nel cellophane e il loro rumore mentre cercano inutilmente di sbatacchiare. Nel cellophane fanno un suono come leccare la stagnola di un uovo di pasqua. Dormo nella mia tana come un orribile demone piumato. Ho sognato di avere una scrittura differente da quella che ho. Scrivevo e non riconoscevo la mia grafia.
14/3/****. Restava un mistero quel che pensasse suo padre quando si teneva la testa nelle mani come in una retina per i capelli. Da bambino a lui era stata messa la testa in una rete di tubicini di plastica. Forse anche dietro le dita di suo padre si agitavano scene di massacro come nei tubicini di plastica. Non era nemmeno necessario che fossero pensieri, non è necessario che tutti pensino pensieri; suo padre non era mai stato bravo a parlare, le parole dell’interlocutore dovevano filtrare attraverso la rete delle sue mani prima di accoccolarsi nel cervello, accoccolarsi e radicarsi ormai già sformate e ansanti, piante parassite e ansanti abbarbicate alla scogliera grigia del cervello di mio padre (ma non è forse così per chiunque, con le parole di chiunque? Le parole di chiunque, le nostre comprese, si abbarbicano e radicano sulla scogliera grigia del nostro cervello, e in questo modo contaminandola la tengono nello stesso tempo intatta, le impediscono – oh, momentaneamente, dato che nessuno sfugge al proprio dovere – di sbriciolarsi, di franare beatamente su se stessa così come fa tutto ciò che è parte di questo mondo –– non è questa la prova più certa che le parole non sono di qui?) e così i massacri si aggrappavano alle sue dita impedendogli di rispondere a tono, ubriacando le parole. Un’intera esistenza soffocando massacri, minuscoli e sempre più brulicanti massacri, una suddivisione e proliferazione di minuti massacri che negli ultimi anni di vita dovevano aver preso l’aspetto di un interminabile formicaio di ferro preda di una qualche guerra fratricida, i massacri… pulviscolari formiche di ferro che il merletto delle dita di mio padre era troppo grossolano per trattenere.
(Nota sul letto di ferro: [Nota alla Nota sul letto di ferro: prossimo all’“assunzione” presso uno dei sottoreparti per lo studio delle interazioni tra i cosiddetti “labirinti” e i primi prototipi ancora non dematerializzati di Psyche®, L. Decor, ignaro che tale pratica di assunzione presso la ditta di giocattoli era in effetti parte di un intricato test interno per valutare il funzionamento/gradimento delle (genitivo oggettivo e – scienziati e assistenti cantano in coro alleluia – soggettivo) prime Psyche® effettivamente dematerializzate e installate in gran segreto nella corteccia del prigioniero L. Decor stesso nonché di altri “assunti”, ha raccolto qui di sua iniziativa alcune per noi non poco preziose informazioni sull’imperscrutabile fase del “risveglio” durante il sogno nel sogno nel sogno etc. ad infinitum dei lettini di ferro] A volte, nel sogno dei letti di ferro, tra un risveglio e l’altro si insinuano visioni estranee. È probabile che il loro scopo sia quello di rendere ancora più crudo l’ennesimo risveglio. È come se per un attimo, attraverso un buco nel materasso, attraverso la paglia si potesse indovinare uno scorcio alpino, del muschio carnivoro intriso di miele e api quasi morte, serpenti neri che si lasciano scivolare lungo i tronchi degli abeti. Si sente persino il fragore lontano di una cascata, poi il canto degli uccelli e le strida degli scoiattoli diventano sempre più forti fino a fondersi nelle urla degli altri legati ai lettini, come luce nella luce / fango nel fango / mosche nelle mosche / sabbia nella sabbia / occhi negli occhi / bocca nella bocca / morte nella morte / fiori nei fiori / cancrena nella cancrena / vermi nei vermi. ––––––– Altri sogni che capita di fare ai condannati al letto di ferro: Una sequenza di case coloniali in un giorno d’estate. Le finestre, i gradini e le grandi terrazze bianche scorrono davanti al sognatore come quinte di cartone; a volte qualcuno (di solito un vecchio Jim, un vecchio nigger) si affaccia dall’ingresso di una delle case o da una finestra, o da una baracca di negri [sic; il prigioniero non ha manifestato altri segni di razzismo linguistico] e saluta; per strada passano dei bambini; dopo un po’ ci si accorge di essere guardati da tutti; tutti ci lanciano occhiate ospitali, cortesi, ammiccanti, e infine divertite; il tipo di strada e di volti fa pensare a una città degli Stati Uniti del sud, forse proprio New Orleans, il che ha fatto sorgere il dubbio [in chi? qualcun altro è in contatto col prigioniero L. Decor? La questione, tutt’altro che peregrina, tutt’altro che risolta e ben lontana dalla pace dei registri d’archivio, è attualmente in mano alla Commissione per la Sicurezza dei Condannati] che l’intera faccenda sia legata in qualche modo al voodoo; esiste una architettura voodoo? Alla fine, uno dei negri ci si avvicina e ci fa notare alcuni dettagli dei cortili e dei balconi, e così ci rendiamo conto di essere già passati per quella via. Il negro si avvicina ancora di più e bisbigliandoci all’orecchio col tenero sussurro che è la forma più ancestrale, sciamanica, del blues, ci rivela che il quartiere in cui siamo capitati è stato congegnato in modo che sia molto semplice entrarvi, impossibile uscirne. Continueremo a ripercorrerlo in eterno, ecco l’accordo segreto del blues che il negro sussurra. A questo punto cerchiamo di ricostruire in che modo siamo finiti in quel quartiere, scoprendo con sgomento – e infine ingannevole sollievo – di non sapere nemmeno in che modo siamo arrivati negli Stati Uniti, mentre il bisbiglio del negro si confonde con il rumore del vento del sud e infine con i sospiri e le grida che arrivano dagli altri lettini di ferro. ––––––– Il caso di interi quartieri a “labirinto” come quello della pseudo New Orleans è comunque raro. Più spesso si tratta di luoghi più piccoli e architettonicamente non-significanti, pianerottoli e scale esterni che fanno da collegamento tra due case altrimenti separate, pozzi di scale condominiali o cavedi inaccessibili sui quali danno soltanto finestre e tubature, etc. Questo in particolare è decisamente ben congegnato [Nota: Procedendo nella stesura della Nota sui letti di ferro, con ogni evidenza il prigioniero L. Decor si sta, beninteso solo brevemente, svincolando dall’incubo a matrioska dei lettini di ferro, indovinando per un attimo di non essere appollaiato sul water di una casa vuota o tantomeno in un finto quartiere di New Orleans ma in un per lui comunque inaccessibile e verosimilmente laboratoriale altrove; qui insomma L. Decor tramite la pratica scrittoria sembra aver ottenuto la dubbia grazia di sollevare uno degli infiniti veli che lo separano dal L. Decor in carne ed ossa, sempre che carne ed ossa ancora ci siano], dato che mi ci sono ritrovato senza minimamente accorgermene (e dovrei essere uno che ha occhio per queste cose), durante una passeggiata; e ora che ci sono capitato, non so proprio più come uscirne. La cosa interessante di questo “labirinto” è che è costituito solo da due scale e un pianerottolo che le collega. Nient’altro. Di fatto non esistono punti chiusi, anzi, il pianerottolo è quasi una piattaforma su spazi aperti [Nota: Sovente uno dei segnali della presenza di un “labirinto” è un luogo-sosia, ovvero un luogo quasi identico a uno già noto alla vittima: gli echi reciproci di forme, come ormai sanno anche i sassi, sogliono indurre nella vittima una sonnolenza de-realizzante, rendendola per così dire più docile durante il cammino verso l’altare o il tavolo operatorio o dove si voglia portarla], montagne velate dalla pelle mesozoica e annerita dei ghiacciai, case sistemate in incaica aderenza di mura, gradini, ringhiere, orti, cortili e pollai, e più oltre prati e fontane e paludi e caverne: tutti però irraggiungibili. Posso anche vedere da qui quei mezzi vicoli tra casa e casa attraverso i quali talvolta si può trovare un passaggio (buono però solo per chi non soffre di claustrofobia, e non è il mio caso) rimasto inosservato al costruttore del “labirinto” [Tra i primi esempi di tali passaggi, il vicolo cosiddetto degli Ebrei nel “labirinto” cinquecentesco individuato nel 1801 sotto la vecchia sinagoga di Briwen, oggi meta di visite turistiche per via dei rilievi geometrici che ne decorano le pareti di legno, e nelle cui linee malferme ci fu chi volle riconoscere un “antidoto” alla meandrogenesi indotta dalla struttura subliminale dei “labirinti” – il principio dei “labirinti” è che, quella dello smarrimento non essendo altro che una condizione mentale, è sufficiente (si fa per dire) avvolgere meandri apparenti attorno alla vittima perché essa vittima maturi con ultraviolenta rapidità la convinzione subliminale della insolubilità di detti meandri –– il cuore del “labirinto” è la vittima stessa, ecco una delle verità ultime, apparentemente fatua ma veneratissima da tutti “costruttori” di “labirinti”]. La bravura consiste nel fare in modo che l’entrata, l’ingresso nel “labirinto” siano il più possibile impercettibili entrando, impossibili da ritrovare per chi poi vuole uscirne. Siano in altre parole ovvero “parole” il più possibile una “entrata”, un “ingresso”. Non è possibile sopravvalutare l’importanza e la delicatezza della progettazione e realizzazione dell’ingresso di una costruzione simile. I “costruttori” sfruttano tecniche di ipnosi propriocettiva tali che il percorrere un certo luogo architettonico disposto secondo ben precise regole geometriche induce nell’osservatore una sorta di trance, che “naturalmente” aumenta in intensità ogni volta che si ripercorrono quelle linee, ma che nei “labirinti” più riusciti (per ovvie ragioni nessuno ha mai potuto redigerne un catalogo; i “labirinti” più riusciti in assoluto sono quelli che appena chiusi hanno inghiottito i loro stessi costruttori, un qualcosa di vagamente egizio; sono noti anche come “stanze nere” e la loro esistenza è puramente ipotetica, dato che il trovare quelle “stanze” coinciderebbe col venirne immediata- e in apparenza volontaria- mente risucchiati). Si dice che Wagner con i suoi Leitmotiv è stato a un passo dal creare, nel Parsifal, un “labirinto” musicale (ben inteso da non confondere coi labirinti armonici di poniamo un Bach o un Mozart). Nietzsche arrivato la prima volta al cancello di casa Wagner ha raccontato di aver sentito uscire dalle finestre continuamente ripetuto lo stesso accordo al pianoforte… La cosa che qui mi ha messo in allarme è stata una di quelle colonnine classicheggianti che si trovano in certe ville degli Stati Uniti del sud. Pare infatti che il primo “labirinto” americano sia stato ottenuto relativamente tardi e, per quanto possa apparire incredibile, per caso, durante la costruzione del set di Gone with the Wind (tale “labirinto” è stato poi distrutto per liberare parte del cast che vi era rimasta intrappolata; non è in realtà del tutto certo che il film fosse proprio Gone with the Wind; a volte le cose famose e le famigerate si fondono insieme per una sorta di attrazione gravitazionale mitogenica. Sembra comunque certo che il tipo di architettura del primo “labirinto” d’oltreoceano fosse di matrice palladiana. Sommariva nella sezione della sua diacriticamente irta Storia e “storia” delle (“)architetture(”) dedicata all’“architettura” congettura con prosa deliberatamente macchinosa che «la prima idea per la realizzazione di un “l.” [sia] stata data dalle porte dissimulate nelle stanze delle onuste, zuccherose nonne lagunari del sedicesimo secolo che usate per caso (le porte, non le nonne) da chi ne ignorava l’esistenza diventavano tuttavia poi introvabili (in questo caso anche le nonne); classico ancorché anodino sia per la teoria che la pratica del “l.” è pure il riferimento alle varie architetture mortali o carnivore descritte nell’Hypnerotomachia nonché nel Furioso, che pure la segue e va da questo concediamo eccentrico punto di vista considerato descriptus almeno quanto il salone del primo capitolo dell’Alice in Wonderland (ed è del resto, il Furioso con beninteso l’Alice, infinitamente meno dettagliato e perspicuo dell’H., la quale a propria volta da questo secondo e benché parentetico non meno eccentrico punto di vista…)» et cetera). Orbene i “costruttori” più abili, in ispecie gli americani, mettono sempre uno di questi “segnalini” palladiani (nei manuali di “costruzione” dei “labirinti” ci sono pagine intere in cui le virgolette circondano quasi ogni parola, le cosiddette pagine lacrimose, e se tra l’altro si tiene conto che la gran parte delle parole virgolettate viene anche abbreviata l’effetto è graficamente piuttosto notevole, esso stesso una sorta di “labirinto” per chi volesse dipanare frasi come tanto per fare un esempio «nel “niellare” l’“h.” al “f.” tramite il “j.” non dimentichi il “c.” di “delungare” prima di “incidere” il “t.” e la “t.” onde “schifare” e nondimanco schifare non sia dissimulata la “m.” di una “p.” dopo l’“i.” dei “v.” bensì tale “prima” “d.” si sdipani “nella” “v.” all’apparire conclusivo di una testa di cavallo in fiamme» [Nota: A fronte a tali esoterici canovacci qualche bello spirito accampò la congettura che la canzone infantile della Macchina del capo col “pss” nella “gmm” fosse stata composta quale sorta di segreto inno “massonico” da un “costruttore” di, ovvero da una vittima fortunosamente fuggita da, un “l.”; approdata inizialmente presso le sole Accademie, ignare e dei giochi dei bambini e sorde alla possibilità di poter diventare bersagli della minuscola e golosetta fatina degli Scherzi, tale burlesca congettura sventuratamente attecchì, e ancora oggi, come suol chiosarsi passim, fa cucù fin nei più paludati volumi di teoria dell’architettura “labirintica”, che anzi più vi s’invescano quanto più s’impaludano]). La presenza di un simile “segnalino” è, qualora chi cade nella trappola sia a propria volta un “costruttore” o come me per lo meno un conoscitore di “labirinti”, sia un avvertimento che un decisamente yankee guanto di sfida che (nel caso il costruttore o l’estimatore non riesca ad uscire dal “labirinto”) un crudele sberleffo. Anche se ormai è tardi, mi piace lo stesso soggiungere che chiamare questo tipo di strutture “labirinto” è in parte improprio (e le ubique virgolette dei trattati stanno appunto a rivelare/disinnescare questa ovvero queste improprietà), in quanto tali strutture, pur essendo concepite per intrappolare la vittima proprio come i labirinti tradizionali, tuttavia né possiedono un centro né hanno (parlo delle migliori, e di che altro bisorrebbe poi parlare, ma coi tempi che corrono) nulla di disorientante (come appunto la passerella di cemento armato in cui sono capitato, che potrebbe essere agevolmente esaminata palmo a palmo nel giro di poche ore, dato che la sua metratura complessiva non supera quella di un piccolo monolocale). È anzi raccomandabile evitare quanto si può di sottolineare o suggerire una qualsiasi somiglianza con un labirinto tradizionale. L’omonimia tra le due strutture è dovuta al fatto che i “costruttori” di (infine, continuiamo a chiamarli così) “labirinti” hanno realmente l’esigenza, di solito di natura patologica, di intrappolare le persone e isolarle il più possibile dal resto del mondo, e per far questo vogliono naturalmente tenere il più nascosta possibile la loro disciplina, in modo da non degradarla ad attrazione da lunapark come è accaduto ai labirinti tradizionali. E quando si vuole passare inosservati non c’è miglior anonimato dell’omonimia. Comunque sia, per la vittima l’importante è accorgersi prima possibile di essere caduta in un “labirinto”; data la natura ipnotica delle geometrie della struttura, infatti, ogni nuovo giro nel “labirinto” è come una nuova oscillazione del pendolo o un nuovo giro della classica spirale di un ipnotizzatore da cartone animato, e non farebbe che rinforzare la trama della trappola: come un sogno che, sognato e risognato più e più volte, finisce per assumere agli occhi spiraleggianti del sognatore la stessa reale consistenza delle sbarre del suo lettino di ferro. È essenziale perciò riuscire a fermarsi entro il secondo giro, al termine del quale bisogna osservare rapidamente il luogo in cui ci si trova cercando un qualsiasi tipo, anche minimo, financo impossibile per il proprio corpo, di apertura verso l’esterno (si ricordi il sia pur fumosissimo cenno a Carroll nel Sommariva). Se non si indovina nemmeno uno spiraglio, ci si deve rassegnare a morire lì. In questo particolare “labirinto” ci sono come dicevo addirittura ampie aperture, che però appunto mettono quasi tutte in luoghi impraticabili, e pertanto sono state certamente concepite per far fare un terzo e fatale giro alla vittima. [Nota: Il fatto che per i “labirinti” migliori siano sufficienti tre giri completi per rimanere intrappolati ha dato luogo ad alcuni buffi incidenti capitati a “costruttori” di “labirinti” particolarmente paranoici che per un caso qualsisia non erano riusciti a trovare sufficientemente in fretta l’uscita da un luogo tuttavia innocuo: non essendo venuti a capo della faccenda nei due canonici giri del locale in cui erano capitati, tali “costruttori” erano rimasti immobili e terrorizzati in quella stanza di fatto inoffensiva. Simili intoppi normalmente si risolvono con l’ingresso nel luogo in questione di una seconda persona, col che l’uscita dall’apparente “labirinto” viene subito rivelata, ma si favoleggia di malcapitati “costruttori”, sempre terrorizzati dall’idea di finire in “labirinti” costruiti da propri fantomatici avversari, finiti, tali ipertesi “costruttori”, in stanze non “labirintiche” ma nello stesso tempo mai utilizzate da nessuno; una volta compiuti i due giri di perlustrazione e non trovata come può capitare a chiunque l’uscita, i poveretti si dice siano rimasti fermi fino alla morte in quello che credevano essere un “labirinto” ma che in realtà era una stanza come tutte le altre, resa letale dalla loro (dei “costruttori”) paura che fosse un “labirinto” e dall’oblio (della stanza innocua) da parte del resto del genere umano. Possibili in linea teorica ma anch’essi non verificabili da un punto di vista pratico (nel momento in cui qualcuno si ricordasse di una certa stanza in fondo a chissà quale androne di chissà quale struttura, e andasse a controllare che non vi fosse chiuso dentro nessuno, quella stanza smetterebbe ispo facto di essere quella teorica trappola di cui si parla qui), simili luoghi innocui ma loro malgrado mortali sono chiamati “stanze bianche” –– qualche ulteriore buontempone (tanti ce n’è che bighellonano fuori dalle aule di “architettura”, schiamazzando come gabbiani affamati intorno a un peschereccio) ha proposto di battezzare le stanze bianche reduplicando le virgolette: ““labirinti””, anche se è naturalmente impossibile immaginare un ““manuale”” o anche solo un ““costruttore”” di simili ““strutture””, dato che è stato un “fortunato” mix di paranoia e dimenticanza a ““produrle””]. Decido di tentare la via più azzardata solo perché, dal punto in cui mi sono fermato al termine di quello che spero essere il secondo giro, è la più vicina. Si tratta di una finestra malchiusa con un vetro smerigliato e dipinto di bianco, di sottigliezza quasi friabile, malfermo nel telaio. Dopo una spinta piuttosto energica, la finestra si apre. Non so se questo vada considerato un buon segno. La cosa diabolica dei “labirinti” è che l’uscita è lì, in quei pochi metri quadri, magari proprio davanti al nostro naso; si può uscire in qualsiasi momento – ma la terra in fondo è solo un immenso labirinto –– è da queste costruzioni che hanno origine varie credenze o se si preferisce fiabe gnostiche, è da queste fiabe che hanno origine varie costruzioni e credenze ––– raccontano di ordini misterici autointrappolatisi in un “labirinto” del quale progressivamente e dall’interno espandono l’architettura, con lo scopo finale di ingoiare tutta l’umanità in un “labirinto” che a questo punto coinciderebbe realmente cioè fuor di melense sofisticherie con il mondo, il quale andrebbe allora “ribattezzato” “mondo” –––– letali sette terroristiche di “architetti” il cui saluto segreto è il segno virgolettante delle dita – ma più si cerca l’uscita meno si ha la possibilità di trovarla. La sensazione è simile a quella di avere una parola sulla punta della lingua, solo che la si avverte con torturante specificità in tutto il corpo, come una dolorosissima sorta di sanguinante infiammazione dell’invisibile organo della propriocezione. Le vittime del “labirinto” finiscono la loro vita in questo orribile stato. Si ha costantemente la sensazione che l’uscita sia vicinissima, di averla appena oltrepassata con lo sguardo. Basta voltarsi. Dalla finestra vedo l’interno di una cucina. Vasetti di marmellata, tazze usate da poco. La cucina è spaziosa e luminosa, in legno; stile tirolese o austriaco. C’è puzza di muffa. Forse è una via buona. Ci sono zampe di capretto imbalsamate, incollate in punta a cannette da passeggio, o forse bacchette da precettore, da direttore di banda… Cerco di chiamare qualcuno della casa, ma la gola mi si è talmente seccata che ne esce solo un suono roco e soffocato.)
Foglio extravagante, non datato. Gli alberi sono le vene, il cielo è la carne, la luce è il sangue: gioia dell’invisibile donna leopardo che mi dondola accanto.
La lumaca pavone
porta gioia e morte sotto la luna
fantascientifica di un cielo alieno.
Vedere labirinti
è l’effetto del suo
veleno, file di denti bianchissimi
e microscopici escono
ed entrano dal corpo
del pavone lumaca
Come una lenta fila di guerrieri lungo i petali giganteschi del fiore di gatto.
Vedere labirinti, gioia e morte. Venire poi di scatto arrotolati come una oltremodo sinistra trombetta di carnevale.
Uomo che si nasconde.
(Fine dell’estratto)

[continua l’11 febbraio]

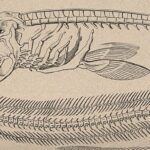 Presiden arsitek/ 58 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 58 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 23 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 23 - Angelo Angera A Frolic of His Own - Angelo Angera
A Frolic of His Own - Angelo Angera Presiden arsitek/ 47 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 47 - Angelo Angera Abracadabra Maradona
Abracadabra Maradona Lo stagno di lacrime
Lo stagno di lacrime Presiden arsitek/ 5
Presiden arsitek/ 5 Se questo è un servo.
Se questo è un servo. 





















