
Odiavo gli ospedali fin da bambina, quando mi ci portavano a vedere i nonni ormai senza speranza di guarigione. In mezzo a corsie verdoline, in penombra, le persone si trascinavano con passi lenti, facce basse e colori strani sulla pelle, ricoperta da pigiami tristi. Di una tristezza che sembrava imposta da una montura, e che per essere curati, lì dentro, occorresse indossare pigiami smorti, lisi e sghembi.
Alle pareti stavano aggrappate le luci fredde, la puzza dei disinfettanti, i gemiti di chi soffriva. E io ci passavo in mezzo senza capire come fosse possibile. Come si riuscisse a stare in un luogo simile, essendo già caricati dal peso di un male. Oppure (ancor più incomprensibile) come si riuscisse a lavorarci. A rintanarsi tutti i giorni in quel cumulo di orrore senza esserci condannati da una malattia. Restare tutto il giorno in mezzo a questa non-vita, al blocco di tutte le attività normali; il mondo attivo, colorato e profumato fuori, e lì dentro questo non-mondo, queste persone che non facevano niente, si trascinavano tutto il giorno senza desideri.
Anche quelli che sapevano che sarebbero guariti, finché stavano lì dentro avevano l’espressione di chi non vedeva niente, nelle ore passate lì. Solo il fatto che stavano passando, e che prima o poi sarebbero tornati fuori.
Mi stupivo dei medici che camminavano con aria baldanzosa, scherzando con i pazienti: “Come va oggi?” alla vecchia con la smorfia di sofferenza sulla faccia. E la vecchia che cercava di ricomporsi, di tirare fuori un po’ di forza e di buon umore da chissà dove per sorridere un: “Eh, che vuole, così…” gentile, rispettoso, quasi civettuolo, al giovane medico aitante. Che passava subito a un altro paziente, ancora più malconcio, e poi a un ragazzo col tubo che usciva dalla gola, che non avrebbe più parlato, e via, di nuovo per i corridoi, ridendo e raccontando storielle ai colleghi. Com’era possibile?
E gli infermieri, a raccogliere gli umori, i lamenti, le piaghe e gli escrementi dei pazienti. A dosare le medicine, provare e riprovare temperature, pressioni, ossigenazione. Senza possibilità di distrazione. Un pensiero oltre ciò che stavano facendo era già troppo, era già una svista, un probabile errore. Anche loro concentrati, condannati all’attenzione, eppure anche loro ciaccolando con i malati, rincalzando un letto, battendo un incoraggiamento su un braccio. E poi spingendo carrelli carichi di boccette, parlando della loro vita fuori, bambini, scuole, ferie e case in affitto. Come facevano?
Io, per me, non ci sarei più entrata, dopo aver perso i nonni. Così avevo deciso.
Ma poi, come spesso capita, ho dovuto sperimentare il contrario di quanto mi ero ripromessa, e in ospedale ci sono finita varie volte per i motivi più disparati. Gravi e meno gravi, lunghi, rapidi, dolorosi o leggeri, ma che mi immergevano comunque, per tutto il tempo del ricovero, in questo senso di non-luogo, non-vita, non-tempo, non-umanità.
Un non-posto dove non-stare davvero. In cui sfuggire da se stessi, in una dimenticanza di quello che si è, dei gusti, del passato, delle attività di fuori. E senza essere completamente coinvolti in quelli di dentro. Stasi, attesa, superficialità. E poi, dopo qualche giorno – o settimana – di nuovo fuori, alla vita di prima.
L’ospedale era semplicemente una macchia scura che si posava di tanto in tanto sulla mia vita, e che io cancellavo ogni volta, il prima e il più accuratamente possibile, dai miei pensieri.
Ma poi in ospedale c’è stata la mamma. Solo alla fine, per un pietoso atto del destino, dopo mesi di agonia trascorsa a casa.
Al pronto soccorso, fra i lamenti degli altri, e il dolore di altri parenti, dietro due tendine verdi che ci isolavano da altre tragedie, abbiamo perso la mamma. In un modo che non avrei creduto, se non ci fossero state altre persone, insieme a me, a testimoniare che era successo davvero.
I suoi battiti erano diminuiti via via, insieme al respiro e la pressione. Li vedevamo calare, sul monitor, e ogni secondo ci separava da lei, mentre lei era ancora lì con noi. Con me, suo fratello, mio marito, mio cugino.
Mio padre e mio fratello invece non arrivavano, e io le ho chiesto di aspettare ancora un po’, di non andarsene ancora.
“È in coma, non la può sentire,” ha detto l’infermiere, mentre con gli occhi continuava a seguire lo schermo. Finché i tracciati sono scesi, si sono appiattiti del tutto.
“Mi dispiace…” ha detto l’infermiere, e si apprestava a spegnere le macchine.
In quel momento ho sentito i passi nel corridoio, mi sono affacciata e ho visto mio fratello e mio padre avanzare, con tutta la velocità che un novantunenne riesce a mettere nelle proprie gambe.
“Mamma, sono qui, ti prego, aspettali…” ho mormorato di nuovo al viso fisso di mia mamma. “Mamma, ancora un poco…”
E le linee si sono mosse, sul monitor. Un piccolo battito, un piccolo respiro, un accenno di pressione nelle vene.
Il tempo, per mio padre, di entrare, capire la situazione e riversarsi su di lei, chiamando il suo nome. Per l’infermiere, di sgranare gli occhi. Per me, di scambiare uno sguardo con mio fratello, e di stringere la mano di mio marito.
E poi le linee, lentamente, sono tornate giù. Sempre più giù, fino ad appiattirsi del tutto.
Mia mamma se n’è andata davvero.
Questi momenti hanno continuato a lungo a circolarmi dentro, nel fluido che trasporta i pensieri; in ogni parte del corpo e della mente, irrorando ogni sensazione.
Li avevo ancora vividi, in me, quando papà è finito anche lui all’ospedale, inaspettatamente. Con addosso l’abito sportivo della passeggiatina quotidiana, e il portafogli lasciato sulla scrivania. Gli oggetti ancora nella posizione in cui li aveva decisi quel pomeriggio; il giaccone appeso all’appendiabiti e le chiavi accanto al portafogli, sulla scrivania. E in ospedale è arrivato così, con la cravatta appena un po’ allentata e un aspetto fuori luogo, di imprevisto davvero strano e brutto, che non c’entrava niente con la sua vita.
Faccia spaventata, il cuore che se ne va per una crisi respiratoria, oppure la crisi respiratoria che viene perché il cuore se ne va… chissà. Una, due, tre volte.
Sono iniziati i contatti con i medici: “Rallegratevi, ve lo rimandiamo a casa”, “Preparatevi: sta morendo”, “Attrezzate la casa, lo dimettiamo”, “Non fatevi illusioni, non ce la può fare”.
Meglio, in fin di vita, ripresa straordinaria! Fisico finito… Alla sua età non ci stupivamo troppo dei crolli, mentre le riprese ci facevano gridare al miracolo.
Ci lasciava attoniti sopratutto la tenacia e la voglia di farcela in quel corpo magro, leggero, tutto nervi e impuntatura di vivere.
Lo hanno sostenuto, bucato, curato, privato, massaggiato. Gliene hanno fatte di tutte, lì dentro, a quel corpo, ma si vedeva che più che altro erano i nervi tesi che ce la volevano fare, che gridavano al soccorso, e che ci facevano massacrare di fatica, a me e mio fratello, per stare dietro a tutte le mille necessità, richieste e rimbrotti che nostro padre riusciva a comunicarci dietro la maschera d’ossigeno.
Aveva necessità ogni trenta secondi, e si disperava di ogni assenza, anche se necessaria. Come fanno alcuni malati, che trasformano chi sta loro intorno in un essere onnipotente, al quale affidare la propria esistenza momento per momento. E la cui distrazione porta alla perdita.
Nei rari momenti in cui riposava mi rifugiavo nella stanza destinata ai visitatori, incorniciandomi nella finestra che dava sulla valle. Dal quarto piano di quella piccola piana subito fuori Firenze, si vedevano colline dolci, e vecchi cascinali che erano diventati abitazioni curate e armoniose. Una strada scorreva davanti all’ospedale, una sola. Troppo piccola per il traffico, brulicava di auto e mezzi di soccorso fin dall’alba. Fino a notte inoltrata.
Intorno a me, le luci che si accendevano e si spengevano nelle corsie, i pasti, i giri di visita. I degenti che venivano e andavano; le ambulanze che ne portavano sempre di nuovi. Non c’era una pausa, non c’era un respiro. Là fuori niente si fermava e niente era in salvo. Tutto si muoveva, si scontrava, cadeva, si ammalava, squarciava, spappolava. E veniva lì, a farsi rimettere a posto. Lì, dove giravano stampelle, sedie a rotelle, deambulatori, bastoni. Li vedevi passare, con le persone aggrappate sopra, dentro i soliti pigiami orrendi. Che magari a casa non erano così tristi, ma lì venivano ciancicati da giornate intere di letto, e poi riflettevano quelle luci azzurrine, e odoravano di medicine…
Il primo giorno, gli infermieri avevano fatto finta di non vederci, mentre mio fratello e io sgattaiolavamo in corsia dopo l’orario di chiusura. E il secondo ci avevano portato una poltroncina dove passare le notti, e ci avevano spiegato come dare da mangiare a nostro padre la pappetta, che era l’unica cosa che potevamo dargli, senza pietà, anche se ci chiedeva l’acqua. L’acqua che lui respirava, invece di inghiottire, e che gli rantolava in gola insieme ai catarri. “Meglio di no, papà,” e lui sbatteva la mano sul mio braccio. Se avesse avuto ancora la forza di un tempo mi avrebbe fatto male. Ma non solo non aveva forza, non aveva nemmeno voglia: “Scusa,” diceva con le labbra, e chiudeva gli occhi. Non voleva farmi male, voleva solo inveire contro il mondo cane che gli stava facendo questo. Dopo avergli portato via, dietro due tendine verdi, l’amore di una vita.
Non si poteva lasciare solo un uomo che aveva avuto qualcuno accanto per settantadue anni. Lo capivano anche i medici più ostili. Lo capivano e ci assecondavano. Hanno detto varie volte: “Sta morendo,” e altrettante volte: “Lo rimandiamo a casa”; per due settimane hanno cambiato terapie e visioni della situazione, hanno ruotato i nostri sentimenti dentro turbini di notizie contrastanti, ma non hanno mai provato a farcelo lasciare solo.
Io e mio fratello avevamo suddiviso la giornata in fatiche di otto ore ciascuna. Potevamo iniziare in qualsiasi momento del giorno, e capitare in qualsiasi fase dell’ospedale. Vedevamo le luci accendersi nelle case sulle colline, e i lampioni lungo lo stradone, i fari delle auto che rincasavano o venivano a trovare i malati. E i flussi dei parenti, i regali, i giornali e il cibo da casa.
Facevamo amicizia con gente che usciva, amicizia con gente che cambiava reparto. Con una madre che è stata seduta una settimana su una sedia, senza mai muoversi, accanto al figlio che forse non ce la faceva. Che forse ce l’ha fatta, perché l’hanno messo in un reparto meno grave. Siamo andati a trovarli, qualche volta. Abbiamo sperato che finisse tutto bene.
“Riuscite a reggere?” ci chiedevano i parenti e gli amici. Noi ci stringevamo nelle spalle e ci chinavamo su nostro padre che tossiva via catarri che lo soffocavano da profondità che facevano rumori cavernosi, e sembrava non finissero mai. Andava aiutato, messo in posizione, ripulito, rassicurato. Come potevamo non reggere?
Secondo genitore in poco tempo. Tanta sofferenza, di nuovo, dopo che ci era passata mia madre. Ci era sembrato di aver pareggiato i conti con la dose di male in serbo a ciascuno. Aveva sofferto lei, e noi con lei, una volta sola: così tanto e per tutti. Ma le illusioni prendono forme stupide, e questa era una di quelle. Non si garantisce il bene con il male, non si pareggiano i conti con niente.
Lo sentivo chiaramente adesso che tutti i giorni dovevo recarmi nel luogo in cui mai avrei voluto tornare. Tutti i giorni fra le luci, gli oggetti e gli odori che più avrei voluto allontanare da me. Le ore che passavo a casa a riposare non servivano, perché anche quando non li avevo davanti, quegli oggetti, luci e odori mi gonfiavano i sentimenti, li liquefacevano in qualcosa di indistinto che mi seguiva ovunque.
E la stanchezza è aumentata, insieme a questa disperazione liquida che si infilava dappertutto. È cresciuta fino a ricoprire ogni cosa. Diventando un mare su cui la mia coscienza galleggiava, trascinata dagli eventi, e poi si inebetiva, e diventava quasi leggera.
Fino a una mattina.
Uno dei miei turni che iniziavano prima dell’alba e che mi vedevano arrivare a testa bassa, stringendomi il freddo fuori dai vestiti, con le solite tre borse a tracolla e il caldo del corpo che sgusciava fuori dalla bocca, in fumo.
C’erano già delle ambulanze parcheggiate davanti all’entrata del pronto soccorso, c’erano già degli infermieri che fumavano una sigaretta davanti all’entrata principale. C’era un parente che sedeva su una panchina, fuori, senza sentire il freddo, e un malato insonne che girovagava, dentro, in fondo a un corridoio, nella luce bianca.
Mi sono soffermata, rallentando il passo nel parcheggio. Per la prima volta, ho apprezzato di essermi trascinata fuori dal sonno, e poi nell’auto gelida, fino a quell’entrata. Di aver lasciato la casa vuota di mio padre, e i suoi oggetti inerti, per portarmi lì dove lui lottava, con le sue poche forze. Lui e tutte le centinaia di pazienti che stavano accanto, nei piani sopra, in quelli sotto, nelle ambulanze in arrivo, nelle auto che sarebbero ripartite da lì a poco verso casa. Lui e i medici che valutavano, gli infermieri che assistevano, i parenti che sostenevano.
Un calore strano si è riversato su queste immagini, informe come la luce del mattino. Un calore che emergeva da loro e al tempo stesso li ricopriva. Tutti gli oggetti, le persone, il verde intorno. Sopra e dentro di loro, nello stesso momento, stava questo calore di vita, pienezza, bellezza.
Tutto era ricco di noi, di esistenze, di sofferenze, di conquiste. Di morte, in alcune stanze che si aprivano accanto all’entrata principale. Stanze un po’ in disparte da cui uscivano persone con le facce contratte, e la vita già indirizzata verso il tentativo di venirne fuori.
C’era così tanto, lì dentro, e non era per niente un vuoto di non-tempo, di non-spazio, di non-vita. Era il posto più pieno che avessi mai visto.
Fra i corridoi con le prime ronde mattutine, ancora a luci smorzate. E il silenzio faticoso di chi cerca di riposare in mezzo alle condizioni estreme. I bip delle macchine, gli squilli dei campanelli che richiedono attenzione. E l’infermiera senza sonno che si sposta, entra in una camerata buia, si avvicina a un letto: “Questa cosa la diciamo domattina al dottore, non ti preoccupare, manca poco”.
Il dottore, che sarebbe arrivato dopo poco, avrebbe incontrato uno che lo aspettava dalla notte. Il dottore con in mano le cartelle dove stava il destino di quella vita.
Sono arrivata a dare il cambio a mio fratello, che non ne poteva più di stare lì dentro a porgere l’orecchio alle richieste di papà. “Sono arrivata poco prima del cuscino?” ho scherzato con lui. Ci dicevamo spesso che se uno di noi non fosse arrivato in tempo per il cambio, avrebbe trovato l’altro che stava togliendo di mezzo papà e le sue incazzature mute, pigiandogli un cuscino sulla faccia.
Mio fratello ha annuito più convinto del solito: “Ci siamo andati vicino…”. Eppure ha lanciato un ultimo sguardo a papà che finalmente dormiva, prima di uscire; gli ha mormorato: “A dopo,” sfiorandogli un piede.
Avrei voluto abbracciarlo con la voce, e trasmettergli con le immagini viste nel parcheggio quel calore che veniva da loro, e che tornava su di loro. Avrei voluto portarlo dentro la mia visione, in qualche modo, ed attraversare insieme quel momento di dolore, fino a sentirne la bellezza.
Ma lui non dormiva da troppo tempo. Voleva mangiare, riposare e dimenticare l’ospedale per qualche ora, solo questo. Così non gli ho detto niente e l’ho guardato andare via. Il calore è rimasto intrappolato nella voce non espressa, e nel mio corpo che si sedeva, osservava papà dormire, lisciava la sua coperta.

 Persa - Francesca Andreini
Persa - Francesca Andreini Brevi dal Nord - Gianfranco Mammi
Brevi dal Nord - Gianfranco Mammi La prima volta che sono stata a una estate sale - Francesca Andreini
La prima volta che sono stata a una estate sale - Francesca Andreini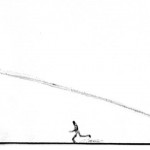 All’avventura, lontano dalla tristezza - Gustavo Paradiso
All’avventura, lontano dalla tristezza - Gustavo Paradiso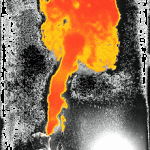 Gino/ 21
Gino/ 21 La prima volta che ho partecipato a una graduation
La prima volta che ho partecipato a una graduation Cronache americane/ 4
Cronache americane/ 4 Cronache americane /2 – I
Cronache americane /2 – I





















