
Un giorno, un ragazzo di poco più di vent’anni si addormentò nello scompartimento di un treno diretto verso Venezia.
Quando riprese conoscenza, il cielo era cangiato, e nella campagna volgeva la sera: la luce elettrica che usciva dai vagoni vinceva ormai quella morente del cielo. Il ragazzo guardava l’orizzonte, sola linea immobile nel flusso sempre più nero e incomprensibile del paesaggio.
“Potresti essere dovunque, sia perché è quasi notte ma anche perché non sai quanto hai dormito” disse una voce alle sue spalle. Il ragazzo aveva da poco perduto, e raccapricciantemente, il padre. Non si voltò. «Raccapricciantemente», aveva sul serio scritto così un giornalista in vena di fesserie, ma la parola era rimasta chissà come in testa al ragazzo come uno stridore di violino, a volte l’unica parola che riusciva ad articolare nel rimbambimento del lutto.
Era come se il treno stesse correndo verso la notte, e dalla campagna e dall’orizzonte ormai scomparsi salivano ventate di falene a morire contro l’invito della luce del treno, per l’insetto chissà, un bruco di luce pronto a spezzarsi in un dio farfalla che incenerirebbe col sudiciume nero e grigio delle sue ali i campi di qua e di là dalla rotaia.
Raccapricciantemente.
“Sono in fregola, come si dice: cercano la femmina, e muoiono così, cercando un’amata che non hanno nemmeno mai visto. S-ciàk, spiaccicati contro una luce che passa in mezzo alla notte. La luna è diventata scema, pensano magari, e poi… s-ciàk. Come se io e lei per fare un esempio io e lei e non so qui sembra mezzo vuoto ma facciamo io e lei e tutti gli altri passeggeri di punto in bianco ci mettessimo a correre col cazzo duro in mezzo ai prati perché ci è venuta quella cosa lì e poi tutto di colpo fosse come se la luna o quello che è cominciasse a rimbalzare di qua e di là come un canguro e il tempo di capire tra cazzo e tutto cosa sta capitando che… Mi segue? S-ciàk.”
All’ultimo s-ciàk l’estraneo batté le mani vicinissimo all’orecchio del giovane, come uno schiocco di frusta austriaca con tanto di scampanio di mucche in fuga.
Ma quando Miloš si voltò, l’architetto era dall’altro lato dello scompartimento, le labbra quasi pietrificate nel trisma di un sorriso ciarlatano, da manichino di caucciù.

Miloš aprì gli occhi. Il treno andava ancora. La passeggera di fronte a lui aveva i piedi immersi in una ciotola azzurra piena d’acqua e fiori. I piedi magri e bruni quasi sparivano contro il fondo scuro della ciotola, che all’esterno era dipinta di azzurro. Una bambina si nascondeva dietro il giallo e l’arancione della veste della donna. Il profumo e il calore della mamma le oscuravano gli occhi; da dentro il ventre di seta guardava Miloš col distacco di una statuina neolitica. Il treno prese una curva e il sole serpendo per il finestrino si rifranse nel prisma liquido della bacinella, vomitando la propria rete di luce attraverso lo scompartimento. La bambina distolse gli occhi da Miloš.
Al posto delle solite vedute di Jakarta, sopra i sedili erano stati attaccati dei disegni eseguiti dalle vittime del videogioco NITA™. I disegni apparivano come incisioni di neon contro un fondo di pietra levigata, ed erano stati ottenuti ricostruendo e talvolta sovrapponendo alcune sequenze di fosfeni delle vittime, attraverso un’avanzata tecnica di ricostruzione neurologica dell’immagine la cui tecnologia, bofonchiava chi ne aveva ancora voglia, era stata sviluppata dal gruppo di bioprogrammatori a capo di NITA™ stesso. I disegni erano accompagnati da cartoncini incorniciati che ne descrivevano stralunatamente il contenuto. I testi erano a propria volta trascrizioni, fedeli fino al refuso (si trattava dopotutto di prove per un processo ancora in corso), scelte dalla montagna di foglietti, quaderni, diari, pezzi di stoffa, segni sui muri, sulle panchine, sui banchi di legno, su qualunque supporto su cui fosse possibile scrivere: le vittime di NITA™ vi si precipitavano come falene contro una candela, per descrivere quel che i loro “occhi” (le discussioni riguardo quel che effettivamente “vedessero” le vittime di NITA™ fervevano ancora, tra orrore e orgasmo) “rivedevano”, così dicevano quasi tutte le vittime, per distinguere il loro “vedere” dal comune vedere. I testi dei cartoncini erano di solito stati scritti da persone diverse da quelle che avevano fatto il disegno corrispondente, circostanza che era legata al quadro sintomatologico che aveva dato il via alle prime indagini e infine al processo. Le Ferrovie di Waltzwaltz, reduci dagli attentati perpetrati dai treni parassiti “FIAT”, nel proporre all’attenzione dei viaggiatori quei lacerti di prove processuali a favore delle vittime di NITA™, avevano ritenuto di esprimere solidarietà verso quelli che consideravano compagni per così dire di sventura (sempre che possano mai essere compagni una persona e un organo statale, sempre che le loro sventure possano mai compararsi o perlomeno porsi su uno stesso sventurato continuum) «nell’aggravarsi», così la nota delle FW, «di quello che ormai è da considerare un vero e proprio assedio alla qualità della vita psichica»; né erano poi tanto campate per aria e forse tutto sommato potevano addirittura considerarsi sincere le richieste delle FW agli organi competenti del Regno per un’esplorazione ormai sempre più urgente delle nuove pieghe legali (ovvero: occasioni criminali) corrugatesi sulla levigatezza del Codice all’apparire di piattaforme biotecnologiche quali appunto quella utilizzata da NITA™ o quella imbastita dai treni “FIAT”.
Il pensiero di chiudere gli occhi e di essere assalito dai contorni insulsi di quegli scarabocchi (con una formula che era rapidamente entrata in proverbio, un avvocato dell’accusa aveva parlato di «violazione del diritto alla tenebra» per le vittime che a loro dire – e confortate dall’oggettività dei subbofonchiati biosoftware per il restauro dell’immagine fosfenica, biosoftware il cui valore legale tuttavia non era ancora stato normato, donde le istanze delle FW per un aggiornamento del Codice – non era lontano, ribofonchiavano gli aventi diritto, il momento in cui alla legge sarebbero stati imposti aggiornamenti della stessa natura di quelli richiesti dalla più raffazzonata e impiastra delle chiamiamole così intelligenze artificiali; non era lontano il momento in cui la legge, come acqua eraclitea, sarebbe stata sì uguale per tutti, ma mai uguale a se stessa ––– non potevano più, le vittime, nemmeno sbattere le palpebre senza essere assalite da uno sciame di linee luminose che imperiosamente comandavano di essere quanto prima esauriente- né importava quanto strampalata- mente per iscritto descritte), per non parlare del chiamiamolo perché così in effetti si erano ridotti a chiamarlo fior di titolatissimi esperti durante il processo fosfene linguistico delle loro descrizioni, tutto ciò, con tutto il suo ingarbugliato corredo di parentesi e controparentesi, terrorizzava Miloš ––– tanto per dire, il pupazzo di gomma notturno che lo aveva “svegliato” con la storia della falene in fregola non sarebbe stato forse un segnale che l’infezione di NITA™ si stava diffondendo anche al di là del contorno apparentemente rigido del videogioco?
D’ora in poi, ogni volta che avesse chiuso gli occhi le falene si sarebbero anticostituzionalmente ridisegnate sopra la sua sacrosanta tenebra?
La donna e la bambina giochettavano con i piedi nella ciotola, sciabordando ondine su cui i fiori aggrovigliavano un girotondo browniano di costellazioni. Parlavano la loro lingua, che Miloš non capiva e che si mescolava nel nonsenso dello sciabordio.

“Hai veduto l’infamia?”
“Cos’è l’infamia?”
“Stavo parlando a papà”
“Sì ma cos’è l’infamia”
“È una cosa brutta. Hai veduto?”
L’uomo fece un cenno chiudendo solenne e sereno gli occhi, come un martire minore pronto sì a buttarsi nelle fiamme ma senza la cagnara dei santi da pala d’altare, che tanto si va tutti comunque in Paradiso, mica a spalar merda nel giardino dell’Avversario.
Miloš aprì gli occhi e guardò.
I “Colibrì”, come li chiamavano ormai quasi tutti, avevano installato una nuova città nel vecchio quartiere olimpionico. Dallo stelo di metallo alieno, impossibilmente alto e sottile, il grande faro centrale pendeva sull’orizzonte come un gigantesco soffione, un astro composto di un pulviscolo di piccole luci attorno al quale fremeva un viavai tutt’ora incomprensibile, persino agli scienziati che fin dal momento del (tale lo si credeva unanimemente allora) primo atterraggio alieno si erano dedicati alla “comprensione del fenomeno” che ben presto era rinsecchita in “monitoraggio” e “raccolta dati”. Fissando abbastanza a lungo lo spazio di cielo tra il faro e il rettangolo di luci sul terreno era possibile, anche dal treno in corsa, anche nella nebbia mattutina, intravedere un fremere grigio e sottile, un viavai continuo e vertiginosamente rapido di esseri alieni, i “Colibrì”, i cui scopi restavano ancora del tutto imperscrutabili. La tanto paventata invasione deludeva le aspettative. Contro il cielo sempre più violaceo della sera, c’era ad esempio tra i viaggiatori chi vi riconosceva un nidificarsi come di ragno, chi una tessitura comunicativa, chi un mero, quanto indefinito (ovvero, variamente definito) campo energetico, chi una contaminazione del terreno e dell’atmosfera, o in ogni caso un’operazione indubbiamente aggressiva per l’intero pianeta. Né l’esercito né la popolazione, del resto, avevano fatto troppi tentativi per comunicare con gli esseri. Dopo un primo momento di frenesia e entusiasmo, restando la situazione inerte, tutti avevano finito per disinteressarsi. La notte, se c’era abbastanza silenzio, c’era chi distingueva il ronzio della città aliena, come un lieve sciamare che presto però veniva inghiottito dal canto notturno degli uccelli.
“Dov’è la cosa brutta?”
“È lì”
“Dove? Dov’è l’infamia? Fammela vedere, non la vedo”
“È quella, ci stiamo passando adesso”
“Quale? Quale?”

La Terra, e con lei ogni corpo celeste, è in perenne moto: non parliamo della rotazione o dell’orbita, ma del suo muoversi in sé dentro sé, del bruciore e bruciazione di continenti nella lava in fondo agli oceani, del corrugarsi e sbriciolarsi di montagne come le lentissime fiamme di un sole gelido. Ma forse è solo una questione di ritmo: per un essere il cui battito cardiaco fosse sufficientemente rallentato, la terra apparirebbe forse come un sole furente, e il sole svanirebbe in una tenebra assetata; e viceversa se solo riuscissimo a ravvicinare i battiti del nostro cuore fino a renderli indistinguibili l’uno dall’altro, potremmo camminare sulle fiamme del Sole. E così la frenesia degli alieni, se poi alieni erano, oltre ad aver loro guadagnato il soprannome di “Colibrì”poteva significare che per loro la ricerca di una comunicazione con noi potesse avere lo stesso significato che per noi comunicare con una catena montuosa. Nulla escludeva che un nostro battito di ciglia coincidesse per loro con l’estinguersi e il risorgere di intere sciamanti generazioni. Riuscivano, questo il punto, a camminare sui raggi del sole?
Né, in fondo in fondo, viaggiando su un fantascienticamente umile treno delle FW le cose andavano diversamente: bastava chiudere gli occhi abbastanza a lungo, e quando si fossero riaperti si avrebbe avuto davanti un nuovo scompartimento, che nell’economia della vita di un singolo viaggiatore non è poi granché diverso dal dire un nuovo mondo.
(E anzi: ma perché poi mettersi in viaggio. Fate così: Leggete fino a che attraverso le scure sabbie mobili delle pagine sembrino emergere come fosfeni le squame e gli artigli di storie e personaggi che non fanno parte del libro. Ogni lettore purosangue sa di cosa stiamo parlando. Ma se quegli artigli e quelle squame non fanno parte del libro, allora di cosa fanno parte? Calma. Andiamo con calma. Isolate e archiviate costantemente quel che vedete nel dormiveglia, e in questo siate diligenti e grigi come funzionari di un impero galattico; solo così vivrete nel presente smantellato del dormiveglia, e vivrete come in un eterno bagnasciuga, né sulla terra né nel mare, eccomi lì anch’io, lo vedete? Mi vedete? Marmocchio! Resto immobile sul bagnasciuga, pensando che mi assorbirà completamente come una medusa. Una coppia di turisti è scomparsa sul bagnasciuga, avevamo letto sul giornale, e mio padre aveva detto A volte succede, resti in piedi sul bagnasciuga per troppo tempo e sprofondi nella sabbia e nessuno ti trova più perché il bagnasciuga non lascia segni. Perfetto, risucchiato nella sabbia e nessuno mi troverà, mi spunteranno squame blu come se fossi un libro purosangue e imparerò a respirare la sabbia intrisa di mare. O magari erano stati gli alieni, aveva detto mia madre, e mi sa che è lì che gli alieni hanno iniziato a terrorizzare mio fratello. Dormiva con torce e coltelli militari sotto il letto. Ricordarsi sempre di chiudere gli occhi. Vale anche per voi. Soprattutto per voi.)
“Siedi qui amore. Qui. No. No. Ferma con le gambine. Ferma. Hai la gonna. Se vuoi fare la signorina che porta la gonna devi stare ferma con le gambine. No. Vieni. Amore vieni qui dalla mamma. Ti devo spiegare una cosa. Non sei mai salita su un treno. Quando ci si siede sul treno bisogna stare fermi e composti e occupare solo i propri sedili, non si può stare stravaccati dove si vuole perché devono sedersi anche gli altri. Se uno ha delle borse come questo signore o come noi o il monopattino come noi lo può mettere lì sopra, vedi dove ho messo io il monopattino? Così come l’ho messo dovrebbe stare fermo. Vedi lui per esempio? Vedi che ha messo il suo zaino nel sedile davanti a lui? Stai un po’ ferma amore. Vedi? Lui poteva benissimo mettere lo zaino lì sopra, invece l’ha messo sul sedile, lì potrebbero sedersi altre tre persone, invece non si siede nessuno. Quando si va su questi mezzi bisogna essere educati e avere rispetto degli altri perché sono mezzi pub-bli-ci. Stai un po’ ferma con quelle gambe.”
“Leggiamo il libro della principessa?”
“Certamente, amore. Amore però se ti siedi così addosso a mamma poi io ti scaldo.”
Per tutta l’infanzia il fratello di Miloš era stato terrorizzato all’idea di dover dormire: niente gli sembrava più semplice e atroce che morire nel sonno e da lì essere direttamente mandato sottoterra senza accorgersi di niente, e perciò niente era più terribile che essere obbligati a dormire. Poi, e poi voi-là: torce: e pugnali. Dormiva con dei coltelli sotto il letto, nel comodino, forse persino sotto il cuscino. Teneva pronte delle torce per poter vedere al buio l’intruso e pugnalarlo. Una delle torce aveva la forma di uno snodo a 90° di un tubo idraulico, e aveva dei filtri colorati da interporre alla luce. In qualche modo ricordava un corto periscopio. Miloš e suo fratello mettevano tutte le lenti sopra la lampadina, spegnevano la luce e accendevano la pila, e lo strato di colori era così spesso che la luce ormai quasi non si vedeva, lontana e fioca come lo stridio di una farfalla pavone a chilometri di distanza nella giungla austroamazzonica… Miloš si nascondeva dietro quella pallida luce che spalancava nella stanza spazi siderali, e suo fratello piangeva.
“Vuoi che mi sposto?”
“No amore, a me fa moltissimo piacere quando mi stai vicina smetti di grattarti. No, è solo che non vorrei che sudassi, va benissimo se ti siedi in braccio”
“Leggi?”
I coltelli erano per fermare le presenze più grossolane: ladri, assassini, i drogati, diavoli fuggiti da o portatori di imprecisi inferni, e appunto alieni: scesi da astronavi provenienti da nessun pianeta, alieni in viaggio da talmente tanto tempo da aver confuso la propria astronave con il proprio pianeta, e chissà che non sia così anche per noi, che la Terra non sia che l’ultima di una serie di caravelle fantasma dirette chissà dove…
Quando vennero scoperti i primi “nidi” di “Colibrì”, il fratello di Miloš tirò fuori da sotto il letto il coltello che per una qualche ragione fin da bambino lo aveva aiutato a prendere il paventato sonno, e con quel coltello si era tolto gli occhi, poi era andato alla finestra e aveva preso un volo di dodici piani.
S-ciàk.
“La principessa vive in un bellissimo castello. Mangia con la bocca chiusa non va bene fare tutto quel rumore quando si mangia. La principessa quando è a tavola mangia almeno un boccone di tutto quello che gli viene portato. Di quello che non le piace ne prende pochissimo, ma comunque ne mangia un pochino anche di quello. Amore se ti metti così ti si vedono le mutandine e non va bene, devi stare seduta bene. La principessa quando va a passeggio viene accompagnata dalle damigelle, dai paggi e dalle guardie che controllano ogni angolo per la sua sicurezza”
“Perché quello lì gli mangia il vestito?”
“Le mangia, semmai, ma non lo sta mangiando, lo tiene sollevato così non si sporca”
“E quella lì chi è, un’altra principessa?”
“No è una cameriera, vedi che le tiene il bouquet? Se mangi con la bocca aperta riempi mamma di briciole vedi? Bisogna mangiare con la bocca chiusa amore”
“Leggi?”

“Il pomeriggio la principessa, insieme alla regina e al re, assiste alle esecuzioni in piazza. Oggi verranno impiccati due assassini, un bandito e un falsario, e quattro streghe e quattro eretici saranno bruciati vivi. La principessa ha portato dei sali profumati da tenere sotto il naso per non sentire il puzzo della carne bruciata.”
“Questo fa le linguacce. È un’infamia?”
“No, è perché sta morendo”
“Perché non è un’infamia?”
“Per la notte la principessa può scegliere tra più di cento pigiami”
“Perché non leggi più?”
“Se ti giri dall’altra e non ascolti mamma non legge”
“Dove sono tutti gli uomini?”
“Saranno a caccia, o a fare un torneo, o alla guerra, oppure sono andati a fumarsi un sigaro e bere un bicchiere di brandy”
“Perché non stanno con le donne?”
“Quella è la stanza delle donne, si vedranno domani”
“Leggi la fiaba”
“L’abbiamo già letta, e poi è lunghissima, il treno sta arrivando”
“Guarda, qui è già finita”
“Hai ragione. C’erano una volta un re e una regina che si amavano teneramente. Non gli mancava nulla per essere felici, il loro regno era grande e prospero, e i loro sudditi erano felici; ma c’era una cosa che turbava la pace dei sovrani: nonostante si amassero molto non riuscivano ad avere un figlio maschio che potesse ereditare il regno. Avevano avuto ben dieci bambine ma non sapevano che farsene, e per questo la regina era molto malinconica. Avevano persino provato a prendere pozioni e unguenti, che però avevano avvelenato un occhio della regina e fatto venire un tumore alla prostata del re, cui ormai non restavano che due o al massimo tre anni di vita.”
“Prendiamo una pozione anche noi?”

Quando Miloš riaprì gli occhi, l’architetto era ancora lì. Fuori era notte, uno smog bluastro attraversato dalle strisce luminose di lampioni o di finestre oltrepassate dal treno.
Non era suo padre, era suo fratello ad essere morto raccapricciantemente. Nel sogno aveva fatto una sostituzione. Miloš non era stato troppo sorpreso di scoprire che suo fratello aveva fatto una specie di testamento prima di uccidersi. Miloš odiava suo fratello, e il suicidio e ancora di più quel testamento non avevano fatto che renderglielo ancora più odioso.
“Sono molto interessanti questi libri che ho qui con me”
Quanto mancava per arrivare a Venezia? Anche se il mostro di caucciù gli aveva parlato di nuovo, Miloš continuò a guardare dal finestrino, istoriando ghirigori con l’unghia sul vetro impolverato.
“Sono vecchi libri di geografia. Ma sono così vecchi che ormai sono libri di storia.”
Nel riflesso parziale del finestrino, la notte e la campagna che scorrevano implacabili, Miloš osservava lo sconosciuto, ignaro ancora dell’orrore che avrebbero portato l’uno nella vita dell’altro. Gli occhi del manichino vivente traballavano come fossero stati sistemati in un cranio troppo grande per loro.
“Lo sapeva che il primo rione di Schwarzschwarz è stato costruito (diciamo meglio: tirato in piedi, anzi: piedacci, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!) applicando all’urbanistica la politestualità dei mottetti medievali? Come nelle voci di un mottetto che dicono cose diverse una sopra l’altra, le voci non si parlano e chi ci capisce qualcosa è bravo, anche nei rioni di Schwarzschwarz le strade stanno tutte insieme ma non si incrociano mai, e quindi è come se ogni rione fosse una stratificazione perduta di città mutilate, del resto dagli zingari non si possono certo pretendere metropoli coerenti–– Non disturbo vero? Il treno è mezzo vuoto, posso anche–– no ma senza complimenti, io non ne faccio, dico ecco, un esempio, uno soltanto, se lei con me sovrappone questa mappa al manoscritto originale del primo tema musicale nel Jeu de Robin et Marion… Non le piace la musica? Ha una faccia da cantante lirico lei, lo sa? Fiiiiigaro Figaro Figaro Figarofigarofigaro la la la la la la la la laaaaaaaaaaa… Non mi dica che non le piace nemmeno Robin Hood! Anche se quasi di certo non è lui quello del rione cioè del tema del Jeu…”
Nel testamento suo fratello gli lasciava una busta e un quadernetto da disegno. La busta si trovava a Venezia e secondo il testamento di suo fratello avrebbe dovuto contenere le password per una serie di siti che Miloš non aveva mai sentito nominare, e che il fratello gli ordinava di chiudere senza lasciare tracce, di farli risucchiare in un bagnasciuga di ciarpame multimediale. Entrare e cancellare ogni cosa. Da bambino Miloš sognava spesso di uccidere suo fratello strangolandolo. Gli prendeva il collo tra le mani stritolandolo, sempre con facilità. Il collo si schiacciava e allungava come un vecchio calzino, e la testa di suo fratello si gonfiava fino a diventare un pallone, poi suo fratello cominciava a piangere e lacrimare da tutta la superficie della testa, grosse lacrime scorrevano compatte, simili a bulbi elettrici, la faccia di suo fratello congestionata dal soffocamento.
Il quadernetto era stato utilizzato solo in piccola parte. Il fratello di Miloš ci aveva fatto degli scarabocchi accompagnati da delle specie di sgherle poesiole. Non si vedeva perché avrebbe dovuto darsi una particolare pena per far arrivare a Miloš quelle pagine.
Miloš chiuse gli occhi. Sto sognando tutto. Devo svegliarmi. È mio padre ad essere morto, non mio fratello.
Ma la bambola di caucciù messicano non smetteva di fissarlo con la sua geografia e i mottetti.
Ci sono due modi per divincolarsi da un sogno: svegliarsi o sognare tutto.
“Le piacciono le storie di pirati e principesse?”
Miloš riaprì gli occhi.

Miloš aprì gli occhi. Sarahs sedeva davanti a lui, nuda e a cavalcioni sulla panca di legno. La mano destra di Miloš era appoggiata con il palmo sul legno della panca, nello spazio libero tra le due gambe allargate di lei. Il dorso della mano di Miloš era leggermente più scuro della pelle di Sarahs. Era come vedere una A, le due diagonali le gambe di Sarahs, la stanghetta orizzontale la mano di Miloš. Lei gli sorrise, magra come una lucertola, quasi un ragazzino, quasi più alta di lui, bianchissima, i ricci scuri talmente lunghi che le coprivano la schiena allargandosi sulla panca. Restarono così, fermi, senza toccarsi, poi lui ritirò la mano e si alzò dalla panca. Delle voci di estranei si avvicinavano, lui non poteva stare nello spogliatoio. La pelle sottilissima di rettile neonato, le vene e le iridi di un azzurro siberiano. Alzandosi lei si coprì con le due mani sopra e sotto, come in un dipinto, poi ci fu uno scossone e Miloš aprì gli occhi.
Sarahs si allunga davanti a Miloš mezzo sdraiato sul vecchio divano di vimini, eclissando il televisore, la sua pelle quasi ramata, selgiuchide, spessa e calda (Miloš ne sente il tepore subtropicale sulla guancia quando Sarahs avvicina le gambe al volto di lui ma senza mai toccarlo, uno spettro di libeccio, quasi un alito; Miloš apre un po’ la bocca e il calore gli scivola sulla lingua lasciando il profumo di lei nella sua gola e infine un bruciore che costringe Miloš ad aprire gli occhi).
Sarahs apre la bocca davanti allo schermo acceso, la lingua sul limitare del labbro inferiore quasi si preparasse ad assaporare la luce o l’elettrostatica dello schermo. Miloš non sa di lei nulla se non quello che ne ha letto sul testamento di suo fratello, morto suicida tre giorni fa. O si tratta di suo padre. Una testa di caucciù rimbalza e rimbalza contro il vetro di una finestra, e Miloš apre gli occhi.
Sarahs seduta al tavolo azzurrino della cucina gli sta parlando della conformazione anormale, con ogni probabilità mutante, dei suoi seni. Sfiora col dorso delle dita l’arco esterno della mammella destra, poi si sbottona lentissima e inesorabile i primi quattro bottoni della camicetta e libera dal drappeggio il seno destro, premendone il peso tra le dita come una Madonna che si prepara per la lactatio. Tra indice e medio sporge tiepido l’astro siamese di un doppio capezzolo. Alla finestra, il paesaggio sfreccia talmente veloce da sembrare un muro bianco che si sfa. Miloš apre gli occhi.
Sarahs è in piedi davanti a lui. Indossa una lunga gonna zingara scura e pesante. Miloš è seduto su una sedia di legno come per un interrogatorio della polizia segreta di Schwarzschwarz. È ancora fresco il caso del laboratorio dei Cheng, e ogni persona di origini cinesi come appunto è Miloš può essere senza tanti complimenti arrestata e interrogata, in qualsiasi momento della giornata. La luce della candela moltiplica all’infinito le sfumature della pelle di Sarahs quando quasi si spoglia del maglione sollevandolo fin sopra il collo. Immobile così, con il nero della gonna sotto e il nero del maglione sopra, il volto ancora nascosto dal maglione, il torso nudo e lievemente inarcato verso Miloš, fa pensare ad una scultura ancora in corso d’opera, o ad una danzatrice, e Miloš può quasi sentire posarsi sul volto la polvere di marmo da cui lo scalpello ha cominciato a liberarla, lasciandola poi così, il torso completo e il resto ancora informe e occulto. Una clessidra nera, pensa Miloš che non l’ha mai vista in faccia, lei nel frattempo sempre immobile, e la piccola fiamma mescolata col crescendo lentissimo e implacabile dell’aurora sembra volerla risucchiare nelle sfumature inumanamente rosa dell’abisso celeste, e in una incontrollabile metamorfosi daltonica le diecimila e diecimila tinte di rosa della sua pelle liberano di colpo, quasi con un morbido e dolcemente nauseante plop, un segreto e remotissimo strato di azzurro, come la vena profonda di un minerale, il divino azzurro ultramarino dell’alba ancora intrisa di tenebra. Il torso di Sarahs si distende su tutto l’arco del cielo inghiottendolo senza che nulla lo inghiotta, e da quel cielo ecco dipanarsi un pappagallo che dal meandro più lontano del fiume, inizialmente più minuscolo di un moscerino, arriva infine a trafiggere da dentro il cuore di Sarahs, divincolando le sue penne e il suo grido versicolore attraverso la cassa toracica, una clessidra nera i cui due vasi sono la gonna di sotto e il maglione dal collo in su, che Sarahs tiene ancora così, il volto ancora nascosto, pietrificata forse dall’alba imminente, le due braccia alzate sopra la testa come una danzatrice preistorica, il maglione che la nasconde dal collo fino alla punta delle dita, una clessidra nera tra i cui due vasi un pappagallo intrappolato nella sua cassa toracica si tende asimmetrico bilanciandosi su un artiglio di ossidiana… Sarahs inizia ad ondeggiare con una lentezza lunare, solo un corpo celeste può muoversi con quella lentezza senza insieme mai arrestarsi. Il torso di Sarahs con ondulazioni lunari imprime la propria lentissima torsione alle gambe e alle braccia nascoste dalla gonna zingara e dal maglione. Miloš si concentra sulle linee ortogonali della sedia di legno per non restare perduto nel movimento vasto e non percepibile del corpo di Sarahs. Si afferra al sedile per non perdersi nella clessidra nera e magari credendo di fluttuare scivolare giù dalla sedia come un imbecille, per l’imbarazzo degli altri passeggeri, sempre che ancora ve ne siano.

Miloš aprì gli occhi in uno scompartimento completo. Tutti parlavano con qualcun altro al telefono. Ogni cosa ovunque sfrecciava incomprensibile come in un mottetto geografico.
“…no, son troppo delicate, anche perché rischi di cambiare tutti i parametri –– rivetti no, perché non resistono bene ai carichi tanto quanto i bulloni, specialmente perché il bullone riesce a resistere bene ai carichi assiali, di taglio, e anche concentrici e decentrici –– i rivetti invece ––– per esempio qua un rivetto non lo potresti mettere perché si strapperebbe il metallo, perché essendo che resiste a taglio sulla piastra l’incidenza va a strapparsi quindi si staccherebbe tutto, quindi il bullone è l’unica alternativa. Ecco, io nel gruppo mi dovrei occupare di questa roba qua, perché di tre che siamo nessuno ha fatto parte media o di struttura che sarebbero tutti i giunti, quindi sa––– cioè… non… loro sono bravissimi a fare i metalli, così, però non sanno cos’è un bullone e la saldatura e io questo corso l’ho fatto quindi io dico quale bullone usare, io lì dimensionerei i bulloni perché ho fatto un corso solo su quello praticamente, bulloni, rivetti, saldature, quindi… torna utile. Ecco.”
“Per difendere il loro amico omicida incollano le loro scarpe davanti alle sedie nella sala d’attesa e restano lì per un’intera vita, immobili e sedati, per dimostrare di essere anche loro dei pazzi, una combriccola di pazzi”
“Le femmine sono più creative. Eh? Ah ah ah! No, no cretine, cre-a-ti-ve, no cretine. Mia figlia che me ne combina ogni giorno una. Ieri ha tagliato un maglione, lunedì non è andata a scuola. Ma tranquillamente, così, me l’ha detto all’una, Ah mamma, sai, oggi non sono andata a scuola. Un maglione nuovo, ma senza neanche chiedermelo, mi fa Ma mamma, come facevo a uscire senza niente da mettermi… sì poi quel fatto dei Cheng è successo a due isolati da dove… ma sì, ti rendi conto, e quella prende e mamma non ero a scuola ho i brividi al cervello a solo a pensare a quel–”
“L’ultimo quadrante di ALICE® lo progettiamo così, un po’… no, dove è preparata una festa in un cortile messicano e lei viene bendata e deve distruggere la bambola messicana piena di dolci appesa sopra la sua testa… sì… sì quello no sì quello è tutto fatto, un’improvvisa… delle difficoltà per il giocatore mentre Alice gioca la sua partita, la scacchiera da viaggio che è dentro come in una specie di valigia di tela di color militare ha cominciato a rovinarsi a furia di partite e così mentre lei gioca la partita una delle maniglie di tela della scacchiera da viaggio che è grande grosso modo come un tavolino ed è… e ha l’apparenza forse spugnosa ma poi di fatto è fatta di tela la scacchiera da viaggio si logora e si rompe”
“Quindi quando ci sarà da fare i bulloni ecco entro nel campo io. Sì. Ecco noi pensavamo, allora in teoria loro ci han detto di far solo la ruota intanto, però noi pensavamo intanto di cominciare con la ruota, e poi se avanzavamo tempo o comunque andava tutto bene, poi di pensare al braccio. Perché anche il braccio qua di sospensione è interessante. Molto semplicemente. Noi pensavamo di farla così, però è un casino per–– da produrre. La NASA ha testato una ruota che è una figata, che è a rete metallica che è una figata de–– è una fig–– è una figata però è un casino da costruire o meglio: devi prendere la maglia, è in alluminio, la devi riscaldare, secondo me devi prendere la maglia, è in alluminio, quindi la riscaldi, dentro però ha una forma in modo che quando poi la raffreddi in modo che tu quando la stacchi dalla forma abbia già preso la sua bella forma, quindi comunque non lo puoi fare all’università diciamo, no, devi farlo Là Fuori.”
“Lo dovresti sapere che per guadagnarmi da vivere realizzo bottiglie di vetro soffiato colorato: che c’è di strano se lo faccio la notte?”
“Questo no scusami ma questo che stai usando, puttanata dico, che termine sarebbe puttanata, nel contesto dico, mica per la p–– mica per la parola o parolaccia come la vogliamo chiamare il termine ecco in sé, ma ecco appunto oggigiorno e nel contesto che tu sai poi è un termine che mi riesce un po’, un po’ come dire, un po’ divisivo ecco, non ti pare? No, no, neanche cazzata, non––”
“Tutto bullonato ovviamente il bullone abbiam visto essere gli unici che… sì… eh vedremo, ci torneremo, sarebbe una figata questa, questa ovviamente è la maglia… la maglia, questa e l’altra in alluminio… questa qua… la NASA ha fatto i test, poi la differenza a costruirla sul suolo dell’università è un casino, perché non è tipo questa che è facile da costruire sul suolo dell’università, poi la NASA sono dei geni e fanno qualunque cosa, noi ci teniamo sui bulloni”
“…film horror dove si può vedere sangue che schizza da destra a sinistra, oppure gli horror che preferisco io, quelli con persone possedute o dove succedono cose inquietanti o anomale. Sì. Sì, anch’io. Questo genere lo preferisco perché si avvicinano alla realtà, capito? tanto che quando esci dal cinema sei più agitato no? Sei più sì ecco sei più all’erta del solito, brava, mi hai tolt–– Mah io credo sia molto più interessante vedere persone con la mente posseduta dove la notte si alzano e fissano i famigliari mentre dormono o sbattono la testa contro il muro. O come quella storia dei Cheng, hai sentito? In un condominio normalissimo, tipo…”
“…bulloni, quelli li so”

Quando Miloš aprì gli occhi, il presidente era già lì.
Nel riflesso apparente del finestrino, la notte e la campagna che sfrecciavano dietro i suoi occhi dondolanti, il presidente fece come il cenno di un inchino da seduto. Miloš annuì al riflesso, senza voltarsi.
“Dove è diretto?”
“Scendo a Venezia”
“Ah, dunque lei va fino in fondo, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!”
Dopodiché ecco qua. I tratti del volto collassarono all’interno del cranio strozzando in un gorgoglio la risata dell’architetto, risucchiati verso l’interno come se in un punto in fondo alla lingua si fosse innescato un buco nero. Il volto collassava come una cupola che crolla o un tendone di circo cui sia stato tolto il palo centrale. Per primo si ripiegò il naso, rivoltandosi all’interno del volto con una specie di grugnito che era in effetti il suono delle ossa nasali che si frantumavano, seguite rapidamente da zigomi e mandibola superiore. Gli occhi scivolarono fuori dalle orbite in una specie di schiuma rosata di sangue e umor vitreo, scendendo fin quasi contro le labbra, labbra a propria volta sformate in una smorfia prognatica che era un disperato sforzo di ridere ancora o almeno di spalancare un urlo, le ossa e i denti maciullati nascosti dalla linea innaturalmente rigonfia delle labbra oppresse dall’implosione. Non ne uscì che uno sputo imbronciato di sangue, prima che la bocca venisse inghiottita nella nuova dilatazione della gola, spalancatasi fino ad appiattire le proprie pareti lungo il bordo del collo e il cranio. Una corona di denti come quella di un verme marino gigante iniziò a seghettare i contorni di quella che fino a pochi minuti prima era la faccia, poi con un ultimo schiocco risucchiante la creatura serrò le nuove fauci di rettile alieno per subito dopo spalancarne l’enormità, una bocca da anaconda cieca i cui denti ritagliavano il bordo del viso inghiottito, sotto il mento, lungo le guance e lungo l’attaccatura dei capelli. Al posto del volto non c’era più che il sospiro rauco e tiepido che usciva dalla gola del serpente, nera del nero impossibile della carne.
Miloš aprì gli occhi.

Una farfalla notturna premeva contro il vetro ghiacciato dello scompartimento.
Quando Miloš si svegliò, si ritrovò ancora sul treno, tre dita premute sul cuore come a consolarlo dello spavento.
Ma sorse nel palmo della mano, a spazzare via ogni sollievo, il bordo tagliente di un biglietto da visita che gli era stato infilato tra le dita mentre dormiva.
Il recto recitava
arch. ABRAHMO ABRAMJ, presidente
senza specificare di cosa Abramj (che Miloš aveva incontrato in sogno? poteva dunque apparire così, come un’infezione fosfenica? un’infezione che lascia biglietti da visita) fosse presidente. Quasi come ci si dicesse amanti, senza però rivelare l’oggetto dell’amore.
E nel verso:
Perdoni se può la libertà che mi sono preso.
Suo,
AA
Ritrovata nella ripetizione la loro indeterminatezza, le due A apparvero allo stravolto Miloš come il pittogramma di due primitive falene.
Il treno andava ancora.

[continua il 22 novembre]

 Sul romanzo in versi - Alberto Volpi
Sul romanzo in versi - Alberto Volpi Presiden arsitek/ 50 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 50 - Angelo Angera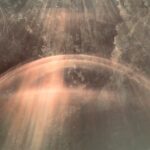 Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera Nella neve perenne/ 2 - Danilo Laccetti
Nella neve perenne/ 2 - Danilo Laccetti Presiden arsitek/ 59
Presiden arsitek/ 59 Infinite Jest, la serie TV: ex-vampiri e mambo minimali
Infinite Jest, la serie TV: ex-vampiri e mambo minimali Presiden arsitek/ 28
Presiden arsitek/ 28 Presiden arsitek/ 40
Presiden arsitek/ 40





















