
Da bambina ero felicemente triste. Mi capitava spesso, e anche nei momenti più allegri, di scivolare in una sensazione lunga e lenta, di qualcosa che si ferma, o si interrompe almeno, e ti fa sentire che tutto si ferma e si interrompe, ed è come se non ci fosse già più intorno a te, anche se sta ancora lì, come prima.
Mi poteva succedere davvero sempre, anche in una giornata di sole pieno, con il manubrio della biciclettina che scintillava, il vento sulla faccia, le mamme sedute sulle panchine e l’acqua dell’Arno che scorreva accanto. Tutto bello e tiepido e luminoso, fino a quel momento di tristezza, che bloccava le cose al loro posto e me le faceva immaginare finite, lontane, desiderabili e perse.
Ci pedalavo dentro, a questo fermo immagine triste, e me lo godevo fino in fondo. Finché passava, come era venuto, e mi ritrovavo a saltare su una cunetta, o a fare una corsa a perdifiato. Con il sole, le mamme e l’acqua del fiume di nuovo dov’erano.
Negli anni dopo l’infanzia, quella tristezza felice si era trasformata spesso in uno stallo dei sentimenti. Un avvitamento in cui il dolore giovanile precipitava senza attrito, e da cui era difficile rialzarsi e riprendere il controllo.
Da adulta, invece, erano arrivate le barriere, le torri di controllo, i campanelli di allarme e l’abitudine alla difesa. E le sensazioni con lo scafandro, adatte a circolare in qualsiasi atmosfera.
Ma, ora, quella tristezza che provavo da bambina, senza difese e senza pentimenti, mi si ripresentava allo spirito come un momento luminoso, desiderabile quasi, mentre sedevo sulla panca della chiesa, stretta fra le giacche dei parenti.
In mezzo alla chiesa dei Salesiani, al funerale di una cara zia, il dolore veniva su, come un sogno indigesto, e per la prima volta, dopo tanto tempo, non sapevo come contrastarlo. Dopo aver seppellito con dignitosa saldezza tanti parenti, e in quella stessa chiesa perfino i miei genitori. Lì in quel posto grande e chiaro, accogliente, che era stato il luogo dei momenti salienti della loro vita: il loro battesimo, il loro matrimonio, il loro funerale… Mi sono trovata fra i singhiozzi, sconfitta dalle lacrime che non riuscivo a trattenere.
Dopo la cerimonia ho passeggiato nella città dove non vivo più da tanto tempo, e dove ogni cosa è bloccata nella memoria a una fase, una giornata, un’amicizia, una sensazione. Non c’è pietra di Firenze dove non ci sia un pezzetto di me, legato a una situazione del passato.
Il centro, poi, così piccolo e curato, pieno di gente che si muove con discrezione, e i palazzi che disegnano le epoche storiche dentro prospettive piccole e armoniche… il centro mi dà l’impressione di camminare in casa, dentro casa mia, e quando piove sembra che mi stia piovendo in salotto.
Dopo il funerale, andavo per le sue stradine medievali – strade strette, che sembrano le braccia di una mamma che ti sostiene mentre vai: “Su che ce la fai…” pronta a prenderti se stai cadendo – e in ognuna ritrovavo un fatto successo tanti anni fa. Quando ero entrata in quel negozio, quando avevo fumato in quel bar, e lì ci abitava una mia amica, là lavorava una mia parente, là, là, là… tratti di vita su ogni scorcio.
Anche le piazze sono piccole, a Firenze, e non sono moltissime. Ma ce n’è una, Piazza della Repubblica, che è stata modificata in quei pochi anni in cui Firenze è stata capitale; quando vennero buttate giù case e torri antiche, e il ghetto degli Ebrei venne spianato per fare una piazza grande come un quartiere, bordata da palazzi più squadrati e più solenni di tutto quello che gli stava intorno.
Anche adesso che lo spazio è stato ridotto dai ristoranti, con i tavoli e i funghi per il riscaldamento infilati sotto vetro come l’arredo di un acquario, la piazza resta enorme. Così larga da offrire tanto cielo, e da farti sentire scoperto e vulnerabile, dopo l’abbraccio delle stradine.
Una giostra monumentale, nel centro della piazza, è quasi sempre vuota, ma il suo piccolo angolo di infanzia ti rassicura con un movimento perenne di cavalli dorati e carrozze.
Il sole era pieno e alto, il giorno del funerale. E, nella piazza, c’era abbastanza spazio per farmelo battere sulla faccia. Per sedermi su una panchina a riposare, scaldarmi al sole, e godermi la compagnia della giostra. E per ascoltare la musica di un uomo scuro e tarchiato, trasandato, coi lineamenti che ho catalogato subito da straniero, anche se non saprei dire perché. In qualche modo si vedeva che non era di lì, che ci stava solo per far soldi con la musica. Come i madonnari cinesi e i mimi marocchini. Nel tempo le esibizioni di strada hanno trovato il loro giro economico, e si sono internazionalizzate.
Lo straniero aveva un violino collegato a un amplificatore, e suonava un repertorio malinconico, di musiche classiche più o meno note. Le eseguiva bene, non so se con particolare correttezza, ma con il dovuto trasporto.
Il suo violino per me è stata come la puntina che si poggia sul disco di vinile; mi si è posato sulla mente e ha acceso la musica della tristezza. Di colpo, senza che me lo aspettassi, e senza il tempo di volerla arginare.
Mi sono trovata in quel momento, lungo e lento, dove le sensazioni stillano una per una e cadono in un punto fermo della mente. Un luogo dove raggiungere le cose che non ci sono più.
Il violino mi riportava verso tutti i pezzi di me che stavano sparpagliati in giro per Firenze, uno su un marciapiede, l’altro su una vetrina, un tetto rosso, un portone…
Ho lasciato la piazza e mi sono messa a camminare continuando ad ascoltarlo, il violino, anche nelle strade vicine, e poi dentro la mente. Le vibrazioni della musica proseguivano, identiche a quando lo strumento mi stava accanto.
Intanto continuavo a raggiungere i ricordi, a piangere, e a desiderare di essere triste ancora per un po’.
Ho riconosciuto questa sensazione e la sua mancanza, allo stesso tempo. La lunga mancanza di quando tenevo la tristezza così lontana da me, e mi perdevo qualcosa. Mi privavo di questo ponte, di questo volo solido verso le cose che amavo, e che erano lontane. O perse.
Dopo, in treno, tornando a Roma, continuavo a pensarci. Mi coccolavo gli ultimi lasciti di quelle sensazioni, ed ero di nuovo triste e non ero infelice.
La tristezza ora si posava sul paesaggio oltre il finestrino. Un paesaggio buio di cui riuscivo a vedere solo le lucine dei paesi, sospese qua e là.
Era triste e piacevolissima, la sensazione del paesaggio al buio e delle case dove non ero, dei luoghi che attraversavo sapendo che non ci avrei mai vissuto.
Pensavo alla casa dove in quel momento qualche bambino stava facendo i compiti, qualche ragazza si truccava per uscire, qualche malato guardava la televisione. Immaginavo con un’accettazione dolce, senza strepiti e turbamenti. Sentivo un’unica presenza, dentro a tutte le cose della sera. Come un’anima triste del mondo, da abbracciare senza paura.

 Il ritardo - Walter Nardon
Il ritardo - Walter Nardon Intervista a Gianni Agostinelli - Gustavo Paradiso
Intervista a Gianni Agostinelli - Gustavo Paradiso Cronache americane / 3 - Francesca Andreini
Cronache americane / 3 - Francesca Andreini La prima volta che ho capito l’inno americano - Francesca Andreini
La prima volta che ho capito l’inno americano - Francesca Andreini Cronache americane /2 – I
Cronache americane /2 – I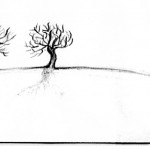 I primi passi di Gino
I primi passi di Gino La prima volta che ho letto una lapide
La prima volta che ho letto una lapide Cronache americane/ 2 – II
Cronache americane/ 2 – II





















