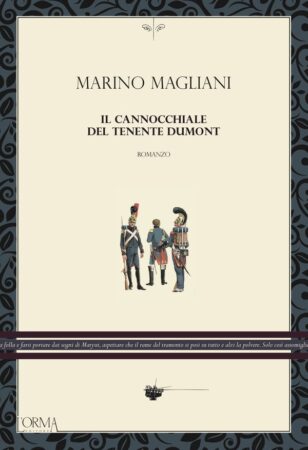
Marino Magliani è una di quelle figure che nella nomenclatura degli autori di letteratura Italiana dei nostri giorni si usa definire, con ipocrita degnazione, “uno scrittore appartato”. E Magliani, scrittore e traduttore di puro talento, appartato di fatto, e da sempre piuttosto estraneo alle conventicole letterarie nostrane, lo è un bel po’; nel senso che egli è propriamente un outsider, un fuoriposto. Emigrato giovanissimo dalla natia Liguria, dopo aver vissuto avventurosamente in gran parte della sua vita fuori dall’Italia, vive in Olanda, a IJmuiden sulla costa del Mare del Nord (“Soggiorno a Zeewijk”, Amos, 2014) ormai da molti decenni. Anche se alla sua piccola valle ligure della nativa Dolcedo Magliani ritorna sovente con la sua narrativa (“Quella notte a Dolcedo” Longanesi, 2008; Liguria – Spagna e altre scritture nomadi, Pellegrini, 2016). Ma certe distanze alla lunga contano, e contano più di tutto, specie quando si deve distillare nella lontananza di tempo e di luogo uno strano romanzo storico -ovvero, un apologo storico e antropologico-, e compitare con scrupolosa precisione una trama e le parole giuste per definire una vicenda immaginaria così complessa da portare in pagina. E’ forse per questo che nel suo migliore romanzo, “Il cannocchiale del Tenente Dumont” (L’Orma, 2021), forte è la sensazione che questo grande affresco sia scaturito dalla sospensione creata dalla grande lontananza di tempo e di luogo sin qui accumulata dall’autore. Il libro pubblicato da poco, dopo più di vent’anni di infinite ricerche, riscritture e di paziente lavoro sul testo. E’ questo un romanzo che si misura infatti con il limite del dicibile, con l’estremo della storia e dell’esperienza umana individuale; anche se sembra da principio una cronaca iperletteraria alla Jan Potocki: un manoscritto e fonti storiche e biografiche intricate e di difficile decifrazione, tre sbandati dell’esercito napoleonico in rotta, la guerra e il peso dei suoi orrori, la perdita di senso delle azioni umane che ne derivano, lo smarrimento che si trasforma per i protagonisti, dapprima in sbandamento e poi nella condizione di disertori e traditori, apolidi e senza patria. “Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani racconta la storia di tre soldati napoleonici, che tentano la sorte del ritorno dopo la disastrosa campagna in Egitto, le cui ferite sono lenite dalla scoperta dell’hashish. Rimandati a forza nuovamente al fronte nella campagna d’Italia, disertano durante la battaglia di Marengo del 1800. Proprio in ragione del loro strano legame dovuto al cameratismo dell’avventura esotica, dalla divisa napoleonica e dalla scoperta della droga, sulle loro tracce si mettono gli emissari del Dottor Zomer. Un delicato e ossessivo medico olandese che vuole provare che la causa principale della diserzione sia proprio da ricercare negli effetti della droga importata.
Il capitano Lemoine, minato dalla tisi e tormentato da fantasmi amorosi, il tenente Dumont, giovane artista mancato e soldato napoleonico per amore d’utopia, e il soldato semplice Urruti, un basco violento e oscuramente attratto dall’avventura della guerra, si ritrovano così a vagabondare per i boschi liguri, perennemente braccati non solo dai loro inseguitori, ma dalla loro stessa diserzione: “Disertare è qualcosa che non finisce, diventa una missione, una carriera, un grado”. Tutta la vicenda è sapientemente immersa dapprima nei colori pastosi e nella luce africana, nell’atmosfera di un orientalismo raffinato che ricorda la pittura francese di età napoleonica. Poi dopo lo sbandamento iniziale e la diserzione i tre protagonisti si perdono in un vagabondaggio famelico e scoraggiato ai margini delle valli di confine liguri, alla disperata ricerca di un imbarco liberatorio per l’isola di Cipro. I fatti narrati si tingono però pagina dopo pagina di un esotismo scuro e senza compromessi, in cui tutto è sguardo, inganno percettivo, paesaggio d’ombre squarciato da fiotti improvvisi di luce, e la mappa che disorienta il calco di un labiranto di sorveglianza a distanza e di incessante nascondimento, e dove tutto sembra ritardare una caduta che spira verso ciò che deve finire in modo disgraziato e mortale. I tre sono promessi alla morte. Come mortale è appunto l’attrazione sviluppata per le droghe africane e orientali, per l’hashish che lenisce i dolori insensati della guerra e annulla la coscienza dei soldati napoleonici trasformandoli in drogati. Se questo non bastasse si apprende che i tre sbandati altri non sono che i soggetti di un primo esperimento sociale condotto a distanza su cavie inconsapevoli da un occhiuto apparato di potere. Dunque non resta che la diserzione, che diventa subito un gioco di scacchi, una diserzione elevata a potenza simbolica, una sorta di gioco di specchi e di sguardi che si moltiplicano in una sorta di infinito mise in abim, prima di scontare il finale di una vicenda che non si conclude, che rimanda la propria fine come diserzione dal suo stesso compimento. La diserzione non è dunque che la storia di un’attesa che non cessa di interrogare i protagonisti, uno per uno e tutti insieme raccolti nel vorticare di un finale inevitabilmente tragico e luttuoso, eppure aperto ad uno spiraglio di luce che sorprende il lettore che giunge in vista di un ultimo geroglifico nascosto tra le pagine. Poi ci sono i caratteri dei protagonisti: le passioni erotiche e ambiguità irrisolte del Dottor Zomer, medico chirurgo che da sempre vive all’ombra del suo famoso collega Larrey, sono la rappresentazione degli intrighi e delle insidie che comporta ogni rapporto umano soggetto a potere e gerarchie. Se Zomer insegue l’avventura del delirio a distanza nella cupa fantasia di un nuovo esperimento scientifico che scatena passioni e bramosie, il tenente Dumont è costretto a mettere la sua vita nelle mani di un capitano morente che non sembra fidarsi di lui abbastanza da metterlo a parte dei propri piani, e che non ha invece dubbi a fidarsi di un fante basco dal passato turbolento e imprevedibile e dall’indole feroce e sinistra.
Questo gioco indissolubile di dissidi insoluti e di ombre taglienti consente a Magliani di scatenare le sue abilità di narratore. Accade affidando il senso di questa vicenda alle potenze dello sguardo. L’occhio diventa protagonista, l’occhio assoluto e il suo lavoro incessante (simboleggiato dal cannocchiale-protesi che accompagna il cammino del tenente), l’organo sommo che processa il mondo, le cose animante animate, le pietre e i cuori, i fiori e le farfalle, i fantasmi fatui e cupi del passato, i sogni invisibili del tempo che forse cadrà. L’occhio, il cui fascio vaga e scruta alto e basso come quello di un Dio che cerca requie. È lo sguardo mimetico che Magliani utilizza con maestria in una prosa acuminata e microfisica che va ben oltre il dettaglio, ricca com’è di descrizioni ravvicinate, di capovolgimenti improvvisi del punto di vista, di metafore barocche, mossa da visioni da entomologo e da abbandoni alle sensazioni trasognate e solitarie. In questo modo egli è stato capace di avvolgere l’intera sequela di scene e di vicissitudini che compongono il narrato di questa sua storia come in un sorta di vaticinio del tempo. Un finissimo tessuto di parole, scabro e poetico, incatenato ai sentimenti senza fondo che risalgono dall’animo umano quando questo è sopraffatto dal caos incipiente, esposto di continuo al pericolo del nulla, allacciato alle stesse forze indominabili della natura che spirano come un vento di entropia da dietro la tenda dell’orizzonte insondabile delle cose, rendendo così il suo composito e misterioso palinsesto molto simile a un resoconto delle visioni oniriche deformate dall’hashish. O forse meglio, al presagio umile e solenne di uno mistico che vaga in cerca della verità per i deserti d’oriente: “il capitano lo diceva che non si diserta, non da laggiù, dalla sabbia, dall’assoluto nulla”.
Il lascito interrogativo e perturbante di questo insolito e intimissimo romanzo, si prolunga ben oltre la soluzione del rebus consegnata alle sue pagine finali. Si ritrova piuttosto in un senso più profondo di pena e di meraviglia, in un fervore inquieto di pietà universale: “La pietà che lasciano i ricordi, la pietà in genere”, dato che come per ogni vita che si inabissa invisibile nel buio del non storico, lasciando dietro di se solo la scia breve di tracce labili e impermanenti, altro non resta che il racconto, il supremo presagio della mortalità. Ed è per questo che peggio della morte per i viventi “non c’è condanna più severa di quando senti i preparativi per un’impiccagione giù nel piazzale, e l’agitazione nei corridoi”. Che la vita duri, comunque, di fuga in fuga, di diserzione in diserzione, ancora un altro po’. Come si fa quando si capovolge l’ottica di un cannocchiale e tutto per magia invece di avvicinarsi, rimpicciolisce e si allontana dagli occhi e dalla coscienza, perché se vivere è la pena che si sconta vivendo, tutto il suo dispendio, il suo acre prezzo finale “non si può pagare tutto in attimo”.

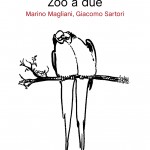 Zoo a due - Redazione
Zoo a due - Redazione Presiden arsitek/ 48 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 48 - Angelo Angera Il puzzle grottesco di Pietro Altieri - Gustavo Paradiso
Il puzzle grottesco di Pietro Altieri - Gustavo Paradiso Presiden arsitek/ 38 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 38 - Angelo Angera






















Leggere le ” meraviglie” di Zibaldoni , al risveglio , prima di fiondarsi negli obblighi del giorno, sentire di insensatezze e di miserie degli umani, è un pensiero felice che attenua quel che ci attende.
Recensione bellissima.
Grazie