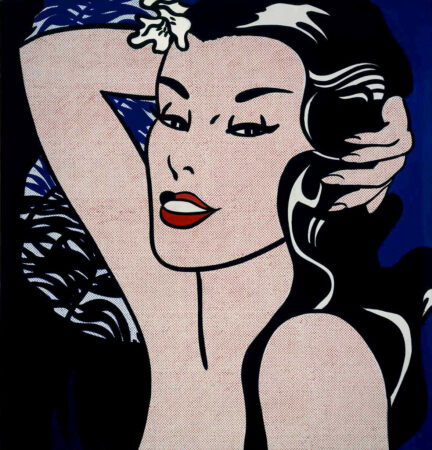
Incorniciata dalla finestra, l’espressione con cui Carlo si dirigeva a grandi passi verso il Centro Bellarmini era l’immagine dell’euforia: su un ottimismo di fondo che sfumava in un’opinione di sé ancora inverosimilmente integra, nonostante le numerose sconfitte, si erano stratificati la convinzione di agire per il meglio – pronto come era a finanziare un progetto degno di lode – e la soddisfazione per una resa che in termini di consenso si presentava agile e sicura. La verità era che la nuova sede della cooperativa sociale Aiutiamoci l’avrebbe sostenuta chiunque, non richiedeva una complicata mediazione politica. Ad ogni modo, la scontrosa spavalderia dei primi anni da amministratore aveva lasciato il posto a un’aria cordiale che ne poteva confermare il successo: era lanciato. Poche volte lo avevo visto così in forma.
Sapevo dove era diretto perché fra mezz’ora ci sarei dovuto andare anch’io. Intanto, berretto da baseball in testa, come i miei amici ero impegnato in un pranzo di ringraziamento per i volontari che avevano dato una mano a organizzare la festa delle associazioni. Eravamo una ventina. Fra chi aveva lavorato per la comunità e chi invece lo aveva fatto per la propria associazione si trattava solo di sfumature, c’era un’intesa comune. I più vicini alla finestra l’avevano spalancata invocando una corrente d’aria che io invece temevo.
«Finché si tratta di In Utero la cosa ovviamente sta in piedi. Ma se parliamo della differenza fra C’è chi dice no e Liberi liberi» mi disse Claudio, «è un altro discorso: c’è stato qualcosa di diverso, un casino ingiustificato, come poi in Gli spari sopra, un casino inutile, come se, avendo sentito il baccano che si sentiva in giro, avesse dovuto mettersi a farne un po’ anche lui».
«Forse si è fatto prendere la mano».
«Sì, c’è qualcosa di troppo voluto. Prendi Nessun pericolo per te – che pure è ancora diverso –, se togli Gli angeli e Sally, per me resta poco. Premesso che, con quello che ha fatto, potrebbe anche anche prendersela comoda, è andato un po’ fuori fase».
Due volontarie stavano servendo le coppe di vaniglia. Dovevo andarmene, ma avrei voluto continuare la conversazione. Con Claudio mi pareva di poter evitare una delle discussioni-chiave dell’adolescenza – peraltro ancora ricorrenti – incentrata sul fantasma musicale che occupava il nostro tempo libero. Non era facile comprendere come si fosse formata la definizione di musica commerciale, capire da cosa dipendesse, perché naturalmente non si trattava solo di musica da sottofondo, né il successo bastava da solo ad attribuire la qualifica; men che meno la attribuiva l’evidente stanchezza di alcuni risultati (gli U2, ad esempio, stavano diventando commerciali). Chi si accalorava di più su questo tema non aveva conoscenze musicali apprezzabili, non suonava uno strumento, né padroneggiava la lingua inglese. Eppure qualcosa aveva capito, anche se non era ancora chiaro cosa. Il termine si trovava al centro di una grammatica di cui alcuni erano diventati incontestabilmente esperti.
C’erano poi i casi in cui l’etichetta non si poteva usare: quello dei Pink Floyd, ad esempio che – per quanto non fossero più una formazione innovativa – venivano ancora collocati all’estremo opposto di questo fenomeno, avendo raccolto da noi un numero imprecisato di devoti che io detestavo. Da questi appassionati si poteva imparare che l’ascolto dei Pink Floyd richiedeva un rito particolare, non solo una disposizione d’animo pronta ad accogliere la novità con fede non finta. I discorsi erano sempre più stentati: al di là dell’aspetto tecnico (in cui nessuno entrava, e che tutti si sforzavano inutilmente di ritenere irrilevante) la principale differenza fra la musica commerciale e quella non commerciale sembrava essere data da due diverse forme di ascolto. E così The Fly degli U2 (1991), ascoltata con devozione, non era ancora del tutto commerciale, mentre passava per esserlo La vita è adesso di Baglioni (1985), che si sentiva ancora e che musicalmente aveva invece molto da dire. Claudio studiava pianoforte. Aveva un’idea precisa delle sue preferenze, in base alle quali tagliava corto, a differenza di altri amici, come Enzo e Stefano, seduti più in là, che una volta, su Use your Illusion I (1991) dei Guns ‘n’ Roses, erano pressoché venuti alle mani. Ecco, venire alle mani per un disco del genere dava un po’ l’idea della faccenda. Ma sentivo che se non mi fossi sbrigato sarei arrivato in ritardo al Centro. Così finii il gelato e, salutando, dissi di dover correre a casa (affari di famiglia).
2.
In un certo senso era vero. Anzi, lo avvertivo con maggior forza rispetto a un normale impegno: me lo aveva chiesto Bianca e per quanto sulle prime non lo sentissi nelle mie corde, la mia curiosità era cresciuta. Ossia, dato che lei lo riteneva interessante, doveva certo presentare qualche aspetto degno di nota. Del resto, con Bianca avevamo preso l’abitudine di ribadire per scherzo, prima di congedarci, che saremmo rimasti d’accordo, quindi avevo data la mia presenza quasi per sicura. Camminavo dunque verso un incontro di esegesi biblica sul libro dell’Esodo, evenienza che qualche mese prima avrei considerato fortemente improbabile. Dalla mia avevo però almeno un elemento certo di interesse: l’ospite e relatore, padre Orazio Koch, un francescano che scriveva musica, l’autore della celebre Noi speriamo in te, fra i pochi pezzi religiosi recenti che non solo trovavo sopportabili ma che riuscivo perfino ad apprezzare.
Il centro non era distante. Non mi ci volle tanto ad arrivare. Era ospitato in una sorta di dependance di un ottocentesco palazzo asburgico. Benché fossi piuttosto nuovo in quell’ambiente – la sala in penombra, le vecchie sedie in finta pelle, l’aria di un ambiente conservato con diligenza per cinquantatré anni – mi accorsi di conoscere quasi la metà dei partecipanti. Andando a prendere posto verso il fondo, rimasi sorpreso dal calore con cui i presenti si salutavano fra loro e con cui salutavano anche me. Mi misi in disparte, cercando di dar mostra di un equilibrio tutto da dimostrare.
Mentre sua moglie si sedeva, Fernillo, un manovale mio vicino di casa che aveva circa quarant’anni, mi si fece incontro: «Sono contento di vederti. In questi incontri si capisce davvero che cosa sia oggi un discorso religioso: non c’entra con la Chiesa e neanche con l’idea che lo stato, o la società, si sono fatti della religione. Non c’entra niente con le istituzioni».
Stavo per rispondere: «Capisco», ma non ce ne fu bisogno: non mi guardava neanche, non cercava un interlocutore, girava con lo sguardo per la sala.
Erano forse i primi sintomi di un comportamento che avrei compreso solo più tardi, quello per cui la partecipazione a questi incontri forniva l’immagine di una società alternativa nella quale credere e della quale sentirsi parte, una società lontana dalle difficoltà sgradevoli della politica, così come dagli obblighi di una religione che poteva illudere di non chiedere più neanche il rigore della fede, ma solo una smisurata comprensione (priva di responsabilità). Feci qualche cenno di assenso al suo discorso, e poi, quando tornò verso la moglie, mi misi a sedere.
Fra quelli che erano rimasti in piedi davanti all’entrata, si distinguevano sette, otto che conoscevo di vista. Dall’eleganza degli abiti e dei loro gesti si coglievano i segni di un’educazione fuori del comune. Avevano forse venticinque, ventisette anni (i più erano già laureati). Stavano per raccogliere il testimone dai loro genitori: liberi da preoccupazioni materiali – figli di una generazione ricca e spenta – erano attivi nell’organizzazione di questi eventi a cui – va detto – avevano impresso un rigore e una credibilità maggiori rispetto agli incontri a cui ero solito partecipare. Fra loro, due ragazze eleganti tenevano in mano il programma della stagione e si confrontavano prendendo accordi per definire i dettagli della data successiva. Nella mia estraneità all’ambiente, avevo però avuto una piccola esperienza di avvicinamento con una di loro, Emma, la bionda e più giovane delle due: cortese, dall’aria estremamente affidabile, l’avevo incontrata al termine di un cineforum, dove avevo colto che le mie preoccupazioni sembravano esserle incomprensibili molto più di quelle di Fernillo. Non sapevo di che vivesse: si appassionava ai discorsi culturali. Appena si entrava in dettaglio, subito la sua attenzione si destava, quasi al richiamo di un’eccitazione segreta, al punto che sulle prime mi ero perfino chiesto se non avessi un po’ fatto colpo su di lei. Poi però l’equivoco si era chiarito. Quando si era trattato di passare dal mondo delle idee a quello delle cose, scoperto che in termini di relazioni avevo poco da offrire, si era scostata quel minimo da farmi capire che la distanza fra di noi non poteva essere colmata; non in questo mondo, almeno. Non direi che mi ignorasse, anzi; sembrava però sorridere dell’idea che si era fatta di me in un primo momento: chi l’avesse osservata meglio non si sarebbe sbagliato nel dire che salutandomi in realtà si compiaceva di se stessa.
Bianca era in ritardo.
Da una porta interna uscì padre Koch: aveva un’apparenza ordinaria. Un tempo credevo che l’ingegno dovesse manifestarsi in un dettaglio dal quale si sarebbe compresa al volo la profondità dell’espressione. Certo, lo sguardo, il tono di voce sono spesso indizi perentori ma, per una disposizione provvidenziale della nostra specie (posta probabilmente a tutela della maggioranza degli individui) non è detto che l’ingegno si colga anche a distanza. Da lontano Koch appariva un uomo di altezza media, piuttosto robusto, con i capelli grigi tagliati a spazzola e un viso largo su cui campeggiavano un paio di solidi occhiali con la montatura in metallo. Indossava un maglione antracite sui pantaloni neri – quasi la divisa di un uomo di chiesa – e teneva in mano dei fogli e tre libri che sarebbero serviti per il suo intervento. Sulla via del palco fu fermato da Emma e dalla sua amica, che suppongo dovessero comunicargli alcuni particolari sulla serata.
D’un tratto, dalla porta d’ingresso sbucò anche Carlo Transi. Guardò i presenti con un’espressione che diceva: «Comodi, comodi», come se al suo apparire qualcuno avesse avuto intenzione di alzarsi per omaggiarlo, mentre invece nessuno era stato sfiorato dall’idea.
Voltandosi verso di me Fernillo a bassa voce, scandendo le sillabe, mi fece: «Carlo Tran-sit», riprendendo un gioco di parole allora in voga che ovviamente si riferiva al furgone Ford, non al verbo latino. Carlo era andato incontro a padre Koch, a cui strinse la mano con vigore.
Sul palco ebbe modo di riprender fiato sedendosi un attimo, mentre Emma diceva due parole per introdurre la serata. Gentilissima, non sospettava neppure che qualcuno, davanti a tanta cortesia, potesse dubitare di lei.
Invitato a prendere la parola, Carlo fu efficace. Più breve, si rivelò anche più disinvolto del solito. Poi, interpretando a suo dire una delle domande del pubblico, si girò verso padre Koch e gli fece:
«Prima di parlare di faccende più modeste, padre Koch, la prego di togliermi una curiosità che credo stia a cuore un po’ a tutti: come le è venuta in mente la musica di Noi speriamo in te?»
Accennando appena un sorriso davanti a una domanda che doveva essergli stata rivolta parecchie volte, Koch rispose: «Il mio lavoro è qualcosa di ordinario. Ci vuole pazienza. Quando scrivi stai sempre a lavorare intorno a un’idea musicale. Quella era probabilmente una buona idea».
Carlo annuì mostrando il suo stupore davanti alla creazione artistica. Non che fosse digiuno di musica – aveva suonato il clarinetto nella banda – sapeva però per esperienza che mostrare di non comprendere l’arte, rispettandola come un mistero, riesce a conquistare lo spettatore. E in effetti, davanti alla sua espressione, il pubblico fu percorso da un moto di giubilo. Come sempre, sapeva il fatto suo. Parlò quindi della cooperativa Aiutiamoci, che aveva portato all’attenzione dei servizi provinciali competenti e che seguiva nel suo «lodevole impegno» con gli emarginati. La sede, alla quale negli ultimi tempi si era interessato anche padre Koch – sollecitando l’opinione pubblica a farsene carico – doveva essere interamente ristrutturata. Carlo si dispiacque di non poter ancora assicurare il risultato pieno (la nuova sede completa dell’arredo), ma era lì per annunciare che il primo lotto dei lavori sarebbe partito entro due mesi. E questo era già qualcosa.
Mentre mi disponevo a seguire l’intervento sull’Esodo, Bianca sbucò dalla tenda della porta d’ingresso: mi individuò e mi fece cenno di seguirla. Sembrava agitata. Cercando di fare il minor rumore possibile, uscii verso il fondo, dietro l’ultima fila di sedie.
«Cosa c’è?»
«Mia cugina. Adesso ti dico».
Anna, che viveva da sola, aveva subito un aborto spontaneo mentre era in casa. Nessuno era al corrente della sua gravidanza: non era neanche di tre mesi. L’emorragia era parsa subito grave. Aveva telefonato alla madre di Bianca, che era corsa in macchina a portarla all’ospedale e, dato che Anna era robusta, aveva chiesto a Bianca di accompagnarla per darle una mano. Poi, arrivate al Pronto soccorso, la madre era rimasta con la nipote e lei era tornata verso il centro.
«Non ha detto una parola: piangeva, non so se per il dolore o per quello che era successo» Bianca era ancora turbata: «Non pensavo che volesse un figlio; del resto, come fai a saperlo? non ha detto niente, non ha chiamato nessuno (a meno che non lo avesse già fatto prima anche se, in questo caso, certo nessuno è corso a casa sua). Non sapevamo che avesse una storia, ma in fondo non è neanche detto che ce l’abbia».
«E come sta?»
«Dal Pronto soccorso l’hanno portata in Ginecologia. Vedremo».
Ci eravamo seduti su una panchina davanti al Centro. Sua cugina dopo la laurea e un’esperienza come supplente di Italiano si era impiegata nel Servizio statistica della Regione. L’avevo incrociata alcune volte in libreria, dove comprava saggi di storia. Non partecipava agli incontri delle associazioni. Rispetto al mio modo di guardare ai libri, avevo intuito in lei una maggiore deferenza per gli scrittori: una volta mi aveva detto di aver seguito una conferenza su Calvino «fatta proprio come si deve». Credo che alludesse al rispetto che si deve alla fama dello scrittore indiscutibile: aveva grande considerazione per il dibattito, che a me invece interessava poco; non riuscivo a capire per quale ragione, dopo aver lasciato l’insegnamento e superato un nuovo concorso, fosse andata a impiegarsi in un ambito che la lasciava così lontana da questi temi. Secondo Bianca, nessuno lo sapeva, tanto che sua madre a volte era tentata di credere che ci fosse di mezzo un legame finito male.
Carlo uscì dal Centro, sempre diretto altrove.
3.
La famiglia aveva minimizzato, qualificando il problema di Anna come un generico disturbo femminile per cui aveva dovuto essere ricoverata. Così nelle parole di sua madre. Suo padre, però, incerto sul da farsi – se mostrarsi condiscendente col destino della figlia o cedere all’incomprensione che aveva sempre mostrato per lei richiamandosi al luogo comune per cui finiamo tutti per ricadere negli stessi errori – si era risolto a sostenere che Anna aveva dovuto liberarsi da un problema che la tormentava da qualche tempo. Suo fratello Saverio, rimettendo a posto il compressore, aveva aggiunto che «per fortuna certi problemi, in un modo o nell’altro, il più delle volte si risolvono da soli».
Nel succedersi di queste espressioni, a cui avevo assistito andando nel loro laboratorio per farmi fare un buco in più nella cintura, proprio mentre i due prendevano in carico il mio problema, mi era d’un tratto venuto in mente che se durante l’infanzia alcuni dei primi nomi che impariamo restano poi legati al singolo oggetto a cui sono riferiti – sostituiti in seguito da altri oggetti, a cui ci legano esperienze emotive più forti – è altrettanto vero che in seguito, le prime relazioni, i primi rapporti umani di cui intuiamo il legame al di là della parentela, tendono ugualmente a persistere nella nostra coscienza; sopra lo strato di nomi e oggetti dell’infanzia poniamo quello semitrasparente delle relazioni apprese più tardi, ciascuna singolare e ciascuna provvista a modo suo di un grado di esemplarità. La particolare tenaglia che serve per forare il cuoio l’avevo vista per la prima volta da loro, quando ci ero andato con mio padre: avrò avuto dieci anni. Ed era ancora lì appesa sopra il banco, in parte ricoperta dalla vernice rossa che ricordavo, logorata dall’uso. Anche l’immagine del rapporto contraddittorio fra i due fratelli falegnami e titolari dell’impresa era ancora lì, come l’avevo colta più tardi, quando aveva rivestito per me una certa importanza nella comprensione delle dinamiche regolari di una società in nome collettivo.
Tornata a casa e alla sua vita clandestina, Anna aveva ripreso un’esistenza in apparenza priva di scossoni, per quanto ciò che era successo suggerisse che la sua realtà affettiva doveva essere una miniera le cui gallerie sotterranee potevano portare ovunque.
Quella sera, mentre rientravo con Bianca verso la stazione pensando ad Anna, quasi senza accorgermene mi ero trovato a riflettere sulla mia ignoranza degli altri e su un problema che ormai si andava chiarendo a poco a poco, ossia che non avrei più potuto coniugare le varie iniziative sociali – attraverso le quali cercavo di farmi strada – con lo studio; l’orizzonte si era ridotto; e da quella porta non c’era più modo di uscire. Le decisioni che si prendevano in quelle sedi, e ancor più le iniziative che si realizzavano, mi costringevano a valutare di volta in volta le possibilità degli ospiti, dei relatori, come se ogni iniziativa, per acquisire valore, dovesse necessariamente essere svolta dagli altri (in questo modo, tutti i soci continuavano a ritenersi reciprocamente sullo stesso piano); in fondo ogni risultato assumeva rilievo («è andata bene», «meglio dell’ultima volta») solo dal punto di vista amministrativo, con tutte le ambiguità del lavoro culturale. Insomma, il limite appariva ogni giorno più chiaro. Con il dispiacere con il quale si riconosce una battuta a vuoto – per quanto a dire il vero non fosse poi tale fino in fondo – mi trovai a concludere che sarebbe stato più opportuno un gesto di umiltà, un altro passo indietro, anzi lo stesso che avevo già colto in biblioteca, ma preso da un altro punto di vista: studiare senza esitazioni, senza alibi. Avrei dovuto attraversare anch’io gli stessi passaggi che avevano percorso e che percorrevano gli altri: laurearmi, trovarmi un impiego. Sentivo che quanto più mi fossi impegnato su una strada ordinaria, tanto più mi sarebbe riuscito agevole verificare gli eccessi in cui ero incorso, la pretesa di tanti sforzi male orientati. D’altronde, lo straordinario non si rivela mai su una strada nuova, ma proprio su quella percorsa da tutti. Bastava quindi ricominciare, non tanto il giorno dopo, quanto proprio l’istante seguente, prima ancora del rientro a casa. Certo, avrei dovuto tener fede ancora a qualche impegno, ma poi me ne sarei andato.
Sorretta da una maggior fiducia nella ragione, Bianca poteva liquidare questi dubbi come un semplice sbalzo d’umore. Era molto preoccupata per Anna. Nei suoi propositi verso di lei sentivo venir meno una delle aspirazioni che nell’adolescenza non si comprendono mai fino in fondo e che ispirano vari errori di prospettiva. Inutile mentire, la solitudine non basta mai a se stessa.

 Il ritardo - Walter Nardon
Il ritardo - Walter Nardon Un certo tipo di realtà.
Un certo tipo di realtà.  Il premio - Walter Nardon
Il premio - Walter Nardon L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo
L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo Un legame ambiguo. Letteratura e territorio
Un legame ambiguo. Letteratura e territorio Fra i libri e il mondo. Ricordo di Gianni Celati
Fra i libri e il mondo. Ricordo di Gianni Celati Arredo sacro
Arredo sacro La somiglianza segreta
La somiglianza segreta





















