
a Enrico De Vivo, con affetto e riconoscenza
PREAMBOLO
Gli indios camminavano in fila sulla strada che li avrebbe portati alla chiesa. Di quanti erano partiti più della metà erano ormai morti, per le malattie soffiategli in corpo dagli dèi bianchi o per il terrore di vedere ogni giorno per giorni e giorni il mare vomitare e reinghiottire nient’altro che il sole, ogni notte per notti e notti nient’altro che le stelle e la luna sempre più sottile. La terra era sprofondata nell’abisso, e le stelle avevano cambiato ordine nel cielo all’avanzare della nave degli dèi bianchi verso il nulla, e nuovi animali spalancavano le fauci dalla medesima tenebra.
A volte esseri inimmaginabili, senza forma né confine, si avvicinavano alla gigantesca nave degli dèi bianchi, carezzandola con la loro schiena, o forse era la loro pancia, o forse era la loro mano se qualcosa di meschino come una mano può appartenere a esseri simili, o forse una vastissima palpebra di pelle grigia e puzzolente, una palpebra, una palpebra, si bisbigliavano l’un l’altro gli indios, la nave degli dèi bianchi scivolava lungo l’occhio immenso di un dio senza fine e senza cuore, e sarebbe infine sprofondata nel baratro della sua pupilla.
Gli dèi bianchi restavano quasi sempre invisibili, anche loro forse risucchiati nell’abisso del loro dio, lasciando gli indios a morire in quel palazzo galleggiante. Ma morivano anche quando gli dèi erano vicini a loro. Le viscere marcivano come abitate dai minuti insetti trasparenti che a volte vedevano spuntare dalle assi della nave, e la luce del sole sbiancava le loro piaghe in cancrene.
Nella chiesa di san Satiro la vegetazione di Bramante usciva in forma di draghi in fiore che si biforcavano dal ventre di figurine umane, e gli indios nemmeno sapevano più se quella su cui stavano mettendo i piedi, così liscia e fredda, e contornata dentro sé delle stesse linee del mare che avevano traversato, fosse ancora la terra o non una specie di solidificazione dell’acqua, della carne bianca degli dèi, e anche dopo l’arrivo continuavano a morire, gli indios, mentre nella chiesa si raccontava di quadri che avevano cominciato a sanguinare e di statue che durante la notte cambiavano posizione, voltando la testa per non vedere l’obbrobrio di quei pezzenti senza Dio, e alla fine ne erano restati solo due, un indio e una india che messi insieme non raggiungevano i trent’anni, e ad un certo punto il ragazzo, madido di sudore e grigio di panico, aveva lasciato andare proprio davanti all’altare centrale un fiotto di piscio così scuro da sembrare uscito dal fiume di là dal mare in cui lui e la ragazzina, che dicevano fosse sua moglie, andavano con gli altri per raccogliere l’oro.
L’aveva fatta così, in piedi con le braccia penzoloni e impettito come un tacchino, sulla faccia rosso scuro la stolida innocenza di un infante. Da dietro uno degli dèi bianchi lo aveva spinto in terra, proprio contro la pozza scura davanti alle sue gambe. Mentre il ragazzino si metteva carponi per rialzarsi, l’altro aveva alzato la propria spada rinfoderata e gliel’aveva lasciata cadere sul collo. L’indio era caduto riverso nel suo piscio, e quando l’uomo aveva sollevato di nuovo la spada per colpirlo ancora l’altra si era buttata in avanti coprendosi la pancia con una mano e con l’altra la testa del compagno.
Una volta in piedi, il ragazzino camminando aveva continuato a scarrozzare verso destra, gli dèi bianchi che ridendo ne correggevano la traiettoria a pedate e scapaccioni. Il fumo delle candele si anneriva in strisce sempre più lunghe che salivano come lacrime inverse contaminando la vista dell’indio. Era come quando erano scesi a terra dopo giorni e giorni in quel mare infinito, i corpi dei loro compagni che uno dopo l’altro venivano gettati in mare man mano che la malattia degli dèi bianchi li faceva morire. Erano scesi a terra ma la terra continuava a muoversi sotto i loro piedi.
L’indio era caduto di nuovo in una sala bianca da cui scendevano minuscole creature senza pace, uomini e donne non più grandi dei ragni che i due indios trovavano sotto i sassi e sotto le foglie della foresta, e anche loro come quei ragni avrebbero potuto senza difficoltà arrampicarglisi sulle dita per accoccolarsi nel tepore della sua mano lercia. Le gambe e a volte anche le braccia di quegli esseri erano state strappate per lasciare posto a una vegetazione che serpeva poi in nuove bocche, nuove zampe e nuovi occhi sempre più piccoli, e più ci si avvicinava e più fiorivano nuove viscere e nuovi denti da sfamare.
La bambina india gli teneva una mano sulla spalla per aiutarlo a staccarsi da quella parete brulicante che sembrava volerlo inghiottire come le mura immense delle città nella foresta di là dall’oceano dove lei e tutti gli altri erano stati ingannati dagli dèi bianchi ed erano stati convinti a salire sulle loro navi, ed ecco l’unica cosa ora a farli sentire di nuovo a casa era la morte, e la sete di sangue delle mura, come uno stomaco di serpente che ti assottiglia pian piano fino a che anche tu non sia una delle sue fibre, Serpente anche tu.
Il ragazzo sembrò riprendersi, e tornò a seguire la sua moglie bambina, regolando il passo sul suo e appoggiandosi a lei per non sbandare. Se lei non lo avesse corretto, spingendo la propria piccola spalla contro la sua che dopo il colpo in testa si ostinava a seguire quel giro curvo, il ragazzo sarebbe rimasto agirare in tondo tra le creature bianche, e la bambina spingendolo nella giusta direzione piangeva, perché suo fratello era più forte di lei eppure lei ora riusciva a guidarlo, e perché se lei non fosse stata lì con lui gli dèi bianchi lo avrebbero lasciato lì a girare in tondo tra quelle creature fino a che non fosse morto di stanchezza o per la vergogna di non riuscire a trovare l’uscita da una stanza tanto piccola, poi forse lo avrebbero raccolto e fatto rinsecchire e lo avrebbero rimpicciolito come fanno i cacciatori di teste e lo avrebbero appeso con gli altri esseri della stanza, anche a lui avrebbero strappato le braccia e le gambe per farne crescere quelle piante stregate.
Le facce di quegli uomini e quelle donne in miniatura che pendevano mutilati lungo le pareti sorridevano come quelle dei morti. Nessuno avrebbe potuto sopravvivere a quelle mutilazioni. Appena fuori dalla chiesa l’indio aveva vomitato, poi aveva ripreso il cammino appoggiandosi alla sua sposina. Era come quando erano scesi dalla nave dopo giorni e giorni passati sul mare, e appena scesi avevano sentito la terra muoversi sotto i loro piedi, e guardandosi avevano pensato tutti di essere arrivati nel paese dei morti, o di essere saliti sopra un’altra nave, ancora più grande della prima, guidata da nuovi dèi. Il mare non aveva fine, così avevano pensato.
Il giorno dopo, guardando un fiore piccolissimo e azzurro che la bambina gli aveva portato, l’indio si era sdraiato sull’erba impolverata del cortile ed era morto. Ora la bambina era l’unica india rimasta, lei e l’altra bambina che portava dentro di sé. Non si può morire nel paese dei morti, ed era così, e per quell’altra vita che aveva dentro e che si nutriva di lei senza essere mai stata lei, che la piccola sposa aveva capito che quello non era il paese dei morti, e che la pace era ancora lontana.
Nessuno le aveva detto che gli dèi puzzano così tanto, e che il loro fiato è più caldo e soffocante di quello degli altri esseri umani. Sulla nave gli dèi bianchi li lasciavano quasi sempre da soli, ma ogni tanto uno di loro arrivava e sceglieva; di solito prendevano le donne, ma non sempre, e tutti gli indios si lasciavano prendere con tanta docilità (tale era il terrore di essere presi in braccio da un dio, del suo fiato caldo e carico di un profumo così forte da risucchiare in sé la vista e l’udito e tutti gli altri sensi) che capitava agli dèi bianchi di non accorgersi a volte di aver preso in braccio un cadavere se non quando arrivavano dagli altri dèi, e allora si poteva sentirli ridere, e poi il tonfo in acqua del corpo abbandonato. Solo di là dal mare l’india aveva riconosciuto il sorriso che avevano i suoi fratelli e le sue sorelle quando gli dèi bianchi li riportavano, ed era lo stesso sorriso di quelle minuscole donne e minuscoli uomini che erano stati mutilati e appesi dentro il tempio degli dèi bianchi. Il terrore era tale che lei stessa non sapeva dire se anche lei una notte non era stata rapita e mutilata da uno degli dèi, o se l’avessero magari scaraventata fuori dalla nave. Dopo il viaggio attraverso il mare non le era più possibile capire che cosa, nel sogno, sogno non fosse, e nella vita vita non fosse.
Il tempio degli dèi bianchi non era ancora finito, o forse per gli dèi bianchi la cerimonia consisteva nel costruire ininterrottamente il tempio senza finirlo mai. Ormai erano passati dei mesi da quando il suo marito bambino era morto, nessuno si interessava più all’india se non altri bambini che la rincorrevano per strada, lei sempre più lenta e appesantita, l’opposto di un serpente, pronta da un momento all’altro a dare alla luce l’altra bambina che finora era vissuta nella tenebra della sua pancia. Tornava nel tempio che gli dèi bianchi continuavano a costruire, e ripensava al marito che era morto nel cortile. I bambini cantavano.
Le avevano portato degli abiti uguali ai loro e le avevano messo al collo una collana con un uno di quei minuscoli uomini morti con cui cercavano di placare la sete di sangue delle loro mura, ma di là dal mare lei aveva imparato prima ancora di parlare che la sete delle mura, non importa chi sia a costruirle, se indio o dio, è senza fondo, e che tutto il sangue di tutti gli uomini e tutti gli dèi non basterebbe a darle pace.
Dietro l’altare si allungava un corridoio creato da uno degli stregoni degli dèi bianchi, ed era forse la stregoneria più terrificante che la bambina avesse mai visto, perché il corridoio ti si apriva davanti solo quando eri lontana da lui, ma quando ti ci avvicinavi si appiattiva fino a diventare poco meno di una piaga nella parete, e la bambina aveva provato molte volte, quando non c’erano dèi bianchi a fermarla, a correre più velocemente che poteva verso il corridoio per cercare di sorprenderlo e penetrare al suo interno. Era un corridoio a colonne, e la bambina sporgendosi e insieme appiattendosi lungo i bordi della parete cercava di indovinare cosa ci fosse dietro i primi spazi tra colonna e colonna, se un altro tempio, o magari un’altra bambina che come lei cercava di passare, e allora cercava di infilare le mani dietro la prima colonna, ma trovava lo spazio chiuso e muto, come se si cercasse di infilare le dita in bocca a una statua, perché il corridoio si era ormai richiuso sulla pelle della parete. La bambina allora provava ad appoggiare un orecchio accanto alla colonna o a bisbigliare qualcosa, se qualcuno dall’altra parte la stesse ascoltando. Una volta, prima di piegarsi in due per delle fitte alla pancia le era parso che sottilissime dita di ragno le accarezzassero il volto. Ormai non riusciva più a correre verso il corridoio e si accontentava di mettercisi davanti e di fissarlo il più a lungo possibile, come per inchiodare le pareti di quello stomaco di colonne d’oro che si apriva e richiudeva implacabile davanti a lei.
L’uomo rimpicciolito che le avevano messo al collo era stato inchiodato come un’iguana a delle assi di legno, e forse lo stavano preparando per mutilarlo e sistemargli rami e teste di serpente al posto delle braccia e dei piedi come avevano fatto con gli altri, ovunque era pieno di quei piccoli uomini inchiodati proprio come nei mercati che si tenevano di là dal mare, ma l’india non aveva mai visto nessuno mangiare altri uomini, nemmeno al mercato. Tutti quegli uomini venivano uccisi e rimpiccioliti per essere appesi e mutilati, ma benché avesse cercato in tutti i punti della città che era riuscita a raggiungere, da nessuna parte la bambina aveva potuto vedere le file di condannati e prigionieri pronte per essere inchiodate alle assi da iguana o i mucchi di corpi stesi a rinsecchire e di braccia e gambe amputate.
Il corridoio si chiudeva come una palpebra quando la bambina si avvicinava, e ogni volta che entrava nel tempio l’india sorvegliava attentamente gli dèi bianchi per vedere se uno di loro riusciva a scivolare tra le colonne per fuggire dalla città. O forse il corridoio era una prigione dove avevano chiuso suo marito, ingannandola sulla sua morte?
Era di notte che più di ogni altro momento il corridoio si allungava davanti a lei, perdendosi nella tenebra. E la notte era sempre più lunga al passare dei giorni, una notte come non ne aveva mai viste che ogni giorni finiva più tardi e ogni giorno cominciava prima, e sarebbe arrivato infine il momento in cui il giorno non sarebbe durato che un battito di ciglia e il freddo sarebbe stato perfetto come quello della morte, e il corridoio sarebbe rimasto aperto davanti a lei per sempre e lei non avrebbe mai più potuto scappare. La luce delle candele allungava le ombre tra le colonne, e l’india si accoccolava sulla panca cercando di assomigliare il più possibile a un mucchio di stracci perché non la vedessero e non la cacciassero via. Ma quando la notte il corridoio davanti a lei si spalancava e non sembrava più avere alcun fondo, la bambina aveva paura ad avvicinarsi a quelle colonne che tremavano alla luce delle candele e sembravano pronte a crollare da un momento all’altro o a spalancarsi come i denti di una vecchissima testa di biscia marina. Perciò non si avvicinava correndo, ma strisciava lentamente fino all’inizio della tenebra, ma ogni volta proprio quando stava per fare il primo passo una delle fiammelle si contorceva un po’ di più contro la parete e il corridoio tornava a sigillarsi.
La bambina non sapeva se erano state un sogno o no le braccia di dio bianco che una notte sulla nave l’avevano sollevata da dove si trovava insieme agli altri indios, sia i vivi che i morti, e per tutto il tempo era rimasta così immobile mentre il fiato del dio bianco e i suoi occhi traballanti di farfalla notturna le toglievano tutta l’aria dai polmoni, e anche quando poi il dio bianco l’aveva riportata tra i suoi lei era rimasta come morta, e solo all’ultimo momento, prima che lui si staccasse del tutto la lei, gli aveva preso una mano e gli aveva addentato un dito e aveva stretto con tutte le sue forze. Il dio invece di gridare si era messo a sibilare, forse preparandosi a strapparle la testa con un morso, ma lei aveva continuato a stringere fino a sentire colare il sangue caldo e nero del dio lungo il collo sottilissimo, e quando infine aveva sentito ballare nella propria bocca la punta del dito staccata le era sembrato di essere ormai immersa fino al collo in quel sangue nero e bollente mentre il dio si rintanava sibilando in una tenebra da cui non era più riapparso, perché il giorno dopo nessuno di loro era venuto per vendicarsi della mutilazione, e lei stessa non aveva potuto trovare da nessuna parte il dito mozzato del dio che la notte l’aveva violentata, e il suo sangue nero non era ormai più che uno sbaffo di polvere di farfalla che si sfa al primo soffio del mare mattutino.
Qualche notte prima che l’altra bambina venisse alla luce lei era seduta come quasi sempre in quel buio crescente e in quel gelo per lei inimmaginabile quando viveva di là dal mare; sedeva come sempre davanti alla gola spalancata del corridoio, e per la prima volta aveva visto nella penombra danzante delle fiammelle il dorso di una mano carezzare una delle colonne e sparire dietro di essa. Poi erano cominciate le fitte, e ancora una volta le era sembrato di annegare nel sangue. Era rimasta inchiodata lì, davanti al corridoio che si spalancava senza che lei potesse avvicinarsi di un centimetro, sibilando come il dio bianco quando lei gli aveva staccato un dito, e quando poi una delle donne velate che vivevano nel tempio l’aveva trovata e insieme a delle altre donne l’avevano sollevata per portarla di là, lei aveva avuto il tempo di vedere di tra lo spazio tra colonna e colonna spuntare il pallore di un sorriso, e una mano che con un dito la invitava a inoltrarsi nella tenebra… L’india aveva allungato debolmente un braccio verso la figura, mentre le donne la trasportavano via. Il volto aveva ribaltato indietro gli occhi in una risata senza suono e sparendo dietro la colonna aveva bisbigliato, Sarahsssssssssss…, il fruscio del nome che già evaporava in quello dei veli delle donne che la portavano in sacrestia, dove finalmente la piccola madre come liberata da un incantesimo aveva cominciato a piangere e gridare.
L’altra bambina venne alla luce senza una lacrima, gli occhi già aperti, con l’innaturalezza esilarante di un numero di magia, e pochi giorni dopo essere stata battezzata, con altrettanta bravura venne fatta sparire, non si venne mai a sapere come né da chi. Quell’inverno erano state viste passare carovane di zingari fuori dalla città, dissero le donne cercando di farsi capire dall’india affranta.
***
In realtà in quel giro di anni “zingaro” voleva dire tante cose. Il Nuovo Mondo aveva portato con sé i primi embrionali rioni di Schwarzschwarz, destinati con la loro mera esistenza a sconvolgere per sempre le teorie rinascimentali sull’assedio delle città, nonché qualsiasi tipo di idea si potesse avere in quei secoli lontani sul nomadismo. Come conquistare una città che è essa stessa una cavalleria di cavallini giocattolo pieni di soldati? I bambini di Schwazschwarz calavano a passo di danza trafiggendo con le loro lance e i loro campanellini i mercenari pallidi e puzzolenti del Moro, mentre Bramante veniva fatto strangolare in una delle oubliette del castello sforzesco con l’accusa di aver aperto con il finto coro della chiesa di san Satiro una prima breccia per la germinazione di quello che oggi è il Rione Scientifico del Distretto a Luci Rosse della periferia occidentale di Schwarzschwarz.
***
Su ciascuna facciata di uno dei rari fogli sopravvissuti del cosiddetto Codice Austroamazzonico di Leonardo da Vinci si possono ammirare due tra i più celebri disegni del Maestro: sul recto, il corpo mutilato dell’architetto assassinato, fatto esporre per ordine del Moro da una delle caditoie del castello sforzesco. Il torso di Bramante e i suoi arti strappati lasciati a pendergli accanto sembrano quasi dondolare fuori dalla pagina, e sono toccanti il gelo e la perfezione leonardesca nel cogliere ogni minuto dettaglio della rovina inflitta alla carne dagli elementi. Sul verso della pagina, la celebre Natività di Schwarzschwarz, una delle prime raffigurazioni europee di un nativo americano: una giovanissima india che allatta un neonato, lo sguardo rivolto all’osservatore in una torsione che attraverso i secoli sembra voler tendere una mano allo spirito di Gauguin di Modigliani. Del piccolo non si vede che la bocca attaccata al seno, il resto del volto nascosto da un piccolo crocifisso nero che pende dal collo della madre e scende ad appoggiarsi con naturalezza e rigidità sul volto del bambino quasi come un marchio alieno. Tra i panneggi in cui il corpo della madre e del bambino si fondono si è recentemente scoperta la cancellatura della mano di uomo che sembra voler cullare il piccolo: ma già prima di cancellarlo Leonardo aveva lasciato incompleto il disegno della mano, monca dell’ultimo dito.
Tra gli altri disegni del Codice Austroamazzonico, notevoli gli schizzi delle celebri “catapulte ottiche” progettate da Leonardo per far fronte ai primi cantieri di quelli che oggi sono tristemente noti come “labirinti”. Come molte macchine di Leonardo, anche le catapulte ottiche sono oggetti la cui bellezza è indissolubilmente legata alla loro impossibilità per i tempi in cui vennero immaginate, fattasi poi progressivamente inutilità nel trascorrere dei secoli. Allo stesso modo sono stati dimenticati, e con ciò salvati dall’orrore della Storia, quei lontani navigatori fenici e greci che per primi giunsero, e sia pure, chissà, come cadaveri trasportati dai loro scafi dipinti, sulle coste americane. È stato in ogni caso tramite un dispositivo di concezione del tutto analoga ad una delle “catapulte” leonardesche che nel 21–– l’equipe di Tomaš Brušek ha potuto individuare e finalmente sigillare, tra la prima e la seconda colonna apparente del finto coro di Bramante, uno dei corridoi ottici di accesso al rione di Newton, primo avamposto della criptometropoli di Waltzwaltz.
***
Riassunto delle puntate parallele
I: In un aspro e stravinskyiano polimetro di ottave cavalleresche, capitoli in terza rima, sestine, collane di madrigali, sestine, ballate e ballatette e distici e disticazzi e chi più ne ha, viene dato conto delle divergenti peripezie tardorinascimentali della piccola Sarahs e della sua quasi altrettanto piccola madre amazzonica, la Truut. Catturata dalla mano bianca dell’architetto infiltratasi per traverso i secoli di tra le colonne del finto coro di Bramante presso la chiesa di san Satiro, la bambina srotola per intero il repertorio dell’eroina cavalleresca, soltanto con la frenesia e l’ingordigia di una bambola di caucciù messa in mano a un bambino: cioè sempre il presidente architetto, che come una tremenda madre ubriaca di LSD interviene di continuo nell’interminabile arazzo di rapimenti, infanzie zingare e fuorilegge, salvataggi e/o stragi di principini, di briganti, di arcivescovi, decapitazioni di sceriffi corrotti, suore pettegole, paggetti assolutamente innocenti e ignari, e poi duelli a destra e sinistra e viaggi di qua e di là dal mare il tutto naturalmente sempre en travesti ora come pirata ora come mozzo ora come commodoro con tanto di baffoni finti e stivaloni grandi il doppio dei piedini della bambina. E intorno a lei tutto un circo rincretinito di figuri più o meno storici che si agitano variopinti come girandole di carta in una fiera di paese. Proprio quando tutta la faccenda pare sul punto di collassare in un teatrino di burattini allestito impilando una torre di cuscinoni sul divano del salotto, fa il suo ingresso ossia torna in scena la Truut, della quale Sarahs (che siamo costretti ad abbandonare mentre langue nella segreta di un castello sotto assedio) nulla sa.
–––
II: Quanto i primi passi di Sarahs hanno la leggerezza suicida di una lucertola tropicale che corre rimbalzando sul pelo dell’acqua, tanto la Truut appare immobile, perennemente sprofondata nelle ramificazioni del passato e del futuro, proprio come altrui. Come in un monologo borbottato nel dormiveglia, veniamo informati delle vicissitudini del suo villaggio natio a partire dall’arrivo dei primi europei, e di una certa poltiglia di liane biascicando la quale gli abitanti del villaggio ricevono quotidianamente visioni che occupano tutta la frastagliata gamma che va dal faceto all’infernale passando per il mistico e il profetico. Entrano in scena, con un alquanto importuno salto in avanti di più di mezzo millennio, diciamo più un finto capitombolo da vaudeville, Giacomo Sommariva e il suo assistente Giorgio Valmarana, impegnati nel laborioso studio delle leggi delle civiltà precolombiane, studio che si inserisce nella colossale impresa di Sommariva, la Storia universale e comparata delle attenuanti giuridiche ai delitti di sangue.
–––
III: Digressione sulla vita di Valmarana come aiutante del famigerato scienziato pazzo Tomaš Brušek. Non è dato sapere se si tratta di un’epoca precedente o successiva all’incontro di Valmarana con Sommariva. Fugace e silenziosa apparizione della signora Valmarana in forma di catalogo delle innumerevoli fotografie di lei fin da quando era bambina, fotografie incorniciate e disseminate in vari punti della casa dei genitori di lei, scomparsi entrambi durante uno degli “attentati” dei treni “FIAT”.
–––
IV: Contestualizzazione storico-antropologica. Dettagliate e documentate genealogie e curricula dei due gruppi terroristici degli Arlecchini e dei Nerini, le cui talvolta concorrenti talaltra coordinate sequenze di attentati fanno da efferato e dissonante bordone per uno svelto sommario della storia planetaria a partire dalla prima insorgenza dei rioni di Schwarzschwarz ai confini dell’allora Repubblica di Venezia, passando per la quasi contemporanea fondazione della criptometropoli di Waltzwaltz concomitante ai primi insediamenti portoghesi sul Ciliwung. Entra in scena Lapin, in un elenco dei principali cronisti riguardo la fantasmatica storia delle due città.
–––
V: Continua la contestualizzazione storico-antropologica. Salto a piè pari al conflitto austroamazzonico tutt’ora in corso tra Schwarzschwarz e Waltzwaltz, ormai fossilizzatesi in imperi. Sezione illustrata con mappe colorate trasparenti sovrapponibili che permettono di confrontare la pianta di Venezia e Jakarta con i due evanescenti e metastatici reticoli urbanistici di Schwarzschwarz e Waltzwaltz. Comparsa di Miloš: un biondino smilzo come un fiammifero, occhi di un azzurro quasi trasparente. Durante un viaggio in pullman in compagnia di una nonna angelicata che di quando in quando gli allunga dei pezzetti di cioccolata bianca che lui si lascia quasi del sciogliere in mano prima di infilarseli in bocca, il ragazzino fa un elaborato e ragionato elenco delle nuove specie di insetti che si sono manifestate nei sobborghi delle due città nemiche. La puntata finisce con il pullman che rimane a secco della benzina nel mezzo di un bosco, forse boemo, forse irlandese, comunque fitto.
–––
VI: Abbandonati Miloš e la nonna in mezzo al bosco, si riprende la contestualizzazione virando alle tecnologie, civili come terroristiche. Tra le più appariscenti NITA™, un videogioco ideato da quello stesso Tomaš Brušek per cui Valmarana lavorava in qualità di biochimico. Il videogioco, che dovrebbe trasportare il giocatore nel mondo medievale di Robin Hood, ha avuto una serie di malfunzionamenti che nei casi più gravi hanno compromesso forse irreparabilmente le capacità cognitive di alcuni giocatori invitati a testarlo. Compare Nita, coagulazione imprevista del videogioco in una sorta di virus/personaggio che in forma di damina silenziosa si insedia nell’inconscio dei giocatori ossia delle loro Psyche®, con il che si passa direttamente a
–––
VII: Descrizione dettagliata dello sviluppo e del funzionamento (con tanto di manuali d’istruzioni e tracciati cibernetici) del software Psyche® , in grado di creare uno specchio più o meno fedele, più o meno potenziabile (a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto) dell’utente. Esplorazione delle varie e più o meno ovvie implicazioni e ramificazioni narrativo-metafisiche della faccenda, con sezione aperta e in continuo sviluppo al link (…omissis…).
–––
VIII: Curva a gomito: ricompaiono, ma in qualità di membri del comitato scientifico destinato alla preparazione del videogioco NITA™ prima e alla preparazione della difesa per il processo poi, Sommariva e il fido Valmarana. Durante la laboriosa e intricata fase di censimento dell’imprevista popolazione di personaggi manifestatasi nel videogioco (censimento il cui dettagliato resoconto viene sveltito attraverso l’uso di numerose illustrazioni sul modello dei tarocchi marsigliesi dei vari personaggi in questione –– l’edizione di lusso prevede illustrazioni adesive trasparenti da attaccare e staccare a proprio piacimento su qualsiasi superficie) i due incappano in una «azteca decrepita» nota con il nome di Truut: nientemeno.
–––
IX: Parentetica, apparentemente solo informativa sui remoti albori della fabbrica di giocattoli produttrice del videogioco NITA™, risalenti al XVI secolo quando un tal Tomás Adra apriva a Lisbona una stamperia che presto si sarebbe specializzata nella produzione carte da gioco. Cenni alle attuali ramificazioni internazionali, addentellati politici e tecnocratici dell’attuale multinazionale del giocattolo. Comparsa dei personaggi di Decor, impiegato nella mai dismessa e gloriosa sezione carte da gioco della multinazionale, e di Carlos Adra, attualmente ricercato dalle polizie di qua e di là dell’oceano, anche lui in gioventù impiegato presso lo stesso reparto di Decor.
–––
XI: Riprende l’indiavolato polimetro di Sarahs, ora impegnata nell’avventurosa risalita di un fiume africano che potrebbe essere il Nilo quanto il Congo, risalita che la mette in contatto con una sequenza gulliveriana di improbabili popolazioni dagli usi e dalle conformazioni più varie e bizzarre, popolazioni tutte per solito sorde a ogni forma di umana simpatia o pietà. Suo (di Sarahs) coinvolgimento in scene di cannibalismo e magia nera. Elenco interminabile dei ninnoli accumulati al termine del viaggio.
–––
XII: Mesto e impantanato resoconto degli anni passati dalla Truut sotto la tutela delle suore che gravitavano intorno alla chiesa di san Satiro agli inizi del ’500. Solitudine e disperazione azteche stese come uno strato di terra verminosa sui successivi trent’anni di vita della donna, in capo ai quali riappare all’improvviso il presidente architetto, pallido e tremante come una luna massenetica, e di aspetto miracolosamente giovane. Con occhi liquefatti dalla follia, l’uomo prende per mano la Truut e la conduce davanti al finto coro di Bramante. I due spariscono tra la seconda e la terza finta colonna di destra sotto lo sguardo esterrefatto di una delle converse, che il giorno dopo viene trovata impiccata in sagrestia con le mani legate dietro la schiena.
–––
XIII: Trasportata nel tempo presente dall’incantesimo del presidente architetto e da lui immediatamente quanto inspiegabilmente abbandonata, la Truut si isola dal resto del mondo trovando rifugio in quella stessa pressoché invariata chiesa di san Satiro da cui è stata rapita. Brevi osservazioni corredate di esempi e note a margine della difficoltà della donna a comunicare in una lingua improvvisamente vecchia di secoli, e della quale del resto non conosceva che i rudimenti. Comparsa di don Giorgio Giorgio, parroco in odore di scomunica presso la chiesa di san Satiro; il sacerdote permette alla Truut di sistemarsi in una delle stanze del Pio Istituto di san Satiro per l’Istruzione della Gioventù, al momento in fase di costruzione. Lì la donna stringe una sempre più affettuosa amicizia con una donna a lei coetanea nella quale dopo un po’ riconosciamo l’angelicata nonna di Miloš, prima ancora che questi nascesse.
–––
XIV: Excursus burlesco su san Satiro in forma di racconto di don Giorgio ai propri giovini fedeli durante il catechismo: delle innominabili frustrazioni di Satiro per essere fratello (maggiore!) del celebre Ambrogio: e dei suoi quattro discepoli uno più squinternato dell’altro: e del rapporto contrastato con la madre che aveva voluto dargli un nome così pagano: e dei suoi miracoli maldestri e sovente non richiesti: nonché delle sue parabole che non avevano né capo né coda e lasciavano perplessi e confusi tutti i fedeli, etc. etc., così via menestrellando. Sua (di san Satiro) simpatia guascona una volta entrato nell’aldilà; sue amicizie e frequentazioni nell’ambigua cerchia dei santi di second’ordine che sono sempre i più mattacchioni etc. etc., persino i diavoli non disdegnano la compagnia di quel bislacco, e si mettono lì con una mano appoggiata allo stipite dell’inferno a chiacchierare dei bei tempi in cui si andava tutti d’amore e d’accordo prima che il Triplo Faccia di Culo etc. etc., a volte con la scusa del nome Satiro va persino a fare dei picnic sull’Olimpo, e lì è tutta un’altra musica etc. etc. e l’unica chiesa al mondo con il suo nome è questa qui miei cari, è un po’ pochino, sì, ma Satiro ci conosce sì ci conosce tutti uno per uno e ascolta davvero davvero tutte le nostre preghiere anche le più stupide perché è un po’ stupido anche lui, e tutte le sere ci viene a trovare e ci fa i suoi piccoli miracoli e sono miracoli da niente è vero ma sono miracoli tutti per noi etc. etc. etc…. La balzana lezione di catechismo viene registrata e inviata a chi di dovere da un non meglio precisato agente di non si sa quale criptometropoli.
–––
XV: Certo a propria volta scaraventata lì da uno degli incantesimi del presidente, Sarahs entra nella vita di Miloš saltando dal ramo di una quercia sopra il tetto del pullman rimasto senza benzina in mezzo al nulla. Miloš sente la furia dei piccoli piedi nudi attraversare la lamiera sopra la sua testa, poi sull’erba vede scivolare Sarahs, una collana di ossicini forse umani al collo e una corona di margherite sulla testa. La ragazzina cade con una capriola, si rialza e guarda Miloš che per vederla più da vicino ha appiccicato la faccia al vetro del finestrino. Si avvicina anche lei la riflessione parziale del vetro le riflette il proprio stesso volto sovrapposto a quello del biondino inebetito che la fissa. Dopo essere restata qualche secondo così, la bambina della foresta sputa contro il finestrino proprio all’altezza del volto di Miloš e svanisce in un intrico botticelliano di vegetazione.
–––
XVI: Senza soluzione di continuità, la vegetazione in cui svanisce Sarahs diventa la foresta centroamericana della Truut bambina. Rieccoci a cavallo tra XV e XVI sec. Lei e gli abitanti del villaggio stanno ancora una volta per essere catturati dagli europei. Ancora una volta attraverseranno l’oceano e ancora una volta uno dopo l’altro moriranno, tutti eccetto la bambina e suo marito. Ma non è ancora successo. La bambina e il bambino camminano insieme, masticando un pezzetto di liana. Lungo uno dei tronchi vedono strisciare una specie di grosso ragno bianco: no, è una mano a cui manca la punta del dito mignolo. La faccia molliccia del presidente scivola di sotto i petali di un gigantesco fiore giallo. Sorride ai due bambini, pietrificata dalla follia. Strida di scimmie e pappagalli, strida di tutta la foresta mentre il presidente massacra il bambino.
–––
XVII: Sulla nave che sta attraversando l’oceano, la Truut apre gli occhi. Le costellazioni le scorrono sopra la testa come un vecchio mazzo di carte da gioco portoghesi. È sola, nient’altro che lo scricchiolio del mare contro la nave a farle compagnia.
–––
XVIII: Il presidente architetto corre nella giungla azteca della fine del ’400. Corre fino a scorticarsi i piedi, fino a che le braccia e le gambe e il petto e gli occhi non gli cominciano a sanguinare, corre fino a diventare lui stesso un pupazzo di sangue.
–––
XIX: Di nuovo nella chiesa di san Satiro. Sommariva e Valmarana esaminano centimetro dopo centimetro l’angolo formato tra il pavimento e la sezione tra la seconda e la terza colonna di destra del finto coro di Bramante. Torcendosi all’interno del riflesso lenticolare prodotto dal proprio “periscopio” portatile per “labirinti”, Valmarana riesce a infilare una mano all’esterno del corridoio. Quando la ritira, tiene in mano un piccolo ciondolo di latta a forma di mezzaluna allungata. Quando Valmarana guarda il proprio riflesso dentro la superficie del pezzetto di latta, per l’orrore e la meraviglia il ciondolo quasi gli cade di mano.
–––
XX: Valmarana è solo, in riva al lago. Da un taschino della giacca, tira fuori il ciondolo di latta. Lo soppesa un po’ nella mano, poi lo lancia in acqua. Dopo un po’ fruga nello stesso taschino. Ne tira fuori un secondo ciondolo identico al primo. Questa volta prima di lanciarlo in acqua lo morde forte, lasciandogli l’impronta dei molari. Quando dopo il lancio torna a frugarsi nel taschino, il ciondolo che ne estrae ha lo stesso identico marchio di quello che ha lanciato. Valmarana lo lancia di nuovo nell’acqua, poi sente la mano di un uomo sulla spalla.
“Abracadabra, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!”
–––
XXI: Di nuovo sulla riva del lago precolombiano, di nuovo la Truut e il suo marito bambino. Camminano insieme lungo la riva tenendosi per mano, fino a che un sentiero li fa deviare verso l’altura e verso il loro villaggio. Arrivati in cima, come sempre si voltano a guardare la sagoma del lago sotto di loro, scura e curva come quella di un falcetto sacrificale.
–––
XXII: Morte di Miloš. Dopo aver riconosciuto la figura dell’architetto in uno spezzone di un film clandestino di Adra dove compare anche Sarahs, Miloš inizia un lungo e maldestro inseguimento attraverso le locations ossia che nel caso di Adra è letteralmente lo stesso scene del delitto a lui (Miloš) note, determinato ad uccidere lui (Adra) e l’architetto. Trascorrono così una ventina d’anni, senza alcun risultato notevole se non un nutrito taccuino di appunti su Adra e sui mille pittoreschi ciarlatani che periodicamente abbordano Miloš giurandogli di avere incontrato il cineasta assassino. Tra questi contiamo anche Valmarana, ormai ridotto in miseria ma ancora capace di inquijottire l’animo di chiunque abbia l’imprudenza di prestargli orecchio. Seguendo il filo dei suoi ingarbugliatissimi racconti Miloš si ritrova a rimbalzare con frenesia di pallina da flipper tra le più tetre periferie di mezzo mondo, e la parodia del film di spionaggio che ne esce potrebbe fosse consolare Miloš del proprio fallimento, non fosse per il pensiero di Sarahs in quel filmato (che Miloš non riesce mai a vedere per intero), e per il costante logorarsi delle sue condizioni di salute. Infine, superati da poco i cinquant’anni e diffusasi nel frattempo la notizia del ritrovamento del cadavere di Adra su una panchina di Riva del Garda, nel nord Italia, Miloš abbandona le speranze. Poi un giorno, trascinandosi contro il vento di piazza san Marco a Venezia, Miloš risente vicinissima a sé la risata di gabbiano dell’architetto. Il vetro del puro terrore e della pura rabbia scheletrificano Miloš in un lentissimo infarto circondato da cartolineschi piccioni in volo, infarto durante il quale il giovane, soffiando di dolore, riesce a indovinare la sagoma dell’architetto su uno dei vaporetti che ha ormai levato gli ormeggi e sta prendendo il largo. L’architetto, che pare non essere invecchiato di un solo anno, gli fa cenno di guardarsi nelle tasche. La vista che sta ormai sprofondando nella carne morente, Miloš legge i frammenti dell’ultima lettera che chissà come l’architetto è riuscito a infilargli in una delle tasche più interne. È, come tutte le altre lettere dell’architetto, incomprensibile. L’architetto spiega a Miloš che il prezzo di ogni viaggio è un mondo sempre più sbiadito e confuso, e che per lui (l’architetto) che ha passato ormai giorni e giorni dentro e fuori da quelle scatole di latta cercando di ritrovare… è come in quelle canzonette sentimentali in cui un’amante dice all’altro di avere l’impressione di averlo già incontrato, ma chissà dove, ma chissa quando… a furia di viaggiare ormai, ho attraversato… io sono… ancora, e ancora, e ancora… Miloš molla l’inutile pezzo di carta e si accascia a terra, il suo cadavere presto confuso e ammucchiato con quelli dei gondolieri, degli accattoni e di tutti gli altri viaggiatori, caduti sotto le prime cannonate delle truppe di Schwarzschwarz che proprio in quel momento hanno dato inizio all’occupazione di Venezia.
EPILOGO
Fuga notturna di Sarahs attraverso gli alberi. Attratta da un improvviso fetore di animali, la bambina cambia direzione. Si ritrova in una radura. Senza troppa sorpresa, sente il ronfo caldo di una pantera a pochi passi da lei. Poi dei sospiri che si direbbero umani, non piovessero dalle stelle. Un circo itinerante sta facendo sosta lì con i suoi pagliacci e le sue bestie, le roulotte e i furgoni sparsi sull’erba grigia. I sospiri vengono da un ramo sopra la sua testa. C’è qualcuno appollaiato lassù a piangere. La bambina lo chiama con un debole fischio di merla, due note discendenti, fuì fiù… L’estraneo si lascia scivolare con un delicato movimento di foglia morta da uno dei rami più alti. Quando tocca terra, le lacrime sono scomparse. Per un po’ l’uomo e la bambina restano in piedi uno di fronte all’altra in silenzio.
– Sei un acrobata?
Gli occhi della bambina si accendono quasi di ferocia quando l’uomo si toglie di dosso la giacca di un logoro frac nero, offrendogliela contro il gelo crescente del bosco.

 Presiden arsitek/ 49 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 49 - Angelo Angera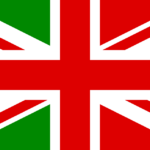 La Gipsi/ 6 - Alberto Volpi
La Gipsi/ 6 - Alberto Volpi Presiden arsitek/ 31 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 31 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 37 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 37 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 45
Presiden arsitek/ 45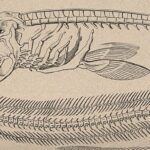 Presiden arsitek/ 58
Presiden arsitek/ 58 L’arte di travisare Agamben
L’arte di travisare Agamben Presiden arsitek/ 59
Presiden arsitek/ 59





















