
Sua madre non avrebbe capito. Se l’avesse vista dimettersi senza aver prima trovato un altro lavoro – e con quale determinazione, poi, si era dimessa – le avrebbe detto che sarebbe sempre rimasta una bambina, che non sarebbe mai cresciuta. Il che, trattandosi di lei, poteva anche suonare come un augurio. A scanso di equivoci, due mesi prima l’aveva avvisata, le aveva annunciato che era prevista una riduzione del personale da cui nemmeno lei poteva dirsi completamente al sicuro (aveva preparato la storia circostanziando di dettagli una fase di crisi). E poi, purtroppo, era capitato: «Ma non me la sono presa più di tanto, – le aveva detto – anzi, guarda, forse è meglio così». Tortuosa come giustificazione, ma non propriamente una menzogna. Le difficoltà economiche, in un mercato sempre incerto, erano effettive. E anche se l’economia non c’entrava così tanto, non era forse vera la crisi? Sua madre aveva scosso la testa. Dopo la caduta, doveva andare da lei un paio d’ore ogni giorno. Faceva sempre più fatica.
Caricata la lavastoviglie, guardava dal balcone verso il campo da calcio.
Per la prima volta poteva dire di vivere le conseguenze di una decisione improvvisa (solo secondo Lucia, la sua amica assistente di comunità, viveva i primi effetti di una ritrovata libertà di movimento. Ma di euforia ce n’era poca).
In sintesi, Alberto era arrivato in azienda quindici mesi prima. Aveva trentacinque anni. Era entrato di corsa nell’ufficio a fianco – da Cinzia, che lo conosceva perché avevano frequentato la stessa palestra – irritato per un guasto alla Golf: «Non bastavano questa mattina le analisi del sangue?». Lei, non vista, aveva sorriso. Aveva quel modo di mostrare la sua fragilità che lo colpiva: un po’ impulsivo, un’espressione rotonda. Per lei aveva significato molto lasciarsi desiderare, delegare a lui il gioco della seduzione, perché in effetti, per quanto ne fosse rimasta subito colpita, era stato lui ad avvicinarla. Alberto veniva da un’esperienza come impiegato nel giornale «Il Quotidiano Definitivo»; ogni tanto si era spinto a respirare l’aria della redazione, ma poco oltre. Poi era arrivato da loro. Un carattere apparentemente avventuroso, più del suo, che pure sapeva affrontare le avversità (ancora una volta se lo doveva riconoscere). Avevano incominciato a uscire ed erano finiti nel suo appartamento: beh, lo aveva sorpreso, era stato più appagante di quanto avesse sperato, anche se nell’immaginazione aveva sperato di tutto. E, altrettanto sorprendentemente, era durata, quasi otto mesi, l’ultima parte dei quali trascorsa in una sorta di convivenza a casa di lui.
Ridisponeva le mollette sullo stendibiancheria.
Ma l’aveva tradita. Lei – davanti a scongiuri umilianti – aveva provato a perdonarlo: non era servito. Gli aveva dato un preavviso più breve di quello annunciato a sua madre, una settimana, poi aveva fatto le valigie. Col passare dei mesi era diventato fatuo, inaffidabile, ma forse la sua radice non era cambiata; forse un anno prima, abbagliata da tanta attenzione inedita, non aveva saputo coglierlo per intero. Non era neanche il tradimento in sé a ferirla; o meglio, per lei il tradimento assumeva un significato peculiare (non ce l’aveva con Sonia, se non superficialmente). La questione aveva a che fare con la vergogna di sentirsi preferire un’altra proprio nel momento stesso in cui lui le ripeteva di amarla. L’aveva sostituita proprio mentre le dichiarava di averla scelta come sola e unica, e ora sentiva addosso tutto questo come se all’improvviso un gruppo di sconosciuti l’avesse rapita e immersa in un barile di grasso di balena per poi esporla allo sguardo degli altri.
Dal punto di vista professionale era già sfiduciata – in ambito dirigenziale le cose non andavano poi così bene come si diceva – ma per molti colleghi il gesto poteva somigliare a un colpo di testa, perché secondo l’opinione comune lì dentro non solo era benvoluta ma, col suo curriculum, avrebbe potuto ambire a una carriera di primo piano. Sua madre non mancava di ripeterglielo.
2.
Due mesi dopo, almeno un passo avanti l’aveva fatto. Se emotivamente si sentiva ancora «come una pigna in mezzo al mare» – come aveva detto ridendo a Lucia – aveva però trovato un impiego provvisorio, inferiore ai suoi standard, una supplenza di tre mesi nel Centro di ricerca Rosser, in amministrazione. Tutto bene. Del resto, un impiego in un ambiente dove non poteva dirsi conosciuta era una scelta ragionevole, un posto in cui mettere a frutto alcune competenze, un modo per sostentarsi e per riflettere con calma sull’avvenire. Col nuovo orario, alzandosi un po’ più tardi, girava pigramente per la casa, si fermava a leggere le notizie sul tablet in piedi, col caffè in mano. Ogni tanto, ma non troppo spesso, andava al lavoro con la giacca e i jeans (anche se sapeva di non dover cedere al confort: «In un attimo ti ritrovi in pigiama»). D’altra parte, per quanto la procedura da seguire nelle pratiche del nuovo impiego fosse rigida, non la impensieriva. Anzi, pur non osando sussurrarlo alle colleghe, ora lavorava con impegno non comparabile a quello del lavoro precedente. Lo stipendio era onesto. In ufficio, restava sulle sue. «Riservata, ma simpatica» aveva detto Agata, la sua collega di scrivania, parlando al telefono con un’amica. Qualcuno aveva sparso la voce che provenisse da un’azienda in cui aveva ricoperto un ruolo di maggiore responsabilità. «Eppure ha un così bel modo di fare».
Cinzia glielo aveva detto: «Tu non hai nemmeno una vaga idea di come lavori la gente là fuori; se lavorerai la metà di quello che facevi qui, passerai per una che vuol fare bella figura».
Aveva fatto qualche giro negli uffici. La bianca atmosfera dell’amministrazione nel centro di ricerca ai suoi occhi appariva uno spazio beato, lontano dalla scomposta durezza delle transazioni quotidiane, dai ritardi nei pagamenti, dalle trattative e dalle liti coi fornitori sull’orlo del fallimento: quasi un piccolo cosmo da tavola che, nei suoi conflitti e nei suoi sgarbi minimi e crudeli, appariva preda di un maleficio che lo induceva a vivere di una violenza tutta simbolica. A ben vedere – se ne era accorta in fretta – nel giro di un paio di mesi tutti là dentro si abituavano a parlare di quel nulla materiale (ma di quella dura sostanza reputazionale) di cui vivevano i professori universitari e della quale gli impiegati erano colpiti di riflesso tanto che in una scala ideale della Pubblica Amministrazione alcuni di loro si sentivano immotivatamente superiori agli addetti all’anagrafe comunale. A volte, mentre percorreva il corridoio verso il fotocopiatore, sorrideva pensando di essere finita in un parco a tema, una sorta di Italia in miniatura nella quale era costretta a girare fra i monumenti in scala ridotta. I vari colleghi erano convinti di vivere di fronte al Colosseo, o alla Fontana di Trevi. Insomma, non ci si poteva stare bene, ma in fondo neanche così male.
La sera, un paio di volte in settimana andava a correre al parco. E aveva resistito all’impulso improvviso di comprarsi un golden retriever. Sua madre le aveva detto di non volerne sapere (proprio per questo a un certo punto le si era presentata come una soluzione possibile). Ma, va da sé, non poteva risolvere un problema creandosene un altro. A cena tornavano le immagini di Alberto e la tentazione dei bilanci; cercava di respingere la conclusione di non aver costruito nulla di durevole.
Era uscita dal bagno con indosso solo gli slip neri, l’asciugamano legato in testa. E ora, mentre mangiava una prugna, scorreva sul computer le piattaforme a cui si era iscritta per valutare possibili offerte di lavoro.
«Il fatto è che tu – sempre Cinzia, in vena di raccomandazioni – dovresti farti mandare delle foto. Insomma, non puoi mica presentarti ai colloqui senza prima aver visto le loro sedi? A quel punto dovresti farti spedire anche le foto del personale, valutare se ci sia qualcuno di interessante. Se fai un colloquio via Zoom, inquadrano sempre quei fondali neutri: non riesci mai a fartene un’idea, sempre che non inseriscano lo sfondo dell’applicazione (il peggiore di tutti è quello con le palme). Tu, cara, tutto sei fuorché neutra».
A dire il vero, il primo colloquio l’aveva già sostenuto, con la ditta di import/export Aux Terres proprio via Zoom. Arie da impresa affermata. Era andato bene, ma era stata lei a chiedere tempo e poi aveva lasciato perdere. Inutile lanciarsi in un’impresa commerciale come quella, passare il tempo a valutare i margini settimanali, controllando gli indici in tempo reale. Questa volta voleva andarci piano, evitare di tuffarsi completamente nel lavoro. O per meglio dire, sapendo che l’avrebbe fatto comunque perché era portata a farlo, voleva almeno trovare un settore dove in teoria, idealmente, sarebbe stata contenta di lavorare. Forse era un’illusione, ma sentiva che era tempo di provarci. Voleva però evitare il ricatto di un lavoro che, con la scusa del fare del bene, non aveva né vincoli, né controlli. Quindi, in linea di principio, niente terzo settore. Ma certo non poteva metterci troppo.
Mentre scorreva i link, a sorpresa aveva sentito crescere senza motivo il desiderio. Quasi una novità. Non pensava tanto ad Alberto, ma a Riccardo, il suo ragazzo ai tempi del master, una passione senza problemi legati al lavoro, né a complicazioni di carriera.
3.
«Mi senti? Come è andata oggi?»
«Mah, ero stufa. Ho fatto un giro fino a trovare Marcella, per fare due passi; poi l’ho accompagnata a fare la spesa. Le ho dato una mano a portare le borse a casa (sai che fa fatica a camminare). Si lamenta sempre, ma d’altra parte gliel’ho anche detto, che vita fai? Non puoi mica restare sempre chiusa in casa ad assistere Sergio? Dice che ha bisogno, il che è vero, ma lei non è più in grado di fare niente e bisogna pensare che anche lei ha la sua età».
«Pensi che sia stanca?»
«Ma no, è che non riesce più a fare niente perché non va più in giro. Gliel’ ho detto. Alla sua età deve stare attenta. Deve camminare, deve pensare a se stessa. E se lui brontola, deve lasciarlo brontolare».
«Siete state fuori tanto?»
«No, sai che poi lei vuole rientrare subito a casa. Ce n’è voluta perché andassimo almeno a bere un caffè da Ranieri. Comunque, bene. E tu?»
«Beh, comincio a capire meglio il lavoro. Ad esempio, …»
«Poi Marcella non è mica convinta, eh, torna sempre indietro sulle sue decisioni. Ogni cosa è una pena. Oggi ad esempio doveva prendersi una maglia, poi era indecisa sul colore. Prenderne due costava troppo; allora alla fine si è convinta per quella verde ma solo con la possibilità – eventualmente – di farsela cambiare».
«Beh, almeno se l’è presa».
«Sì, ma quanto ci è voluto. Secondo me anche la commessa si è stufata, a un certo punto. Continuava a guardarmi. Ad ogni modo, che vuoi farci, è fatta così. Solo che la prossima volta non so se l’accompagno. A proposito, tu stai bene?»
«Sì».
«D’altra parte, Marcella o no, almeno ho fatto un giro. Questa mattina non ci speravo, tirava un vento che non si riusciva neanche a stare in piedi. Dovevi vederlo. In fin dei conti ho fatto bene. Poi lei è ridicola, che ci vuoi fare? Adesso stavo cercando un film per questa sera, ma in televisione non c’è niente. La prossima volta mi devi mettere a posto questo telefono perché continua a suonare; continuano a mandarmi offerte di ogni tipo. Adesso è mezzo scarico; anzi, guarda, lo riattacco subito».
4.
«Io mi dico che dovremmo puntare di più su di noi, farci valere». Cinzia era strepitosamente vitale. Si versò ancora del vino, poi riprese: «Insomma, guardaci: è un dato di fatto, siamo uno schianto. Ma tu alla fine ci vieni o no alla festa del pensionamento di Ferruccio? Ci sarà un sacco di gente. Guarda che si fa al Borgogna, mica in azienda?»
«No. Credo di no. Capirà, gli manderò due righe».
«Però dovresti cominciare a prendere un’altra piega. Il tempo passa e non avrai mica qui tua madre per sempre, devi pensare a te stessa».
«Sì, hai ragione. Ci sto provando».
A dire il vero, per quanto sua madre non fosse peggiorata, la certezza che non sarebbe rimasta con lei per sempre, più che una constatazione, assumeva i tratti di una realtà dai contorni profondamente ambigui, che non somigliava né a una liberazione, né al breve conforto di una presenza familiare a cui comunque si sentiva vicina, tanto che, confondendo i piani della coscienza, questa certezza si riduceva in fondo a ciò che di lei portava in sé, alla sola immagine interiore. Sentì d’un tratto con precisione che proprio per questo, per quella vitalità che a sua madre non era mai venuta meno, neppure negli ultimi mesi, avrebbe dovuto dare più credito agli incoraggiamenti di Cinzia. E che anche la realtà materiale poteva tornare a fornire stimoli inconsueti, senza per forza corrispondere alle sue incertezze.
«No, alla festa di sabato non vengo, ma dato che non sei mai a corto di programmi, sono pronta ad accogliere un’altra proposta».
Cinzia sorrise.
«Te ne offro una sensazionale, e non accetto un altro no. Domani andiamo a vedere la presentazione di una mostra di scultura; mi tocca perché mia sorella Paola è nell’Associazione Prospettive che fa questa cosa per i piccoli comuni, da qualche parte sul Garda. Poi andiamo a cena. Sta tranquilla che dell’azienda non ci sarà nessuno».
«No, dai. Lo sai che queste cose sono sempre una rottura».
«Sì, ma non hai alternative, e ci sarà gente perché Paola mi ha detto che è una mostra collettiva, quindi almeno i parenti di chi espone ci saranno di sicuro».
In effetti, sulla carta la mostra sembrava così priva di interesse che poteva rivelarsi un’idea vincente. Si era accorta che spostarsi in un ambiente diverso spingeva i suoi sensi a rinfrancarsi: affollandosi l’un l’altra, anche le sollecitazioni di un quartiere sconosciuto, perfino di un piazzale grigio, agivano su di lei quanto una camminata su un sentiero di montagna; le insegne, i lampioni, i tavoli dei bar, i cassonetti dei rifiuti garantivano uno spazio e un tempo poco noti, offrendo insieme un’onesta illusione di continuità, di durata. In quel momento le importava solo degli oggetti, non tanto di ciò a cui questi potevano alludere, come il piccolo borgo ospitale e confortevole entrato da poco nei borghi più belli d’Italia. Figuriamoci l’aggiornamento culturale. Cercava l’incanto neanche tanto dimesso delle realtà minime: una tazza di tè, il cucchiaio sul piatto, una sedia imbottita, il caffè. D’accordo, potevano innescare ricordi del passato – evitava ancora di percorrere le strade abituali – ma allo stesso tempo aprivano a nuove e prepotenti intuizioni. Ma niente diario col lucchetto, ciabatte di lana, auricolari col filo, plaid a quadri, braccialetti di cuoio, orrendi sandali sfondati, pantaloni cargo, fasce colorate per i capelli e borse di pezza. Niente maglioni oversize e caschetto grigio, taglio di tendenza per troppe donne di mezza età. Niente calzini multicolor sdrammatizzanti (non c’era niente da sdrammatizzare). E per carità niente incensi. Allo stesso modo, niente borsa bauletto, scarpe con stiletto argentato, porta-agenda organizer (o porta tablet) in pelle martellata. Niente portachiavi high-tech. Niente. Si sentiva in ripresa. Voleva solo confondersi fra la gente con la soddisfazione di indossare un abito ben scelto, col profumo migliore.
Doveva chiamare sua madre.
5.
I fari accesi alle pareti color caffè promettevano un incanto indefinito che in realtà durava circa sette secondi. Entrati, infatti, sotto lo sguardo sguardo obliquo del custode – fra le note prevedibilmente ambient –, ci si trovava davanti a un insieme composito: tutto sembrava teso nello sforzo di dare il meglio di sé; sforzo in parte vano, va detto (ad esempio gli specchi sul soffitto alternati a pannelli fonoassorbenti), apprezzato però da quasi tutti i visitatori che si compiacevano vicendevolmente della crescita fatta segnare negli ultimi anni dal piccolo museo. L’intenzione era quella di competere con le migliori gallerie della regione. E davvero per lo più i presenti non erano lì per l’allestimento, ma per accompagnare, appunto, questo processo. Benché fossero in tutto trentatré (li aveva contati) e alcuni di loro presumibilmente parenti degli autori delle diciassette sculture, non degnavano l’allestimento di particolare attenzione, attardandosi invece a valutare la bontà dei nuovi fari, dell’impianto a pavimento: «Questa è una struttura destinata a durare», concluse in sintesi l’Assessore alla cultura, come se rispetto all’edificio le statue, specie quelle in bronzo, recassero in sé un destino più breve.
Cinzia era nel suo elemento, elegantissima in un tubino ocra scuro e a suo agio in mezzo agli sconosciuti. Su suo suggerimento erano arrivate con quaranta minuti di ritardo («Non ti dico il traffico» aveva scritto a sua sorella Paola e glielo aveva poi ribadito a voce), in realtà si era trattato di un accorgimento mirato con successo a tener conto del ritardo fisiologico con cui di norma si aprono queste occasioni, e dei primi discorsi di ringraziamento dei politici di maggior grido, talvolta interessanti, perché del tutto svincolati dalla realtà dell’arte, ma il più delle volte – e questa era data per una di quelle – scontati e ripetitivi («Una palla esiziale»).
Anche Giulia si sentiva bene. Si teneva più indietro, in mezzo agli altri, priva di obblighi di circostanza e animata da un’autentica curiosità.
Aveva ascoltato con attenzione il discorso di Ugo Pedrolla, che aveva parlato a nome dei quattro artisti esposti:
«Siamo fra i pochi a concentrarci ancora sui valori plastici. Ciò che facciamo non è un gesto, è materia tridimensionale che ha una vita propria: è qualcosa in cui possiamo inciampare, che non può lasciarci indifferenti. È qualcosa destinato a restarci davanti».
Sua madre passava la giornata a casa di Marcella, piegando biglietti della lotteria.
Se lei e Cinzia avevano pensato di farla franca arrivando in ritardo per saltare i discorsi di circostanza, non avevano tenuto conto che si poteva fare di meglio, come una signora del borgo, coperta di bigiotteria di pregio, che entrò nel museo prima della conclusione del discorso di Pedrolla, del quale non aveva intenzione di curarsi. Era un’amante delle gite, del patrimonio tutelato dal FAI. A un certo punto tirò fuori un foglio piegato che teneva in borsa e, concluso il discorso di Pedrolla, ebbe l’azzardo di chiedere la parola per presentare con un azzardo ancora maggiore il programma stagionale della sua associazione. Gite per tutti e post-impressionisti. Poi Sulle tracce di Rilke a Duino. Per i più esigenti, Pasolini disegnatore. Cinzia se ne mostrò tanto entusiasta da mettersi per prima ad applaudire, mentre Giulia, da lontano, le raccomandava a cenni di trattenersi.
A ben vedere – pensava – non c’era poi tanto da ridere se i suoi coetanei che avevano fatto studi umanistici si sarebbero accapigliati per Fortini illusionista. Una volta aveva litigato con Fiorenzo Bianco Sarti, un amico di Lucia che lavorava in università, accusandolo di fare un lavoro sterile, parassitario. Meglio passare alla mostra.
«Al di là di tutto,» diceva la signora, «si può ben riassumere il senso del programma ricordando – e vi prego di ricordarlo tutti – che l’arte si confonde sempre con l’amore per l’arte».
Applausi. Anzi, applausi convinti, non era chiaro se di condivisione o di sollievo.
Concluso il momento ufficiale, due camerieri entrarono dall’esterno e si diressero verso il fondo, ciascuno ai lati della parete. Uno dei due, tirando un cordone, mosse un sipario di velluto nero che si apriva su uno spazio immacolato, dove su quattro tavoli due colleghi stavano predisponendo le ultime delizie del rinfresco.
Altri applausi, ancora più convinti.
Cinzia aveva puntato due del gruppo degli artisti. Li aveva avvicinati e parlava con loro. Nel frattempo, Giulia girava fra le sculture: vari esempi stilizzati o astratti; qualche ripresa figurativa, come uno splendido busto di ragazza dall’aria seria, in bronzo, striato di verde. La cosa più bella dell’esposizione, quasi commovente. Una giovinezza fragile e determinata, come era stata in fondo anche la loro.
Strano che sua madre non si fosse fatta sentire.
Fuori, dalle ampie vetrate, si intravedeva un giardino che aveva bisogno di risistemazione, ma che non l’avrebbe ricevuta finché non fossero terminati i lavori sul retro della galleria, dietro ai bagni.
Nell’erba alta, le panchine somigliavano proprio a due panchine, non al risultato di un progetto di ricerca. Non erano diverse da quelle disposte nel parco in paese. Aveva fatto bene a venire.
6.
Due ore dopo, in macchina con Cinzia, rifletteva sulle sue uscite con Alberto, che non erano state numerose; del resto al lavoro finiva prima di lei, per questo spesso si fermava con gli amici, col giro della palestra, a cui lei ogni tanto si aggiungeva solo per cena. Inoltre, non avrebbe amato occasioni come la mostra collettiva: dato che sapeva apprezzarle soprattutto per il loro aspetto sociale, ai suoi occhi apparivano sempre troppo piccole, troppo poco significative sul fronte della notorietà (era ridicolo, a queste latitudini, parlare di glamour). Per lei, invece, forse sarebbero state interessanti se completamente prive di glamour. Ogni tanto aveva pensato che un evento aperto solo per lei sarebbe stato l’ideale, anche se poi era arrivata quasi subito a pentirsene, perché non era poi così a suo agio nella desolazione. Comunque, Alberto aveva una diversa attenzione per gli oggetti, che per lui non possedevano un valore autonomo, ma solo strumentale: sceglieva con cura sovrumana la borsa della palestra e così l’abbigliamento sportivo, che doveva essere intonato a tutte e tre le paia di scarpe che usava. Da questo – in fondo lo aveva sempre saputo – si desumeva l’opinione che aveva di sé, più che la passione per una disciplina. Lei invece amava la disciplina: da ragazza più volte in montagna si era trovata a scendere per una pista nera con i jeans; e si era trovata benissimo.
Pioveva leggermente.
Senza grande sforzo, Cinzia aveva strappato un appuntamento a quattro con Carlo, architetto, e il suo amico scultore Enrico (l’autore del busto della ragazza). Si sarebbero visti sabato sera a cena a Sirmione. Due persone vivaci, soprattutto Enrico, che dopo alcune esperienze in Germania come scultore, insegnava in un liceo.
«Vedi un po’ che ora sono io a doverti ringraziare,» disse Cinzia, le mani sul volante, «perché a dirla tutta, se tu non fossi venuta, neanch’io ci sarei mai andata. Paola o non Paola. Figurati, tutti questi chilometri per una mostra».
«A me è piaciuta».
«Ma anche a me, cosa credi?» Cinzia scoppiò a ridere, «e quel che mi è piaciuto di più è che con loro ho proprio voglia di parlare, non ho per niente forzato la mano. Specie con Carlo. Ed Enrico mi è sembrato così umile quando parla delle sue esperienze in campo artistico. Sono persone a posto e in più mi sembra che abbiano anche qualcosa da dire, cosa rara negli ultimi tempi».
L’elasticità era una manifestazione del suo temperamento più che la conseguenza di una reale disinvoltura. La bellezza un po’ vistosa, una marcata propensione teatrale, il tono di voce che talvolta si spingeva più in alto di quello che la convenienza avrebbe richiesto la annunciavano con invidiabile chiarezza: in questo ambito non aveva nulla da nascondere.
«Ti confesso che anch’io non vedo l’ora di andare a cena con loro».
«Oh, ecco. Finalmente».
Il cellulare di Cinzia suonò. Ci mise un po’ a toglierlo dalla borsa.
Era Marcella. Stava portando sua madre al Pronto Soccorso perché non si sentiva bene:
«Un’ora fa mi ha detto che si sentiva un affanno che non sapeva da dove venisse. Poi ha avuto un capogiro. Mi sono un po’ preoccupata perciò ho chiesto a Sergio di andare a vedere. Siamo quasi arrivati. Vuoi che te la passi?»
«Sì, subito. Grazie, Marcella. Mamma come stai?».
«Non lo so. Ora Marcella mi dice che è meglio andare a farsi vedere e forse è la soluzione migliore».
«Va bene. Non agitarti. Passami Marcella».
«Marcella, scusa. Grazie di tutto. Fra mezz’ora siamo lì».
«Non preoccuparti, fai pure con calma».
«Grazie ancora».
Non era la prima volta che sua madre si sentiva poco bene, ma non era facile interpretare le sue condizioni, aggravate da un’ansia che talora un diversivo bastava a tenere a bada, se messo in campo con prontezza. Poteva dunque essere una di queste occasioni, nelle quali Marcella non era stata in grado di intervenire, o poteva essere qualcosa di peggio.
«Stai tranquilla, è di nuovo una questione di ansia. Se tua madre si stufa di qualcosa, si fa prendere dai pensieri cupi e subito si sente peggio».
In effetti, la situazione era indecifrabile. Non come con suo padre, che non si era mai lamentato e che era morto all’improvviso, di infarto. Qui era in gioco un’ermeneutica estenuante.
«Stai tranquilla. Non è niente di che».
Il tempo continuava a cambiare.
Fra i banchi di nebbia si aprivano d’un tratto squarci più sereni. La stagione era questa, bisognava rassegnarsi. Risalivano per la valle ora più ampia, fra il lago a destra e un pendio più scosceso dall’altra parte. Cinzia voleva mettere della musica, ma Giulia la pregò di non farlo. Nonostante non si potesse certo dire una bella giornata, su quella strada c’era sempre un traffico sostenuto, sia per il percorso tortuoso, sia perché non c’erano molte altre alternative viarie. Sua madre a volte era impossibile, ma sentiva che la preoccupazione che provava non era in contrasto con la serata che aveva trascorso con Cinzia, con le parole che aveva scambiato con Enrico; avvertiva, anzi, che andavano nella stessa direzione. Non era in preda al senso di colpa per averla lasciata tutto il giorno da Marcella, o almeno non tanto quanto in passato. Proprio perché l’affetto che provava si esprimeva nel tempo, e non solo in assoluto, per lei aveva sempre più a che fare con una forma di onestà che doveva agli altri come a se stessa, per quanto affrontare l’imponderabile fosse – com’era in quel momento – decisamente difficile. D’un tratto, pensando a quelle strade, su una via in un certo modo parallela a quella sulla quale stavano viaggiando, ricordò un’edicola che si apriva all’improvviso sul muro, sulla destra, del tutto inattesa, con l’immagine a fumetti di una Madonna pianista, dipinta da uno street artist (forse un improbabile omaggio a Santa Cecilia). Qui la strada scorreva più lontana dai paesi, priva di segni ufficiali, o popolari.
Arrivò un messaggio di Marcella: Niente di grave. Solo uno spavento. Fate con calma.
«Vedi? Lo sai che è così».
«Sì. Lo so anche troppo».

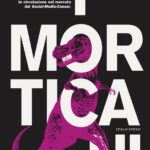 Francesco Maino, o la lingua impossibile - Massimo Rizzante
Francesco Maino, o la lingua impossibile - Massimo Rizzante Il premio - Walter Nardon
Il premio - Walter Nardon Guardare avanti - Walter Nardon
Guardare avanti - Walter Nardon Scartafacci e punzecchiature/ 2 - Fabrizio Cossalter
Scartafacci e punzecchiature/ 2 - Fabrizio Cossalter Umanissime illusioni.
Umanissime illusioni.  Sette canestri
Sette canestri La grandezza degli altri.
La grandezza degli altri. 





















