
Da cosa nasce questo tuo interesse per i naufragi dei migranti?
Ciò che trovo inaccettabile dei tanti naufragi di immigrati che contraddistinguono la nostra contemporaneità è il silenzio che li avvolge. Letteralmente, i naufraghi sono quasi sempre risucchiati dal silenzio delle onde. Per questo, credo che l’operazione, ostinata e contraria, della letteratura e del reportage narrativo debba essere quello di raccontare ciò che in genere non viene visto o sentito, o viene semplicemente rimosso. Con Il naufragio ho voluto raccontare la storia di un naufragio specifico: quello della Kater i Rades nel marzo del 1997. Con La frontiera ho provato a tenere insieme le infinite rotte e i disparati naufragi che segnano i viaggi contemporanei e che lambiscono quella che noi proviamo a definire come “frontiera”.
Il libro si apre con un video che hai visto a Roma nel 1998.
Quel video mostrava il massacro dei curdi nel villaggio di Halabja, fatti gasare da Saddam Hussein. Le immagini mostravano la morte dopo l’avvelenamento collettivo: i corpi di uomini, donne, bambini e animali riversi per le strade, davanti alle case, intorno a un tavolo da cucina. Erano immagino scioccanti, e se ci penso oggi credo che mi abbiano colpito nel profondo, non solo perché non avevo visto niente di simile prima, ma perché di quel genocidio non sapevo assolutamente niente. Non sapevo niente delle cause e della sua genesi. Credo che questo iato, tra la violenza che genera i viaggi e di cui a volte percepiamo qualcosa e le sue cause, la sua storia, sia alla base dell’incomprensione o dello stupore che spesso proviamo verso i viaggi contemporanei.
A mostrare quel video a te e altri studenti universitari era stato Shorsh, un profugo curdo che hai recentemente ritrovato a Bolzano, dove vive. Chi è?
Shorsh è un profugo curdo a cui mi lega una profonda amicizia. La sua storia, oltre a essere segnata da quegli eventi, ci dice di quanto complicati siano i viaggi contemporanei. Dopo essere stato in Italia per molti anni, è tornato in Kurdistan, ma poi dopo l’avanzata del Daesh, è tornato in Italia, approdando a Bolzano, dove l’ho ritrovato. Questo andirivieni non lineare, fuori dagli schemi con cui spesso guardiamo alle migrazioni, ci dice molto della vita dei profughi.
Molti dei profughi di cui racconti sono eritrei, come eritrei erano i 360 morti del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. Da cosa scappano?
Scappano da una dittatura terribile, nata dalla degenerazione del governo rivoluzionario che aveva condotto il paese all’indipendenza dall’Etiopia nei primi anni ‘90. Il fallimento di quella lotta di liberazione è una tragedia politica contemporanea. L’Eritrea è un carcere a cielo aperto. Le prigioni sono pieni di oppositori politici. Non si ha nemmeno conoscenza di quanti siano tutti i gulag disseminati nel paese, dove si praticano sistematicamente le torture sui detenuti. Soprattutto, l’Eritrea ha istituito il servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato sia per gli uomini sia per le donne. A 18 anni tutti sono costretti a entrare in caserma e a rimanerci, in balìa dei vertici dell’esercito, almeno fino a 55 anni. È da questa mostruosità che scappano ragazzi e ragazzini che affollano i barconi.
L’Eritrea è stata una colonia italiana, che legame c’è tra quel passato e la situazione politica di oggi?
La rimozione delle condizioni attuali dell’Eritrea è strettamente intrecciata alla rimozione del nostro passato coloniale. Siamo incapaci di riconoscere la questione eritrea anche perché siamo incapaci di nominare il nostro passato coloniale. Che non si conclude solo con il fascismo: una comunità italiana, ad esempio, era rimasta ad Asmara fino alla metà degli anni ‘70. Più in generale, siamo incapaci di riconoscere il passato coloniale in tutti quei luoghi chiave per comprendere le migrazioni contemporanee. Non solo l’Eritrea, ma anche la Somalia, l’Etiopia, la Libia e la stessa Albania.
Credi che giornali e televisioni stiano raccontando correttamente le tragedie dei profughi?
Ci sono giornalisti che svolgono ottimamente il proprio lavoro. Ma nel complesso il mondo dell’informazione è spesso in ritardo nel restituire la complessità delle cause che spingono centinaia di migliaia di persone a partire. Solo comprendendo quelle cause è possibile evitare di creare allarmismi.
Cosa si può obiettare a coloro che dicono aiutiamoli a casa loro?
Ma cosa vuol dire aiutare a casa loro chi è scappato dalle galere della dittatura eritrea, dalla guerra in Siria o dalle violenze del Daesh? Un’espressione del genere è del tutto priva di senso logico. Diverso è porsi il problema di trasformare radicalmente le condizioni sociali, economiche, e soprattutto politiche, che costringono la gente a partire. Ma per farlo bisogna abbandonare un modo di ragionare che si divide in “casa nostra” e “casa loro”, perché nell’età della globalizzazione esse sono strettamente interrelate.

 «Nessun delitto è più interessante di un racconto riuscito» - Giovanni Accardo
«Nessun delitto è più interessante di un racconto riuscito» - Giovanni Accardo «Uno scrittore è sempre un asociale». Intervista a Massimo Rizzante - Giovanni Accardo
«Uno scrittore è sempre un asociale». Intervista a Massimo Rizzante - Giovanni Accardo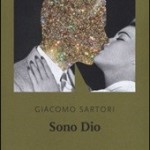 Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo
Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo La letteratura e la vita. Conversazione con Eraldo Affinati - Giovanni Accardo
La letteratura e la vita. Conversazione con Eraldo Affinati - Giovanni Accardo Il meccanismo incompiuto della letteratura. Intervista a Domenico Starnone
Il meccanismo incompiuto della letteratura. Intervista a Domenico Starnone





















