
Qualche breve considerazione su questo tempo che stiamo attraversando. La pandemia – come è accaduto, lungo i secoli, in occasione di pestilenze, di genocidi, di stragi – richiama il pensiero verso la necessità di uno sguardo sul tempo tragico. Il tragico è l’apertura di una voragine nella quiete di un’esistenza pensata come succedersi prevedibile di eventi, come sistema consolidato di relazioni, come definiti rapporti tra saperi e poteri. Irruzione dell’inatteso, e insieme evidenza del limite costitutivo dell’umano. Trionfo della morte – come celebri iconografie medievali e rinascimentali hanno raccontato – che disvela le illusioni della tecnica e della civiltà.
Le reazioni rischiano di chiudersi nella logica discorsiva del singolo sapere: al punto di vista medico si oppone il punto di vista politico, alla salute dei corpi la complessità che definisce le forme del vivere. Difficili le mediazioni. Rischiose le oscillazioni tra tutela esclusiva della salute pubblica e attenzione alla necessità che il corso economico e sociale delle cose riprenda il suo ritmo. Quali i modi e le forme che possano far convivere diritti alle libertà individuali, necessità del lavoro, diritto alle cure? Cercare, e praticare, questo equilibrio è compito delle comunità, dei loro interpreti, dei loro delegati.
Nel caso del virus che ha circolato, e circola, in questi tempi, secondo una diffusione appunto pandemica, lo sguardo va anzitutto verso quei numeri che sono nomi, quei nomi che sono vite, quelle vite che sono storie – storie di legami, di desideri, di esperienze e di sogni – trasformate in sequenza tragica di sparizioni, di sottrazioni all’esistenza. Qui è il centro della vicenda: il dilagare, dove più dove meno, della morte. L’estensione implacabile, ostinata, del dolore. Dire di questo coronavirus significa dire del dolore. Se rileggiamo la Peste di Camus, vediamo che il punto di osservazione sulla malattia, sui corpi, sulle relazioni che si formano e disfano, sull’immaginazione di nuovi rapporti è quello del dottor Rieux, un punto di osservazione che è anche, sebbene in terza persona, quello del narratore. Uno sguardo che ha il dolore come costante riferimento, il suo dilagare, il suo ritrarsi, le sue tracce, i suoi annunci, le sue ferite.
I discorsi che mettono tra parentesi, o danno per supposto, o considerano implicito questo sguardo, annunciano, fin da oggi, quella rimozione del tragico che in genere accompagna l’enfasi del ritorno alla vita considerata normale.
Nei tempi recenti due forme del tragico hanno levato la loro interrogazione rivolgendosi al nostro costume, alle nostre certezze, al nostro sapere: le morti di naufraghi nel Mediterraneo, le morti recenti, e che continuano, per il virus. Dovremmo ricostruire i nessi tra le due vicende, quale nascosta logica unisce questi due momenti del tragico contemporaneo. Il primo ha reso esplicito il limite di una cultura occidentale trincerata dietro i muri della difesa egoistica, dell’incapacità di ospitare e accogliere e dialogare, il secondo ha rivelato quanto fragile e miope e incosciente sia una civiltà incapace di trovare un equilibrio con la natura, con le sue leggi, con le sue forme.
Dinanzi ai due modi con cui si è manifestato il tragico, il primo, naturale, atteggiamento, non può essere che il compianto, questa forma di relazione con il corpo sottratto alla vita ma che può trovare una sua perdurante presenza nel pensiero e nel ricordo di chi resta in vita. Il compianto connota quel che possiamo chiamare umano in una civiltà. Ed è proprio la forma visibile, rituale, di questo compianto che l’ordine della sicurezza ha sacrificato nell’occasione di queste tante morti per il virus. Dolore aggiunto a dolore. Solitudine aggiunta a solitudine. Profondità del tragico. Non poter compiangere i morti: il divieto del seppellimento evoca Antigone, la sua affermazione di un diritto che è oltre le leggi, iscritto nella natura corporea e intima dell’appartenenza (autoadelphon, lei dice del fratello, unendo il possessivo al sostantivo, come accade in alcuni nostri dialetti meridionali: fratima, mio fratello). Nel cuore di questi lutti, il sacrificio dei medici e sanitari che per soccorrere hanno perso la vita: come si può distogliere lo sguardo da questo punto nero del disastro? Nell’esercizio del soccorso, nella pratica della compassione, le loro vite sono state travolte. Quale memoria potrà compensare la loro sparizione?
Convivere col virus, si dice. Si tratta, certo, di sperimentare delle forme che permettano di ritrovare una socialità – costitutiva dell’esistenza – che sia in equilibrio con la difesa della salute, e delle vite, dei singoli e delle comunità. Ma, nel frattempo, e da subito, perché non aprire una grande, corale – scientifica e politica insieme – progettazione di modi e forme che permettano, per riprendere un’espressione del giovane Leopardi, di “abitare la natura”, e che rendano via via meno “snaturato” questo mondo? Un grande piano, economico-politico, di ristabilimento dei rapporti con la natura: protezione, cura, pratica di relazioni produttive che preservino l’ambiente, modifica graduale ma, in prospettiva, profonda dei consumi, dei modi di produrre e consumare energia, ricerca di un equilibrio tra agricoltura e industria, progetto esteso di risanamento idrogeologico del Paese, tutela effettiva e minuziosa del paesaggio. E, insieme con questo, riorganizzazione a tappeto, e per tutti, di quei servizi – sanità, strutture di cura e di accoglienza, scuola, ricerca – che permettono di dare senso all’espressione stato sociale. Senza questa svolta ogni rimedio è provvisorio.
L’altro volto che la pandemia ha messo allo scoperto è quello della diseguaglianza, un volto certo già visibile ma spesso reso opaco dall’astrazione dei numeri, o dall’illusione di progressivi miglioramenti. Diseguaglianza di condizioni economiche, di situazioni – le case di riposo, i portatori di handicap abbandonati a se stessi, nel chiuso delle case o delle strutture sanitarie, gli immigrati, i senzatetto – ma anche diseguaglianza nelle possibilità di difesa dal virus, nell’organizzazione della vita quotidiana, negli spazi necessari alla sopravvivenza.
Ancora. Alla distanza fisica dei corpi, all’abolizione delle forme sociali di convivenza, di prossimità e condivisione, fondamento del riconoscimento e della conoscenza e del vivere civile, si risponde con la dilatazione del virtuale, dell’interconnessione, della partecipazione per immagini e suoni: una rapida, pervasiva, sostituzione che la telematica – il sapere visivo della lontananza – ha messo in campo. Utilissima compensazione, ma bisognerà interrogarsi sulle forme con le quali questa presenza potrà ritrovare un equilibrio in rapporto all’altra necessaria presenza, quella corporea. Fino a che punto, ed entro quali limiti, la telematica, che è la tecnica del lontano, potrà non prosciugare né alterare le forme dell’immaginazione – abitare con l’immaginazione la lontananza è attitudine propria delle arti – e con quelle forme aprire un dialogo proficuo? Prossimità e lontananza sono due grandi temi che questa vicenda invita a ripensare.
Un’ultima considerazione. Tutti i rapporti, si dice, sono ormai globalizzati. Allo stesso tempo, e spesso in connessione con questo, si riconosce da più parti che la natura è offesa nella sua integrità, nei suoi ritmi, nelle sue leggi, nel suo stesso apparire: proprio su questo piano – sul legame tra un mondo sempre più contiguo nelle sue forme e culture e produzioni e una natura sempre più aggredita e trasformata – come si potrà cominciare a pensare una mutazione? Come le forme diverse del sapere e i comportamenti, le leggi e i rapporti possono disegnare un mondo che su questi due campi metta in opera una vera conversione?
Dare allo sguardo sul tragico il respiro di un pensiero che diventi principio di una svolta: di cosa altro dovremmo occuparci, in questo periodo?

 Lettere a un giovane del XXI secolo - Enrico De Vivo
Lettere a un giovane del XXI secolo - Enrico De Vivo Got Rhythm? - Angelo Angera
Got Rhythm? - Angelo Angera Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio
Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio لا شكرا La, shukran - Sofia Pettorelli
لا شكرا La, shukran - Sofia Pettorelli Appunti su Vico e Leopardi
Appunti su Vico e Leopardi Margini per Umberto Bellintani
Margini per Umberto Bellintani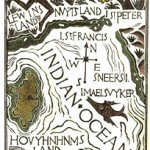 Soyumba
Soyumba Luna nera
Luna nera






















Pingback: (Segnalibri) Un intervento di Antonio Prete su “Zibaldoni d’eccezione” | Via Lepsius