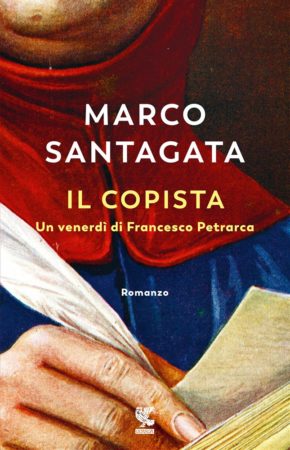
A un certo punto il protagonista de Il copista di Marco Santagata, testé ripubblicato da Guanda a seguito dell’edizione Sellerio di vent’anni fa, alle prese con una corrispondenza molesta sbotta: “Non bastava Boccaccio a fargli una testa così sull’Alighieri, ci si doveva mettere anche quel mezzo letterato di Napoli”. Si tratta ovviamente di Petrarca, di cui Santagata è tra i massimi studiosi, a soffrire il confronto con il suo maggiore, dando vita ad un derby toscano dagli altalenanti esiti nel corso dei tempi; glorificato in vita l’autore dei Rerum vulgarium fragmenta fu seguito, grazie alla lingua rarefatta e prestigiosa, per almeno due secoli da un’infinità di imitatori non solo italiani, mentre la rimonta dantesca, cominciata nell’Ottocento romantico, si è ampiamente compiuta e dura tuttora anche a livello mediatico (con romanzi polizieschi, film e fumetti dedicati), avvantaggiandosi della visionarietà della Commedia e della figura tutta d’un pezzo del suo autore. Eppure il più giovane antagonista parrebbe assai prossimo alla sensibilità contemporanea. In primo luogo si trova a calare un nuovo sentire dentro una cultura già non più sua, così da essere da subito un autore, a differenza di Dante, messo di traverso, della rottura e del passaggio, che guarda indietro ai classici e fonda il futuro dell’Umanesimo. Di qui le variazioni personali all’endecasillabo, al sonetto e alla canzone, l’organizzazione in struttura del Canzoniere (che Santagata suggerisce rubata al Decameron dell’amico Boccaccio) ma soprattutto, per quanto ci riguarda, il senso di fuga temporis e di morte, le incertezze esistenziali e la forte introspezione di un poeta che per la prima volta si vede vivere; tutto quanto all’interno, quasi mimetizzato, del codice d’amore.
Questi e altri motivi si ritrovano nell’unità di tempo messa in forma nel breve romanzo: la giornata del 13 ottobre 1368 in una uggiosa Padova. Santagata non schizza certo un santino del poeta laureato; anzi vi si rinviene la confidenza un po’ perfida di chi conosce a fondo, virtù e molti vizi, del proprio oggetto di studio:
Lo sapessero i suoi ammiratori che il grande Petrarca, avvezzo a dialogare con le Muse, era ridotto a parlare di merda e di ulcera allo stomaco con una vecchia deforme e analfabeta.
E più imbarazzanti problemi alla vescica, meteoropatia, invidia sociale e rancori (“Se lui fosse nato in casa Colonna, in casa Correggio, se soltanto avesse avuto un decimo delle rendite di quegli zotici superbiosi davanti ai quali si era inchinato per tutta la vita, e no, perdio, che non avrebbe preso i voti”), rabbie e facili commozioni, ridotta capacità di lavoro e di originalità a fronte dell’allargarsi della “polla d’indolenza”. Quell’acedia medievale – “sottrazioni temporanee di vita” – che Petrarca trasforma in moderno male di vivere; da una parte in grado di dare equilibrio all’attivismo giovanile, creando pause di sogno e di ricarica, dall’altra momenti baudleriani in cui la Morte fissa il suo nero vessillo sull’emorragia del tempo. Petrarca a questa altezza storica è divenuto il monumento di se stesso, che non deve più affannarsi a cercar riconoscimenti e onori dai potenti o dai dotti, ma resta comunque tignosamente impegnato ad amministrare con mestiere il suo mito, fosse pure, come detto in apertura, con un’epistola latina piena di riguardi verso un oscuro cavaliere napoletano. Non si pensi soltanto al grande attore, che avverte le proprie stonature o auto-scimmiottature, perché l’”eternità cartacea” stessa viene messa in questione: grande elemento di modernità! Possiamo certo fare della storicizzazione sul contrasto tra gloria terrena inseguita e subito distrutta nel confronto con la vera eternità celeste, che rende la prima peccaminosa, ma ciò che conta per noi oggi è l’insoddisfazione e quasi l’amata beffa per i risultati raggiunti:
Posterità! Una catena che rotola sulla carrucola: ciascun anello appare per pochi istanti alla luce e subito risprofonda nel buio del pozzo. I posteri non sono che una illusione, lampi che si accendono muti nell’oscurità della storia. Scrivi, Petrarca, avrai l’applauso dei defunti.
Il contrasto viene alla luce soprattutto tra l’assolutismo dell’abbandono alle Muse e la povertà umana che ciò sembra comportare di necessità, facendo il deserto d’affetti attorno al poeta. Vuol bene a Boccaccio ma ugualmente si compiace di vederlo dopo cinque anni invecchiato e imbolsito, un po’ sciocco nell’entusiasmo per l’inedita frequentazione dei potenti: un minore per consapevolezza; Laura, amata in gioventù, viene malignamente ricordata nel suo decadimento fisico; la figlia Francesca, remissiva e piegata alle prossime cure dell’illustre genitore, il nipotino Francesco (ed è tutta una replica di specchi nominali) morto nella peste come Giovannino, bastardo riconosciuto ma indocile a ogni educazione. E prima di tutti il copista, Giovanni Malpaghini, altro probabile figlio illegittimo, che fin da ragazzo diventa il silenzioso e colto aiutante. Ma che rompe quel legame “dolce, sereno e distaccato”, cioè tanto utile al grande autore, abbandonandolo all’improvviso dopo averlo accusato del più tristo egoismo e averlo implorato di riconoscerlo quale legittimo erede. Petrarca tace durante quella scenata. Poi tormentandosi vorrebbe recuperare; in chiusa di romanzo invia un’olimpica, farisaica, lettera dove si dice pronto ad appoggiare l’allievo nella sua vita raminga (parallela a quella sempre inquieta del maestro), anche a riaccoglierlo a patto che abbandoni “quelle idee bizzarre che avrebbero turbato la loro convivenza”. Rimpianti paradossali per affetti concreti, rivolti a Giovannino il vitalista, e negati al possibile competitore Giovanni.
La debolezza umana del letterato dalla coscienza sempre incerta si era già adombrata nelle correzioni finali di una canzone, in cui Santagata mette magistralmente a frutto la conoscenza filologica e variantistica per illuminare in narrazione un carattere: la verità nichilistica di “nessuna sopravvivenza in terra, ma anche nessuna vita dopo la morte. Il male e il nulla. Un lampo di luce il buio perfetto. Questo è tutto: un niente”. La rivelazione definitiva, ottenuta per via poetica, definitiva e stupefacente anche per lui, viene poi edulcorata da Petrarca per il timore di mettere in cattiva luce la propria immagine ipostatizzata. Si vira verso il conforto ultraterreno che la canzone CCCXXIII offre all’autore: “Queste sei visioni al signor mio / àn fatto un dolce di morir desio”. Sta allora alla nostra sensibilità di moderni riconoscere quanto di esasperatamente ondivago e insoddisfatto si trova dentro alle soluzioni rassicuranti della tradizione e in esso riconoscerci; oppure di restare deliberatamente gli ipocriti lettori di un autore troppo timoroso e sottile.

 Tempi tolkieniani - Alberto Volpi
Tempi tolkieniani - Alberto Volpi L’animalista - Alberto Volpi
L’animalista - Alberto Volpi Accelerato - Alberto Volpi
Accelerato - Alberto Volpi Bufala e Romanzo nell’epoca delle fake news - Miguel Gallego Roca
Bufala e Romanzo nell’epoca delle fake news - Miguel Gallego Roca Il caso Tortora
Il caso Tortora Versi dell’orto e del giardino
Versi dell’orto e del giardino Tempi tokieniani/ 2
Tempi tokieniani/ 2





















