
E se avessimo puntato tutto sul cavallo sbagliato?
Voglio dire sull’uomo plasmato dalla scienza e dalla tecnica? Non abbiamo dato per scontate troppe cose?
E se ci fossimo sbagliati anche quando, non riconoscendo più nell’uomo che ci passa accanto nessun tratto distintivo, abbiamo cominciato per amore verso i cavalli e l’erba che calpestano a puntare gran parte della posta sul fatto che in fondo siamo tutti esseri viventi? Uomini, cavalli, ciuffi d’erba calpestati, insetti e perfino quegli scommettitori tanto incalliti quanto entusiasti che se ne stanno tutto il giorno nei laboratori della Silicon Valley a programmare l’erba, il cavallo o l’uomo del futuro?
Certo, secoli e secoli di falso umanesimo e di filosofico accanimento nel tentativo di conoscere ogni mistero, ci hanno condotto ad avere più fiducia nel fiuto del nostro cane, nella sensibilità di un ficus, o nella ricerca del gene della felicità che in noi stessi. Chi, dopo una separazione, o la morte di un figlio, ha mai pensato davvero che Leibniz, Hegel o Goethe potessero essergli di aiuto? “Le antenne della specie”, come una volta Pound definì pensatori e artisti, oggi sono quelle dei ripetitori di telefonia mobile in 4H. C’è chi ha anche messo in dubbio con buoni argomenti che l’educazione, a parte ciclici fallimenti delle riforme scolastiche e universitarie, sia in generale un valido sostegno. E la risposta è no, è sempre stata no, nel XVI come nel XIX secolo, se si desidera a tutti i costi applicare le grandi lezioni della cultura alla vita di ogni giorno. Ed è no, anche quando, a partire dalla seconda metà del XX secolo, la scienza e la tecnica hanno preso sempre più il posto della letteratura, dell’arte e della filosofia. Di fronte allo squallore di una città degradata non mi è di conforto sapere che la Cina, battendo sul tempo Google, ha recentemente creato Jiuzhang, un computer quantistico che usa particelle di luce per eseguire in duecento secondi un calcolo che richiederebbe seicento milioni di anni. Jiuzhang riuscirà forse a battere sul tempo i nostri battiti di ciglia e a ricreare una splendida città rispetto a quella che siamo soliti vedere. Ma si tratta di una macchina. Si tratta di cifre, il cui scopo è letteralmente quello di confonderci: confondere la realtà numerica con quella organica dei corpi affinché i corpi smettano di reclamare affetto, cura, condivisione, smettano di essere organi senzienti e si trasformino in pure funzioni tracciabili, o in pazienti da medicalizzare. Si tratta di comprendere che il fascino per il numero e per la macchina è tanto antico quanto l’uomo ed è frutto della sua immaginazione e della sua realtà. Di quello stesso uomo che, assistendo all’agonia del suo cane, non si consola con la lettura né di Cartesio né di Montaigne. E neppure si mette a sfogliare un trattato di etologia o si balocca con la speranza che il suo cane possa ritornare a scodinzolargli tra le gambe grazie all’intervento provvidenziale di una stampante 3D.
O, forse, non è così. Forse mi sto illudendo.
Forse la mia innocenza non è più quella dell’odierno padrone nei confronti del suo cane moribondo. Forse non esistono più padroni e cani, ma solo esseri viventi e macchine. E padroni e cani che, in quanto esseri viventi che sognano di diventare macchine, per quanto storicamente transeunti nelle prime decadi del XXI secolo, sono tutti affetti dalla stessa malattia romantica che ha corrotto l’innocenza esaltandola in modo esagerato e rendendola una forma di fuga dalla realtà, mentre essa, per quanto mi riguarda, non esprime che la mia ammirazione per quello che è stato creato. La mia è l’innocente ammirazione di un realista per quello che c’è, mentre forse uomini, cani e scienziati che desiderano diventare macchine, oggi, preferiscono la copia di quel che c’è, o c’è stato, meglio se in 3D, meglio ancora se prodotta da un computer quantistico cinese. Meglio se una “bella copia”, migliorata, aumentata, imperitura. Non è un caso se gli animali-robot stiano diventando in molti paesi civilizzati un ottimo metodo di formazione negli asili nido e nelle scuole materne. A loro contatto, leggo in un recente articolo di una zoologa di Auckland (Australia), i bambini sono costretti a giocare responsabilmente: “hanno la gioia di entrare a contatto con una macchina, che per quanto elettronica, è zoomorfa e possiede un’intelligenza artificiale”. Se la rompono, vengono ripresi. Sanno che la prossima volta dovranno stare più attenti. “Imparano che non si distruggono le cose, tantomeno le persone e sperimentano la socialità con il diverso da sé. E tutto questo, naturalmente senza fare davvero del male a nessun essere vivente”. La stessa équipe di Auckland ha testato anche diverse case di riposo per anziani. Bene, i cuccioli-robot si sono dimostrati molto più validi del bingo e delle gite in città per alleviare solitudine e depressioni.
Per Cartesio l’uomo era poco più di una macchina. Per Montaigne le bestie erano in grado di provare sentimenti. Molti animali, è noto, sembrano a volte manifestare una certa sensibilità e perfino una coscienza elementare: i lupi ululano alla luna; elefanti, scimpanzé ed orche si riconoscono guardandosi allo specchio; i delfini giocano per ore, mentre le cornacchie dispongono sulla strada file di noci, di cui vanno ghiotte, affinché le auto, schiacciandole, le aprano al posto loro. Gli animali, sebbene con un paio di secoli di ritardo rispetto agli uomini, sono riusciti ad ottenere una carta universale dei loro diritti. Non importa che né l’una né l’altra siano granché rispettate. Ciò che importa è che l’uomo stia a fianco degli animali e che lotti per i diritti di ogni essere vivente. In una vera democrazia, ovvero in una bio-democrazia planetaria, tutti gli esseri viventi hanno diritto di esprimersi, di votare, di essere liberi, di associarsi. Per i doveri c’è sempre tempo. Ed anche per la vera innocenza nei confronti della natura e il senso dell’umorismo.
Tuttavia, oggi dobbiamo cominciare a fare i conti, oltre che con i diritti degli animali e in generale di tutti gli esseri viventi, anche con quelli dei robot. In Giappone da alcuni anni insigni giuristi stanno preparando un nuovo codice civile e penale che comprenda crimini o abusi di o a danno delle intelligenze artificiali. L’Europa, dal canto suo, non è affatto in ritardo. Di recente ho letto alcune raccomandazioni della Commissione europea in materia di copyright nel caso di “opere di ingegno create da intelligenze artificiali alle soglie della quarta rivoluzione industriale”. In altre parole, la Commissione si pone il problema se un robot possa essere considerato autore di un’opera, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica. La Commissione sta cercando, insomma, di elaborare dei criteri per definire una “creazione intellettuale propria” da parte della macchina, suggerendo la creazione di un nuovo “genus giuridico” titolare di proprietà intellettuale: il soggetto digitale. Ma le cose non sono semplici. Il soggetto digitale può essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui le sue opere risultino plagio di opere create da terzi, cioè da esseri umani o animali? E di conseguenza: che cosa ne è delle nozioni di copyright e di plagio, nate con la carta dei diritti dell’uomo e del cittadino più di due secoli fa?
A questo proposito c’è una storia, o storiella, che ho letto un paio di anni fa durante un mio soggiorno a Montréal, in Canada. Nemmeno i canadesi scherzano quando c’è da spendere il denaro pubblico per “la ricerca e l’innovazione”. Dopo il Giappone e gli Stati Uniti, il Canada è il “terzo ecosistema di intelligenza artificiale per numero di esperti in robotica e apprendimento automatico”. La storiella, comunque, data 2014 e ha come protagonista David Slater, un fotografo naturalista inglese, e un macaco indonesiano. Il buon David, mentre sta realizzando un servizio fotografico su un gruppo di scimmie, lascia per alcuni minuti incustodita la sua macchina fotografica. Un macaco, come fanno tutti i macachi in presenza di qualsiasi oggetto, la prende, se la mette a tracolla e inizia a scattare una serie di fotografie, tra cui diversi selfie. Il caso fa sì che due selfie riescano perfettamente. A quel punto il fotografo naturalista si pone pubblicamente una domanda che lascerà il segno nella storia della specie umana: di chi sono i diritti di utilizzazione economica di quei due selfie? Il fotografo, che aveva predisposto la macchina fotografica in modo che potesse accadere quel che poi è accaduto, oppure il macaco? Ma un macaco può considerarsi “un soggetto animale proprietario di diritti d’autore”? La vicenda arriva nelle aule giudiziarie. In primo grado i giudici decretano che “degna di tutela è solo una creazione frutto di lavoro intellettuale”. Perciò attribuire a un soggetto diverso dall’essere umano la qualità di autore di un’opera dell’ingegno (mind) è impossibile. La querelle non finisce e alla fine il fotografo, spinto dall’opinione pubblica, dai partiti ambientalisti e forse da un certo senso di colpa, decide di donare una percentuale dei proventi dei due selfie scattati dal macaco a un’associazione animalista. Così vanno le cose con i macachi. Tutt’altra faccenda quando entra in gioco l’intelligenza artificiale con i suoi “soggetti digitali”. L’evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine intelligenti pronte a prendere decisioni in modo autonomo dagli umani e a superare presto le nostre capacità intellettive. Come si può negare a un robot le cui prestazioni intellettuali saranno ben presto molto superiori alle nostre il copyright sulle sue opere con relativi diritti d’autore? È notizia dell’anno scorso che un robot ha creato una serie di opere musicali che formeranno parte di un album destinato a essere commercializzato, mentre un altro robot ha appena terminato una sceneggiatura e un altro ancora una vera e propria opera letteraria.
L’intelligenza artificiale corre, corre, corre molto più di un uomo e anche di un cavallo lanciato al galoppo. Del resto, si tratta di un cavallo-macchina e per giunta la corsa è truccata. Il cavallo-macchina, infatti, corre senza veri avversari. I bookmakers “della ricerca e dell’innovazione” di tutto il mondo danno la sua vittoria 100.000 a 1. Per batterlo ci vorrebbe solo un miracolo!
Un cavo teso al di sopra di un abisso
Vi ricordate il buon vecchio Nietzsche? Prima del suo ultimo periodo e del collasso mentale avvenuto a Torino il 3 gennaio del 1889 davanti allo sguardo lucido di un cavallo – non un cavallo da corsa, ma un vecchio cavallo preso a calci e a frustate da un cocchiere – aveva scritto Così parlò Zarathustra (1885), che lui stesso definì il libro “più profondo che sia mai stato scritto”. Con quel tono biblico da Discorso della Montagna che gli è proprio, già nel celebre prologo Zarathustra annuncia uno dei suoi grandi temi. Rileggendo il brano, ho sostituito mentalmente a metà della prima frase la parola “superuomo”, con la parola “macchina”. Così:
L’uomo è un cavo teso tra la bestia e la macchina, — un cavo teso al di sopra di un abisso.
Un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi.
La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto.
E subito le parole di Zarathustra hanno assunto i tratti di una vera profezia. Tutto mi è parso più chiaro. Forse Nietzsche valuta la “grandezza dell’uomo” nell’essere solo un ponte e di non avere nessuno scopo se non quello di tramontare in quanto essere umano in modo da compiere finalmente quel passaggio “periglioso”, ma decisivo, verso la sua ultima trasformazione in una macchina. Solo così, mi sembra di capire, l’uomo smetterà di essere un “cavo teso” sopra l’abisso del nichilismo, terrorizzato dal suo passato animale e incerto sulle gambe a causa di un presente il cui annuncio “rabbrividente” della morte di Dio, cioè della morte di ogni “realtà dietro la realtà”, risulterebbe privo di ogni prospettiva.
Questo vorrebbe dire allora che l’uomo, se davvero desidera superare l’abisso che egli stesso ha scavato dentro e fuori di sé, non ha altra scelta che scomparire? Non ha altra chance che abbandonare la sua specie, la sua storia, i suoi tratti distintivi, il suo corpo?
Beh, calma. Conosco un po’ le sirene del post-umanesimo e quelle, ancora più cacofoniche del trans-umanesimo, ma in giro, mi chiedo, non c’è più nessun Ulisse, o almeno qualche Telemaco privo di complesso di Edipo, in grado di tapparsi le orecchie? Il terrore di fare scalo nell’isola di Circe e vedersi trasformati in un branco di porci non è poi così lontano da quello di ritrovarsi un giorno in una casa di riposo del Vermont o della bassa padana con un cucciolo-robot come unica compagnia.
O non è così? Forse, come spesso mi capita, sopravvaluto i miei contemporanei. Come si fa a non vedere che tribalismo e high-tech vanno a braccetto in ogni angolo di strada? Del resto, dovremmo saperlo che il culto della macchina, se spinto agli estremi, fa sorgere dalle profondità dell’inconscio i nostri istinti più primitivi e violenti. E qui, mi sa, crolla l’idea che un superuomo-macchina possa farci fare un balzo al di là dell’abisso del nichilismo. Per il semplice fatto che il superuomo-macchina è quell’abisso. E l’uomo che aspira a quell’ideale, anche se non fosse armato di ogni sorta di bomba nucleare e di arma biologica, sarebbe già in grado di determinare la fine della specie grazie solo al suo rapido galoppare sulla strada maestra, inaugurata nel XVII secolo, e che in realtà è un vicolo cieco. Tuttavia, la situazione in cui viviamo ormai da diverse decadi non ha nulla a che vedere con quella del XVII secolo, e neppure con le rivoluzioni economiche, politiche e sociali del XVIII e del XIX secolo. Il vero abisso nichilistico inizia con la prima guerra mondiale. E, se stiamo alle profezie di Nietzsche, durerà almeno due secoli. Ciò significa che siamo in mezzo al guado. Siamo al centro di un cavo teso tra la bestia e la macchina, con in più una sola consapevolezza – una consapevolezza che è la più grande eredità del XX secolo: che la frontiera tra l’una e l’altra non è soltanto labile. L’umano non è qualcosa che si può definire una volta per sempre. Sta all’uomo di ogni epoca storica decidere che cos’è umano e che cosa no, che cosa lo differenzia dall’animale e, oggi, dalla macchina. L’uomo non è l’animale più nobile del creato per il semplice fatto che si è emancipato dalla sua animalità. Divenire umani è un’arte segreta, è una conquista faticosa, un compito infinito. L’uomo può trasformarsi in un macaco che si fotografa in qualsiasi momento. E, oggi, anche in un “soggetto digitale”. Quel che dovremmo fare è non dimenticare che siamo corpi e menti naturali e che viviamo all’ombra dei nostri sensi, lottando con i fantasmi delle cose e perciò dobbiamo essere consapevoli della nostra instabilità, della nostra cecità, della nostra ignoranza. Del resto, che cos’è la cultura, ci direbbe Lewis Mumford, “se non una potente messinscena attraverso cui l’uomo cerca di rafforzarsi nella sua illusione originaria di non essere, in fondo, un semplice animale?”. Ma, se l’esistenza dell’uomo sarà sempre più interamente consacrata all’incessante trasformazione della natura attraverso il perfezionamento della macchina, le tendenze animali dell’uomo, così come le sue molteplici manifestazioni storiche dall’epoca primitiva fino alle grandi civiltà, o saranno eliminate come impensabili o faranno esplodere l’intera struttura. Non si tratta di scagliarsi contro la scienza o la tecnica, ma di non soccombere a un’idea di ragione che denigra come irrazionale, visionario, o semplicemente inutile, l’immenso spettro delle potenzialità umane. Quando la razionalità riduce tale spettro, si trasforma in quella sorta di delirio raziocinante secondo il quale solo ciò che è impersonale ed empirico, oggettivo e quantificabile è degno di essere conosciuto. Così la neuroscienza (dopo il comportamentismo, dopo il cognitivismo) ha preso il posto dello studio dell’inconscio, la neuro-estetica (dopo lo strutturalismo, dopo la semiotica) quello dell’arte. Gli dei della scienza e del “realismo filosofico” banchettano in tutte le università e negli istituti di ricerca, accompagnati da code di esperti il cui unico standard di comprensione è basato sui fatti. I fatti! Perfino gli scrittori hanno capitolato di fronte alla forza dei fatti e non si sentono più in dovere di abbracciare il mondo con l’immaginazione! Intanto le nostre esistenze si riducono al conteggio delle vittime, al superamento di test elaborati da un algoritmo, o ad accumulare ogni giorno una valanga di informazioni nel tentativo di non provare vergogna – la terribile e ridicola vergogna di fronte alla macchina di cui parlava Günther Anders – davanti alle capacità superumane del nostro computer. La grande differenza tra la nostra epoca e quella in cui Nietzsche si lamentava dei danni che un eccesso di Storia poteva produrre alla vita è che oggi non è il passato che minaccia di seppellirci vivi, ma piuttosto un presente continuamente sollecitato dal cambiamento. Un cambiamento che, sebbene tutti – politici, giornalisti, professori, ecologisti, top-model e stelle di Hollywood – facciano a gara nel dirci quanto sia insostenibile, non riesce a darsi un limite. Il fatto è che il nostro presente, non essendo più in grado di compararsi e perciò di pensarsi (penser est comparer, dicono i francesi) in relazione con altri presenti storici, ha perduto la stessa nozione di limite. Il pericolo non deriva da un eccesso di forme tradizionali, per altro moriture o vissute senza alcuna ritualità. La Storia non è solo un incubo – lo può essere, lo è stata –, ma anche una consolazione: una terra da riscoprire e in cui trovare possibilità di vie di uscita dal nostro presente già sperimentate con successo.
A proposito di profezie, sentite che cosa diceva Paul Valéry, un poeta che non amo molto, ma anche, soprattutto nei Cahiers, un grande fenomenologo che non mi stanco di leggere, più o meno all’epoca dello scoppio della prima guerra mondiale:
La nuova era produrrà ben presto uomini che non saranno più attaccati al passato per mera abitudine. Per questi uomini la Storia non sarà altro che un insieme di strani, incomprensibili racconti; non vi sarà nulla nel loro tempo che si sia mai visto prima – e nulla del passato sopravvivrà al loro presente. Tutto ciò che nell’uomo non è puramente fisiologico sarà alterato, poiché la nostre ambizioni, le nostre idee politiche, le nostre guerre, i nostri costumi, le nostre arti attraversano una fase di rapido cambiamento; dipendono sempre più dalle scienze positive e di conseguenza sempre meno da ciò che in passato determinava l’esistenza. I fatti nuovi tendono ad assumere l’importanza che un tempo apparteneva alla tradizione e ai fatti storici.
Il pericolo non è nell’adorazione del passato, ma nel rifiuto del passato, e nell’aver dimenticato che nessuna generazione è in grado, nella sua limitata esperienza, di misurare la dimensione delle potenzialità umane. Noi non siamo gli ultimi, e neppure i primi. Sebbene ogni nuovo nato ricominci daccapo il cammino dell’uomo, ogni nuovo nato non è mai solo se stesso, ma parte di un discorso, parte di un patrimonio antropologico, storico e spirituale. Il fatto di essere un italiano che vive nel XXI secolo cancella forse il mio essere anche un greco, un romano, un cristiano, un europeo? Cancella tutti i miei ego storici vissuti e scomparsi dal neolitico alla civiltà cosiddetta dell’informazione? Il passato, il presente e il futuro non devono essere concepite come fasi temporali successive, ma come un continuum organico in cui il passato è ancora presente in un futuro che è già all’opera in modi imprevedibili nelle menti degli uomini sotto forma di sogni, fantasie, idee.
Ma c’è un effetto ancora più devastante provocato dalla nostra fede nella sacra alleanza tra novità e sapere tecno-scientifico, per cui ci sentiamo più infantilmente adulti e più liberi di tutte le generazioni che ci hanno preceduti. Si sente ancora dire da qualcuno, probabilmente non del tutto colonizzato dal verbum dell’informazione, che il tempo farà il suo corso, che con il tempo i valori verranno ristabiliti e che, al limite, dopo la morte ciascuno troverà il suo posto, sarà riconosciuto. Ebbene, credo che anche qui si sia superato un limite. Al dolore della morte di qualcuno, si aggiunge un dolore tanto più intenso quanto più il cambiamento di costumi, di idee, di significato delle parole si fa vorticoso, permanente, senza sosta, establishement. Morire fisicamente non basta. Bisogna diventare incomprensibili a coloro che restano. Animali estinti, fossili, esseri spiritualmente obsoleti, essendo la rapida obsolescenza delle macchine – e loro relativa intercambiabilità – l’unico criterio rimasto.
Sto esagerando? Sono un pessimista quando osservo come il sistema tecnologico del XX secolo ha distrutto l’autonomia individuale, le basi della democrazia e la stessa civiltà? Se l’arte segreta di coltivare l’umanità è sul punto di perdersi? Se il disastro, allo stesso tempo ecologico, sociale e soggettivo, non mi fa presagire che una sola alternativa: o l’inizio di una post-umanità in cui saremo asserviti completamente alle macchine o una nuova epoca che avrà come scopo l’unità tanto dell’uomo in quanto specie quanto dell’uomo come individuo?
Non so. In ogni caso l’idea di trovarmi a vivere nel punto più basso e degenerato della storia umana è qualcosa che rigetto, come rigetto il mio infantilismo e il mio desiderio “umano, troppo umano” di fuggire la realtà. E allora? Allora, dato che accrescere le conoscenze senza al tempo stesso imparare che uso farne avvelena l’esistenza, meglio ingoiare qualche antidoto contro la religione del progresso che, dopo la “morte di Dio”, sembra essere il nostro pane quotidiano che spezziamo per non morire di fame, ma che speriamo non diventi il nostro unico alimento. Per questo mi sono messo a tradurre, che è sempre il miglior modo di leggere, Le trasformazioni dell’uomo. Leggete questo libro del 1956. Vi sembrerà più nuovo dell’ultima versione di Apple. E non dimenticate: “Non abbiamo imparato nulla dall’esperienza storica finché non abbiamo imparato che l’uomo non vive facendo ricorso alla sola intelligenza”. Parola di Lewis Mumford. E, per qual che vale, anche mia.

 De bello Trubbiani - Massimo Rizzante
De bello Trubbiani - Massimo Rizzante Dialogo sulla fantasia - Gianni Celati
Dialogo sulla fantasia - Gianni Celati Liz - Massimo Rizzante
Liz - Massimo Rizzante La forza dell’amicizia e la gioia di scrivere nell’opera di Massimo Rizzante - Antonio Devicienti
La forza dell’amicizia e la gioia di scrivere nell’opera di Massimo Rizzante - Antonio Devicienti Scuola di calore /2
Scuola di calore /2 La poesia e il mondo della prosa
La poesia e il mondo della prosa Ivo Andrić o un giorno del 1954
Ivo Andrić o un giorno del 1954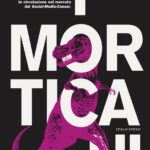 Francesco Maino, o la lingua impossibile
Francesco Maino, o la lingua impossibile





















