
Vite perse, dimenticate, aveva detto Iole. Quante ricoperte per sempre, davvero in tutto e per tutto vite di formica, di insetto, senza nome, nessuna impronta rimane, da una sola grande nebbia seppellite.
La sciagura di Gemma odorava un che di familiare. Per carità, subito dopo la guerra sfavillavano gli elettroshock, un toccasana. Isterico, schizofrenico, camicia di forza, contenzioni nel letto; tutto questo era stato Fausto. L’unica fortuna sua essersi consumato in dieci anni. A trentacinque, grasso quanto un bue, la barba sul petto, lo trovarono seduto in un angolo dei bagni comuni, nudo e sporco di feci, la lingua di fuori, gli occhi rovesciati. La vicenda scoperta solo dopo alcune reticenze di Ester; compatita in famiglia la sua memoria, come si compatisce una vittima, si perdona una vita rovinata, sprecata, una vita senza autentica responsabilità nella disfatta, annullata da sé, dalla sorte o soltanto dall’immensa marea delle cose che accadono. Un capanno dimenticato sulla spiaggia, strappato dal vento, arroventato dal sole.
Due bambinette, Iole e Gemma, il giorno che l’adorato cugino lo arruolarono fresco dei suoi vent’anni nei paracadutisti. In contemplazione dal basso verso l’alto; ne saranno state perdutamente innamorate. Da balilla, alle adunate, un piccolo Marte; giovine italiano spavaldissimo; in divisa un dio greco, induriti e bruciati i muscoli dai bagni nel Tevere. Nizza Corsica e Tunisia è tutta roba mia, tu me la devi, me la devi ridar: cantava a spaccarsi la gola, allegro Fausto, sulla nave che da Napoli lo portava a Tripoli. Allegro Fausto paracadutato nella notte, nei campi nemici; sgozzare i porci inglesi, le sentinelle, e poi bruciare tutti, far saltare in aria tutto. Li drogavano per fare una roba simile, più che sicura Ester. Invasato Fausto, marcito come tanti altri sin da quando aveva i pantaloni alla zuava. Se non fosse stata la droga, la guerra. Il primo segno forse lì: sparpagliate sul letto, le fogliate da diecimila lire, sciorinate una accanto all’altra, ricompensa della repubblica per il sangue nemico versato, esibite a chiunque entrasse. Un giorno ci si mise un caffè in piazza, bivacco di giovinastri; due fischi a una sottana, qualche sfottò. Davanti a quei tavolini Fausto, lo scemo di guerra, impettito nella sua giostra martellante: il passo dell’oca, eja eja alalà, il duce è vivo, vivo, capite, e state accorti che tutti al confino, tutti; il duce è vivo, il duce non è mai morto, a piazzale Loreto solamente una controfigura per i minchioni come voi. Calura da non respirare una mattina d’estate. Fausto, gambe nude, scarpe senza calzini, si buttò addosso il cappotto di lana; uscì. Arrivato davanti ai soliti grugni insolenti, li salutò, sorrise, chiese scusa; per farsi perdonare, da bere a tutti. Dal cappotto sfilò il lungo manico di legno di una pala da muratore, cui aveva staccato la lama. Randellò e sfasciò teste e tavolini per un quarto d’ora. La camionetta della Celere, in mezzo a urla e pugni serrati, gli risparmiò il linciaggio.
Fatta la mezza, mi accingevo a salutarla, perché potesse mangiare, e Iole con un filo di voce, c’era dentro vigorosa una smania, un bisogno autentico, mi disse:
“Non portarmi qui Carlo. Se anche lui volesse, non farlo”.
* Questo brano è il terzo e ultimo estratto pubblicato dalla nostra rivista dal romanzo di Danilo Laccetti Nella neve perenne (terza parte, cap. 3). Chi volesse ricevere gratuitamente il romanzo completo in formato PDF, può scrivere all’autore compilando il modulo Google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/yUfo5z3ZqEpc7heS8.

 Presiden arsitek/ 44 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 44 - Angelo Angera 12.18 - Danilo Laccetti
12.18 - Danilo Laccetti Tra le Muse e la povertà umana nasce il romanzo - Alberto Volpi
Tra le Muse e la povertà umana nasce il romanzo - Alberto Volpi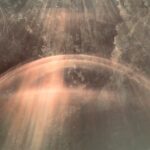 Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera Panegirico dell’ospite
Panegirico dell’ospite Marziale/ 4
Marziale/ 4 Sallustiana/ 2
Sallustiana/ 2 Fiori di carta
Fiori di carta





















