
“C’era una volta un re:
seduto sul sofà:
che disse alla sua serva:
raccontami una storia:
e la storia incominciò:
“C’era una volta un re:
seduto sul sofà:
che disse alla sua serva:
raccontami…”
Suo padre la metteva a cavalcioni sulle ginocchia e tenendola per mano e facendo trotta trotta con le gambe ad ogni accento le raccontava sempre questa storia, poi quando lei si stancava di tutti quei re e tutte quelle serve e gridava Basta! suo papà si fermava e diceva Seduto sul sofààààà, e fingeva di disarcionarla e farla precipitare a testa in giù. Lei strillava con tutta la sua forza come se volesse trasformarsi per sempre in nient’altro che un grido, poi il papà se la risistemava sulle gambe e quella era l’ora di andare a dormire.
C’era una volta un re, ogni volta che lei chiedeva una storia quella era l’unica storia, una storia che non finisce mai e che non racconta niente, e forse era per quello che lei ancora adesso che ormai era più vecchia di suo papà come lo ricordava quando la teneva a cavalcioni sulle ginocchia, ancora adesso non capiva mai nessuna storia o odiava tutte le storie che le venivano raccontate, ma quando la donna che ormai da qualche anno viaggiava con lei e che le aveva detto di chiamarsi Teresa aveva attaccato con la stessa filastrocca del re e della serva lei aveva pensato che quello era quello che i personaggi perbene nelle storie perbene chiamerebbero un segno del destino, ma dato che i segni del destino esistono solo in quelle storie – altrimenti non sarebbe nemmeno giusto chiamarlo destino – allora forse voleva dire che anche lei ploppete era finita dentro una storia, un’altra storia raccontata da chissà quale delle infinite serve imprigionate nella storia di suo padre una in fila dietro l’altra ciascuna con il suo bravo re e il suo sofà, ma l’unica storia che lei riusciva a immaginare era appunto quella del re e della sua serva, e perciò l’unico problema da risolvere in questa storia, l’unico destino da affrontare sarebbe stato capire chi avrebbe dovuto essere il re e chi la serva, a chi sarebbe toccato raccontare e a chi, di c’era una volta in c’era una volta, sempre e solo ascoltare. Ma a parte i morti e gli stracci in tutto quel tempo non avevano ancora deciso nulla, e nessuno raccontava mai nulla, né loro né tantomeno i morti. Forse giusto gli stracci, ma quelli come serve non contano, uno straccio in fondo è come la parola di un racconto, che noi buttiamo lì perché qualcosa di invisibile la indossi e la storia possa incominciare.
A volte per gioco ne prendeva alcuni dal mucchio che ingombrava il bagagliaio della loro macchina e spesso crollava anche sui sedili posteriori e cercava di ricomporre un vestito completo, di qua una gonna, di là una camicetta, un paio di stivali, un cappello di paglia, e li appoggiava così, sul poco di spazio libero dentro la macchina oppure fuori, sulla carrozzeria, ma da quando un paio di persone alle porte di Jakarta si erano avvicinate per osservare gli stracci e capire se erano in vendita Teresa aveva detto che da quel momento giocare con gli stracci fuori dalla macchina era assolutamente vietato a meno di non trovarsi lontano dalla città.
“C’era una volta un re
Seduto sul sofà
Che disse alla sua serva,
Raccontami una storia.
E la storia incominciò:
C’era una volta…”
La donna che viaggiava con lei ripeteva sempre quella filastrocca sottovoce, come fosse qualcosa da nascondere, prima di addormentarsi e cedere. Quando erano in movimento la donna dormiva ininterrottamente, girata su un fianco, la faccia rivolta al finestrino e a volte spiaccicata contro il vetro come i topi bianchi che una volta avevano visto ammassarsi in un grande contenitore di vetro di un negozio di animali. Cedeva come in una lotta, la donna lottava non si sa perché contro il sonno, e il momento in cui si addormentava era uno spasmo e uno svenimento dopo aver in un ultimo sforzo supremo teso tutti i muscoli del volto e le palpebre perché restassero attivi e svegli, quasi stesse trattenendo il respiro a più non posso per una fotografia, e il sonno arrivava come uno svenimento, la donna quasi paonazza per lo sforzo di tenere un’espressione sveglia sulla faccia, gli occhi sempre più spalancati e contratti, quasi furiosi per lo svanire del mondo davanti a loro, sbottava infine in un sospiro e immediatamente crollava addormentata.
Una storia che non finisce mai e che non racconta mai niente è lo stesso che dire una bugia o un imbroglio, solo che il tuo papà le bugie non le dice e non ti imbroglierebbe mai, no, era lei stupidina che si annoiava o si addormentava sempre prima che il papà arrivasse in fondo a tutte le serve, se solo fosse riuscita a resistere o a rimanere sveglia avrebbe scoperto la verità in fondo a quella storia stregata, e così anche lei come la donna che diceva di chiamarsi Teresa aveva provato per lungo tempo, da bambina, a rimanere sveglia tenendosi le palpebre aperte a forza con le dita, ma quando faceva così finiva sempre per sognare cose orribili davanti alle quali non poteva chiudere gli occhi, perché le sue mani erano ancora sveglie anche se tutto il resto dormiva, e così lei poteva comandare il suo corpo nel sogno fuori che le mani, che erano rimaste sveglie e tenevano i suoi occhi sempre aperti.
La mattina usciva dal posto di guida dell’auto dove aveva sempre dormito, si voltava verso il sole e chiedeva scusa al buon Dio, così diceva ogni volta, scusaci tanto buon Dio non era una preghiera perché sapeva bene che loro due loro non potevano più pregare, ma anche l’ultimo pezzo di merda d’inferno può sempre chiedere scusa, e così anche lei tutte le mattine usciva dalla macchina, il sorriso ancora istupidito dalla notte e impastato degli incubi sull’Africa che faceva quasi sempre, si metteva dove i suoi occhi ancora festonati di streghe e caverne africane riuscivano a vedere qualcosa che sembrasse la luce del sole e chiedeva scusa al buon Dio con un gesto delle due mani che da sopra la testa si allargavano e scendevano una di qua una di là e si bloccavano a metà come braccia di un crocifisso, e così in quella posizione lei restava fino a che gli occhi non si erano liberati del tutto dal sogno, e quello era il segno che il buon Dio anche per quel giorno aveva accettato le scuse, ma forse un giorno non le avrebbe più accettate e lei sarebbe rimasta per sempre negli incubi che faceva, in Africa, e sarebbe stato peggio che essere ciechi, e strapparsi gli occhi durante gli incubi non funziona, diventa solo peggio.
Ordinatamente in fila una dietro l’altra come uno specchio in uno specchio le serve la fissavano, la aspettavano dietro le sue palpebre, deluse perché come ogni volta si sarebbe addormentata prima che arrivasse l’ultima serva.
Un giorno si era messa a gridare, lì accoccolata al posto di guida, perché alla radio che ascoltavano quasi tutti i giorni una voce aveva iniziato a raccontare il suo stesso sogno africano, aveva gridato perché aveva capito che le streghe avevano finalmente trovato il modo di fuggire dal pantano bianco dei suoi occhi e strisciare come piccolissimi lombrichi neri negli occhi della persona che stava parlando dentro la radio, e “17 giugno: Nel sogno, sono tornato in Africa. Ancora una volta, una serie di tornado si sta per abbattere sulla costa. Questa volta però siamo in albergo, e sebbene l’edificio sia molto vicino alla spiaggia siamo in una piccola baia la cui entrata è per di più protetta da una grande isola-vulcano, così mi spiega quello stesso cameriere in divisa bianca che mi ha avvisato dell’arrivo del tornado. Il cameriere è a piedi nudi, e quando noto questo dettaglio lui mi rivolge uno sguardo che mi commuove e nello stesso tempo mi fa sentire cretino. C’è persino un cannocchiale a monetine, immagino per osservare l’isola di fronte all’hotel quando il vulcano è attivo e lente liane di lava scendono fino al mare paralizzandosi in ossidiana. La lava adesso scende da un’apertura laterale. Niente di preoccupante, mi dice il cameriere mettendomi una mano sulla spalla. Le mani degli africani, con quel colore chiarissimo nei palmi e sulle unghie, mi hanno sempre fatto venire in mente le zampe dei gatti. La lava scende lenta dall’apertura laterale, come sperma.
18 giugno: Il cameriere mi spintona ridendo e dicendo qualcosa nella sua lingua. Uomo Bianco. Il cronometro a del cannocchiale scatta richiedendo altre monetine, e indicando l’isola davanti a noi dico al cameriere che ci proteggerà. Poi, lateralmente, un’onda enorme riesce a insinuarsi nella baia, passando davanti all’hotel di profilo, per così dire, come un complicato marchingegno teatrale, e nel momento esatto in cui la cresta passa alla nostra altezza, e possiamo vedere i suoi gorghi di sabbia e alghe, con pesci o forse serpenti che balenano nei suoi vortici, riesco a capire perfettamente il significato del paragone tra un’onda e un cavallo che ho letto non so più dove. L’onda si abbatte sul lato sinistro della baia, ma è ormai evidente che il vulcano non ci proteggerà affatto. I tornado si stanno avvicinando. Devo trovare mio figlio e metterlo al sicuro, dico al cameriere. Nono piano, mi dice lui. Io non ho figli––” Io ho un figlio, aveva gridato allora la donna che diceva di chiamarsi Teresa, io ho un figlio, e allora lei aveva risposto che quella era la prova che il sogno dopotutto non era davvero lo stesso di quello che stavano raccontando alla radio, ma Teresa strillando e liberando dagli ultimi stracci il morto della sera prima aveva risposto che ormai le streghe avevano capito il modo con il quale non ci sarebbe più stata nessuna differenza tra i sogni della radio e la sua stessa vita, ecco cosa stava succedendo, e lei non avrebbe mai più potuto rivedere suo figlio, diceva Teresa denudando il cadavere ormai gelido ma non ancora irrigidito dell’ultimo morto e buttando di dietro i vestiti insieme a tutti gli altri.
Toccava sempre a lei guidare, non sapeva nemmeno se Teresa fosse capace di tenere in mano il volante, e mentre viaggiavano Teresa quasi sempre dormiva, accasciata contro il finestrino del passeggero oppure accoccolata dietro insieme agli stracci ai pupazzi e alle cianfrusaglie che raccoglievano lungo la strada togliendole ai morti. Altre volte con delle penne colorate faceva dei disegni sul rivestimento delle portiere e dei sedili posteriori, tutta una serie di animaletti disegnati con tratto infantile e radunati fuori da una specie di locanda in riva al lago.
I topi bianchi erano dentro un grande contenitore con le pareti di vetro, ammassati uno sull’altro contro uno degli angoli, almeno un centinaio di topolini bianchi vivi che sembravano avere come unico scopo quello di scegliere un angolo del contenitore di vetro e lì ammassarsi uno sopra l’altro, schiacciandosi uno sopra l’altro in modo che nessuno di loro si poteva più muovere se non quelli all’esterno, mentre gli altri col muso contro il vetro, e più di tutti quello con il muso contro lo spigolo inferiore, circondati dietro e sopra e ai lati da decine di altri topi bianchi, non potevano far altro che arricciare il naso e spalancare degli occhi nerissimi che era impossibile capire se fossero terrorizzati o no, ma forse i topi avevano capito che non dovevano farsi prenere dagli inservienti del negozio, avevano capito con l’infallibile intuito dell’animale da preda che intorno a loro un’intera popolazione di rettili e altre creature mostruose stava spalancando le fauci per prenderli, e non potendo avere un buco in cui rifugiarsi avevano deciso di rifugiarsi uno sotto l’altro, e quindi era probabile che i topi più sepolti fossero quelli più forti, quelli che ancora nessuno aveva catturato, e forse nascosto nel centro esatta del mucchio era accoccolato un vecchissimo topo bianco che era riuscito per anni e anni a sfuggire alle mani degli inservienti del negozio di animali, un quasi mitologico sopravvissuto che aveva buone probabilità di riuscire a salvarsi quando il negozio sarebbe stato infine venduto per diventare magari una lavanderia a gettoni, un’altra lavanderia in cui portare enormi sacchi pieni di stracci da lavare e asciugare prima di portarli al negozio di vestiti usati sul retro del ristorante Soni Toko Yu.
I corpi erano del colore della cera, molli e gelidi come la pancia di una lucertola, a volte quasi disciolti contro l’asfalto rovente, che quasi sfrigolavano, burrosi e ridicoli, e di tutte le chiacchiere e le storie di infinite serve in cui anche loro come tutti quanti erano intrappolati non restavano che pozze grigie e gusci d’insetto, ciascuno identico all’altro come infinite file e file e file di re e regine, solo gli abiti e le cianfrusaglie a fare la differenza, ma anche loro finivano tutti insieme ammucchiati in fondo al bagagliaio in un mucchio sempre più fitto e puzzolente, là dietro non c’era altro che la roba dei morti, a meno che uno non volesse contare i bigliettini di Teresa, ma i bigliettini che una persona scrive in preda alla follia contano quanto una cosa sognata, non sono completamente reali e nessuno li dovrebbe leggere mai, perché non sono per lui da leggere, sono per i mostri quelle parole, per gli estranei e le allucinazioni e le serve senza occhi che perseguitano le donne matte che non fanno altro che dormire e liberare i morti delle cianfrusaglie che li renderebbero uno diverso dall’altro.
Per esempio una volta nella tasca di un signore indiano soffocato in mezzo alla campagna contro le zolle ancora morbide d’aratro avevano pescato un piccolo serpente D’oro! aveva subito gridato Teresa come se avesse ancora tre anni ma non era oro di certo, bella mia, quello era ottone, ed era una cosa tutta a onde come un coltello di pirati della Malesia, ma più irregolare, non andava diritto e il suo corpo era come quello di due serpenti saldati assieme e intrecciati, uno un po’ più magro e l’altro un po’ più grasso, forse un maschio e una femmina o Forse siamo io e te aveva detto Teresa e lei si era sentita felice che l’avesse detto, forse siamo io e te. A volte durante le pause tra un morto e l’altro scavava con il serpente d’oro, ormai era d’oro anche per lei perché tutti quanti abbiamo avuto tre anni e una volta che li hai i tre anni nessuno te li toglie più, scavava nella polvere degli sterrati dove andavano a rintanarsi con la loro macchina piena di stracci, scavava nella ghiaia con il serpente d’oro e le sue spire indiane entravano ed uscivano dalla polvere e quasi sembrava che il doppio serpente fosse vivo, e ogni spira fuori dalla polvere era una serva e ogni spira nascosta nella polvere era un re, e quando il serpente entrava e usciva dalla polvere ogni re diventava prima o poi una serva e ogni serva un re…
Forse siamo io e te, aveva detto Teresa con la voce impastata di chi parla nel sonno, e a lei quasi era venuto da piangere, era poi per questo che non avrebbe mai abbandonato Teresa anche se sarebbe stato così facile lasciarla lì, addormentata in macchina insieme a una montagna di cianfrusaglie, non faceva altro che dormire e dormire come in una fiaba per bambini e a lasciare in giro per la macchina biglietti di avvertimento a persone che non esistevano perché li leggessero, dormiva e dormiva e dormiva e come nelle fiabe forse sarebbe stata capace di dormire per cent’anni di fila, ma nessuno sarebbe mai venuto a baciare una vecchia puzzolente come lei, nessun cavaliere si sarebbe mai avventurato nella selva di stracci per trovare la sua faccia indurita dal sole e dai morti che si lasciavano dietro lungo il cammino, nudi e bianchi come tanti Pierrot che giocano a un due tre stella.
Era questa la fine della storia? Forse siamo io e te, era questo quello che avrebbe dovuto dire a suo padre, io sono la serva e tu sei il re e la nostra storia non finirà mai e non racconterà mai niente a nessuno se non al re e se non alla sua serva, ed era per quello che si era messa quasi a piangere quando Teresa le aveva detto così. Forse siamo io e te, perché altro qualcuno dovrebbe raccontare o ascoltare delle storie se non per quel Forse da chiedere al papà o da rivelare alla propria bambina? Perché altro tenere in tasca un doppio serpente d’oro?
Il negozio vendeva animali velenosi come ragni e altri enormi insetti tropicali e naturalmente serpenti, e i topi bianchi erano il cibo di quegli animali e andavano appunto comprati così, vivi, e vivi presentati al proprio animale velenoso, che mangiava soltanto ciò che uccideva, e c’era forse della santità in tutto questo, mangiare solo ciò che si uccide e uccidere solo ciò che si mangia, non fosse stato che i topi bianchi venivano raccolti a manate dagli inservienti del negozio, come fossero frutta, e in quel momento le era tornato in mente di quando da giovane metteva i topolini a dormire, così diceva quando era così giovane che a pensarci ora le pareva di sprofondare attraverso strati e strati e strati di persone che erano sempre lei, sempre più giovani, tutte una sopra l’altra come i topi del negozio pronti per essere gettati nel terrario delle tarantole, e lei li chiamava topolini anche se il lavoro che faceva era una cosa da scienziati quindi avrebbe dovuto chiamarli esemplari, ma nessuno la guardava o la ascoltava mentre li metteva a dormire, e a nessuno importava poi davvero del lavoro che faceva e che per quei topolini era un ovattato e delirante inferno.
A volte mezzo per gioco lei e Teresa restavano chiuse dentro la macchina ferma sotto il sole, i finestrini chiusi, lasciando arroventare l’aria nei loro polmoni, le lingue secche e nere come quelle dei pappagalli o degli appestati, gli occhi folli di febbre che pareva volessero risucchiare tutto il resto della faccia come zecche, occhi-parassiti dietro i quali nella follia della lamiera incandescente le pareva quasi di sentire il formicolare di zampine e il becco d’insetto frugarle le orbite, i colori e le forme ormai nient’altro che una malattia provocata dall’insetto che fin da prima della nascita si annida nelle orbite di ogni essere vivente gonfiandosi del suo sangue e trasformando quel sangue in forme e colori per ingannare gli esseri e far loro credere che esista qualcosa al di là di una torre di sangue di serve e di re. Il sudore si appiccicava ai finestrini e ad ogni cosa mentre la macchina diventava sempre più calda e puzzolente, fino a che anche il sudore finiva e una di loro due perdeva i sensi, o il sole tramontava, e il giorno dopo la macchina sembrava un rottame abbandonato sul ciglio della strada, con quella carrozzeria rimontata un pezzo di qua e un pezzo di là nel corso degli anni, ciascun pezzo di una sfumatura di grigio o di azzurro mai uguale agli altri, una specie di arlecchino monocromatico i cui unici colori erano i mucchi di vestiti che portavano via alle persone assassinate, e solo se ti fossi avvicinato avresti potuto vedere, tra gli stracci o contro uno dei finestrini, i capelli di Teresa o la faccia della Truut spiaccicata contro il vetro, deforme contro la sua trasparenza, il tenue e ritmico biancore del fiato come solo indizio di vita, i vestiti dentro il bagagliaio ormai ridotti a un variopinto fango di tessuti e sudore dopo quella specie di ordalia cui ogni tanto si sottoponevano, e avvicinandosi ancora, appoggiando magari l’orecchio contro quello stesso finestrino poteva anche capitare di sentire il brusio della radiolina che tenevano quasi sempre accesa e “19 giugno. Prendo l’ascensore, un ascensore vecchissimo, con tanto di cancelletto di ferro battuto e porte di legno, c’è persino un divanetto interno di cuoio rosso. I corridoi dell’hotel sono molto lunghi, e tutti gli angoli, tra parete e soffitto e tra parete e pavimento, sono stati arrotondati. Io venivo a giocare in questo hotel, quando ero bambino. Io e il figlio del proprietario eravamo in classe insieme. La cosa più divertente era appunto l’ascensore, anche se allora i piani erano solo cinque, non nove come ora. Nono piano. Non ricordo il nome di mio figlio, ma è intrappolato lì. Cammino nel corridoio cercando di capire in quale camera sia. Un figlio, se non ricorda il nome del proprio padre, può gridare “Papà”, ma un padre che gridasse “Figlio” sarebbe strano, così mi dico, indeciso su come chiamarlo. Poi sento la sua voce. Papà. Cerco di aprire la porta ma è chiusa a chiave. Sento la voce di un’altra persona chiusa in camera con mio figlio. La persona mi spiega che non è la prima volta che le capita di restare bloccata, e che mio figlio sta bene. È la voce di un uomo anziano.
Il mio nome è Morte, mi dice”, e forse siamo io e te, sospirava lei, e Morte è anche il nostro di nome, ma se proprio quando eri lì sopra, il volto spiaccicato contro il vetro come un pesce tropicale in un acquario, cercando di decifrare il brusio della radiolina ancora accesa dentro la macchina, se in quel momento una delle due avesse aperto gli occhi, ecco i suoi occhi insetti parassiti del cranio ti avrebbero catturato con la stessa spassionata competenza di un ragno africano che vomita il proprio veleno dentro il corpo tremante di un topo bianco, e anche i tuoi vestiti sarebbero finiti insieme agli altri, Il mio nome è Morte e Morte è il nome della serva e della storia e del re.
Ma a Teresa la Truut aveva detto di chiamarsi Ilenor, Ilenor l’imperatrice segreta, e dopo essersi presentate per la prima volta le due vecchie avevano riso contro la luna piena come due lupi famelici di vecchi libri per bambini.
La prima serie di omicidi era stata per loro come un’infanzia o un amore. Dopo aver scelto la casa, che di preferenza doveva essere una casetta all’americana con ingresso sul retro, nel giorno stabilito ci arrivavano a piedi e si separavano poco prima di essere in vista. Già quella era una bella emozione, perché passavano così tanto tempo assieme da non essere più in grado, a volte, di distinguersi una dall’altra, ed ecco che ora invece si separavano, una di qui e una di là, anche solo per pochi minuti erano ormai così abituate a stare sempre insieme che era come staccarsi un braccio, ed ora eccole, una di qua e una di là senza nemmeno fiatare, e il meglio era che non dovevano mai nemmeno discutere e ogni volta la azzeccavano, se una delle due si avviava verso l’ingresso l’altra nello stesso istante aveva già preso per il retro… Scivolavano per finestre o porticine malchiuse, o se ogni varco era impedito restavano in attesa anche per giorni, una davanti e l’altra dietro la casa, due officianti la cui pura presenza e reciproco distacco trasformavano lo spazio tra l’una e l’altra in un altare, e quando poi finalmente riuscivano a penetrare nella casa, gli stracci ammassati sulle loro quattro ossa come una modificazione della pelle e la loro lentezza di poco superiore a quella delle ombre delle pareti che inarcavano le loro linee al trascorrere del sole, i loro passi di serpenti aztechi si confondevano spontaneamente con il tuo respiro, mimetizzandosi in attesa paziente che tu fossi abbastanza vicino, senza incontrarsi mai se non infine per ghermirti, e quando poi finalmente vedevi l’una o l’altra vicinissima a te, quasi una coagulazione imprevista del tuo campo visivo, tanto poco era il loro calore e tenue il loro sguardo che fino all’ultimo la tua anima in un disperato anelito ne decifrava il sorriso e i radi capelli appiccicaticci come una semiallucinazione, l’effetto di non so quale stanchezza, di non so quale chiuso dolore, ed era infine l’odore impolverato e pitico della loro pelle a innescare in te la delusa meraviglia della vittima, quando con dolcezza prestigiatoria una mano scivolava da dietro il tuo collo e ti chiudeva la bocca, e questo era il loro officio di magia, in quei tuoi ultimi istanti non ne avevi visto che una sola delle due, mentre dietro di te l’altra con la stessa implacabile precisione di un pianeta d’ombra che eclissa un astro faceva scivolare la sua mano ossuta contro la tua bocca e c’era nell’odore di questa mano e nella sua consistenza strisciante un brivido che come un magnete lasciato cadere in una soluzione ferrosa obbligava i tuoi pensieri a riconfigurarsi in follia e terrore, e anche se la mano era strisciata dolcemente, quasi romantica dietro la tua nuca e lungo l’attaccatura dei capelli e sotto un orecchio e infine si era incollata davanti alla tua bocca aderendovi e risucchiandone tutta l’aria come una stella marina, tu pensavi che quella che ti stava chiudendo la bocca era la mano della donna che avevi di fronte e che era l’unica che riuscissi a vedere, e perciò doveva essere la sua mano perché dietro di te non sentivi alcun corpo premere anche se la mano di bloccava la testa con una presa di ferro, e perciò doveva essere la mano della donna che avevi di fronte, scesa lungo il tuo collo grazie a chissà quale impensabile contorsione o deformità del corpo dell’estranea, e ogni volta capivi troppo tardi quello che stava succedendo, e chissà che fosse anche il semplice fatto di aver davanti una vecchia ad averti illuso di poterne facilmente avere ragione, e quando alla fine il gelo bianco della lama si faceva strada nella tua carne liberandone il sangue come il piscio di un neonato era quasi piacevole sentirsi intridere da quel calore che era stato tuo, ed ecco prima che l’ombra scendesse su di te capivi finalmente di trovarti nel centro gravitazionale di un rito e che due erano le sacerdotesse, una dietro di te che non avresti visto mai, e questo era parte del rito, e ora se la mano si fosse staccata dal tuo volto forse avrebbero potuto vederti persino sorridere, ma già il tuo sangue incoraggiato da quel primo taglio si sarebbe fatto strada tra i tuoi denti e infine tra le dita della donna il cui volto non avresti mai visto, e allora l’altra di fronte a te, che non ti avrebbe mai più toccato in vita, tirava fuori dagli stracci un involto di sacchetti di plastica e dall’involto una radiolina a pile, e dopo aver trafficato un po’ con le manopole “la vittima viene inseguita lungo le stanze e i corridoi, i bagni speculari e le scale di rovere della villa, e quando finalmente viene aperto il taglio lungo la gola è come se le urla disperate dei fenicotteri e delle oche rendessero invisibile la lama e con lei la mano dell’assassina, e la ferita che si allarga quasi decapitando la vittima il risultato di un’oscura stregoneria ossia di un difetto di fabbricazione del corpo. La maledizione si era manifestata, ovvero si era fino a quel momento manifestata attraverso le pubblicità a doppia pagina di un dentifricio su un quotidiano locale. L’immaginetta, talmente piccola contro o sfondo uniforme della pubblicità che lì per lì nemmeno la noti, attratto prima dall’araldica della ditta – le cui geometrie e animali, non è escluso, sono forse il vero stemma scatenante, il cerchio da cui è sbucato il Verme d’Inferno – e dagli slogan cubitali: e tutto questo nondimeno infine collassa nel sorriso del minuscolo e sulle prime trascurabile bambinetto con il dentifricio, il cui sorriso si dilata imprimendo al tuo volto un’identica contrazione, obbligato e ormai servo dell’immagine senti i tuoi stessi muscoli allargarsi in un sorriso che impegna l’intero sistema del volto, non avresti mai creduto si potesse sorridere tanto, né sospettato l’esistenza di un tale reticolo di nervi che il tuo volto potesse dedicare ad allargare sempre di più il sorriso, perfino dalla nuca qualcosa è impegnato nella dilatazione del sorriso stregato, e anche tutta la fronte si dilata e si tende, e il sorriso pare voler strappare il viso in due per rivelare il biancore del teschio, ed è con quel sorriso che infine prendi il coltello, un comune coltello da cucina di quelli da thriller degli anni ’80, e questa volta le tue sorelle si offrono docilmente al sacrificio, offrono la gola terrorizzate ma immobili, e le ultime due vengono pazientemente traversate dalla lama, una contro l’altra, come in uno spiedo brasiliano, una gola trafitta contro l’altra gola trafitta, il taglio talmente perfetto che quasi non ne esce sangue, i due volti così vicini come quando da bambine, terrorizzate dal buio, vi accoccolavate strette e vicinissime sotto le coperte…” e Forse quelle bambine siamo io e te, papà, mio re serpente d’ottone…
A volte si fermavano più del dovuto nelle case dei morti, anche dopo averli liberati degli stracci e averli sistemati magari in poltrona, o sdraiati in corridoio, bianchi come cittadini di Eden fiamminghi mezzo disciolti dall’uragano di calore dell’ininterrotta estate austroamazzonica di Schwarzschwarz. Restavano più del dovuto, ogni operazione ormai compiuta, a rovistare nella casa. Trovavano bottiglie di liquore o di vino e per un paio di giorni sarebbe stato così, non si sarebbero nutrite che di liquore, ciondolando ubriache per le stanze e i corridoi, senza quasi mai parlarsi, l’una dormendo mentre l’altra era sveglia, l’una il sogno dell’altra, le tracce dei loro piedi nudi e delle loro dita un po’ dappertutto per gli agenti da trovare.
Prima di portarli al negozio di vestiti usati, a volte tornavano a giochettare un po’ con gli stracci che traboccavano dal bagagliaio franando sui sedili posteriori; parcheggiavano la macchina in un uno spiazzo d’erba accanto alla strada e lontano dalla città come aveva ordinato Teresa, tiravano fuori mezzo a casaccio gonne, pantaloni, giacchette, sandali e stivali e componevano abbinamenti improbabili lasciandoli così sdraiati sul verde, era chiamato il gioco delle bambole invisibili e anche se non si potevano vedere le due donne proprio come due bambine avevano cura di sistemare anche la biancheria nel punto giusto, le mutande dentro i pantaloni o le gonne, i calzini nelle scarpe, i reggiseni e le canottiere infilati dentro i maglioni e le camiciole, e restavano così indaffarate sotto il sole e le urla delle scimmie e dei pappagalli, popolando lo spiazzo erboso di tutto un teatro di esseri invisibili e quasi bidimensionali, un intero circo di clown fantasmi sistemati nelle pose più varie, e se solo qualcuno avesse potuto vedere lo spiazzo dall’alto avrebbe potuto anche apprezzare quella coreografia immobile, a patto naturalmente di ignorarne la macabra origine, ma poi alla fin fine che male c’è a riconoscere la bellezza di una danza macabra quando ce la si trova davanti, e quasi stracci tra gli stracci anche le due donne, senza mai aprire bocca si sdraiavano insieme alle bambole invisibili, ircocervi di persone disparate e rotte e ricombinate, i pantaloni dell’avvocato con la camicetta della ballerina e le mutande del poeta fallito, e in mezzo a loro le due donne restavano sdraiate per ore arroventandosi come vecchi pezzi di cuoio sotto il sole, le grida delle scimmie e dei pappagalli che finivano per intrufolarsi sotto gli stracci prestando la loro voce alle bambole, e le due donne cavavano da quelle grida lunghe e insensate conversazioni in lingue a loro ignote, in russo o in italiano o in tedesco, o lingue non mai nate ma nondimeno plausibili in quello spiazzo d’erba affollato di fantasmi ricombinati uno sull’altro, poi quella delle due che l’aveva in mano tornava ad accendere la radiolina e per esempio “…me l’Avanzo del Teatro Neroniano domestico sul Palatino di Piranesi. Lo spettacolo della morte invade l’impero e corrode le gradinate del teatro casalingo con le sue radicole e le sue erbe e i suoi pastori e i suoi infiniti stracci, come un pensiero formulato sulle soglie del sonno, pensiero i cui archi e le cui colonne abbandonate si fanno ora sostegno per la giungla e il folle terriccio del sogno, il nuovo impero sempre di là da venire, sempre di là dal mare… Le lance cui si appoggiano così tanti personaggi di Piranesi: a che servono? Per guidare le pecore? Sono armi? Aste con cui misurare le distanze e le ombre? Avanzi di un lontanissimo naufragio? Pali da gondolieri esiliati? Non possono che essere utilizzate all’aperto, quale appartamento potrebbe mai contenerle senza creare un enorme incomodo? Esistevano forse apposite rastrelliere cui i viandanti di Piranesi potessero appoggiare le loro pertiche prima di entrare nelle case? Chi possiede quelle lance è forse l’emissario di un impero nomade, l’impero degli architetti dell’invisibile, che scrutando l’aria lungo il filo delle loro aste costruiscono trasparenti città, altari, circhi, teatri e templi in cui nessuno potrebbe mai vivere e nei quali finiscono per perdere il senno? Appoggiato alla sua lancia in un modo che lo fa quasi apparire da quella lancia trafitto, e quasi emergendo da una soglia bianca, da un monto ctonio e bianco al di sotto e al di là del mondo che tutti gli altri direbbero reale, un uomo emerso da quella putredine barbarica che ricopre il teatro di Nerone pare aver disegnate sotto e dietro di sé le zampe di un fauno, come in un’irreparabile infezione della propria ombra, e avvicinandoti al foglio quasi riesci a sentire il brusio di vecchia spinetta dell’impossibile chiacchiericcio di quelle figurine, e dal comignolo della capanna stregata ancora intrisa del sangue della madre di Nerone fatta squartare dal suo stesso figlio che voleva così rivedere il luogo in cui era nato, dal comignolo esce il fumo di bambini assassinati e cotti nel pentolone della Strega del Teatro di Nerone… Ogni strada porta a Roma, bisbigliano le streghe, ma non perché tu debba camminare quella strada per arrivare al teatro sepolto e alla capanna stregata, ma perché liberandone gli strati uno dopo l’altro, sprofondando al di dentro della strada, sfrondandola dall’allucinazione che tutti noi chiamiamo il nostro presente, sotto questa così come sotto ogni altra strada, non importa quanto remota, sia un sentiero azteco che si snoda tra le liane di yagé, una pista di pellerossa, una rotta di corsari malesi o un cammino segreto di bambini che giocano lungo il torrente, scava scava scava e comincerai a sentire il brusio di Roma… e così è, posto che l’anima non è che una strada che si srotola senza alcuna meta, così è per ognuno di noi, e scavando scavando scavando dentro il terriccio che buffamente chiamiamo “noi”, ciascuno di “noi” libererà infine il biancore del marmo di Roma, il tremulo scheletro dell’anima di ciascu–– –Professor Sommariva ci dispiace davvero doverla interrompere in queste preziose divagazioni piranesiane, ma sono appena giunte in studio delle notizie sconvolgenti da Venezia, dove a quanto risulta una serie di esplosioni nella stazione di Santa L––”
Nessuno faceva mai troppo caso a quelle due donne quasi vecchie, sulle soglie di quell’altro tormentato impero di visioni che chiamiamo vecchiaia, mezzo addormentate sui sedili anteriori di una macchina talmente tante volte smontata e rimontata con pezzi di altre automobili che sarebbe stato difficile se non proprio impossibile risalire al modello originale, le varie parti della lamiera colorate di varie sfumature che andavano dal grigio chiaro all’azzurro, i sedili posteriori ingombri di stracci e cianfrusaglie che periodicamente le donne portavano al negozio di vestiti usati sul retro del ristorante Soni Toko Yu, nel quartiere antico di Waltzwaltz, nessuno faceva caso né tantomeno si avvicinava a quelle due donne che anche tra loro non parlavano quasi mai e più che altro ascoltavano la radiolina che ad esempio in questo momento “26 giugno. Quando mi parla, mio figlio sembra spaventato. È normale, immagino, i bambini hanno quasi sempre paura dei vecchi, se non li conoscono. Il signor Morte. Ogni camera ha dei piccoli balconcini, per cui decido di scendere all’ottavo piano per vedere se riesco a farmi calare mio figlio dal vecchio. Quando arrivo al balconcino, trovo il signor Morte che si è già calato, portando con sé mio figlio. È la prima volta che lo vedo. Mio figlio. Non ho tempo di osservarlo con calma: da dietro il vulcano vediamo arrivare una nuova ondata e decidiamo di salire. La scala è sempre più stretta e ricurva, come fossimo nell’intercapedine di una cupola. Il vecchio respira a fatica. Quando siamo quasi arrivati, le pareti sono talmente strette che dobbiamo salire con la testa girata di lato, le punte dei piedi in fuori, quasi come delle figure dell’antico Egitto. Io non ho mai avuto un figlio. La scala porta a una specie di museo. Io e mio figlio siamo ancora in costume da bagno. Il signor Morte presta un frac a mio figlio. Incontriamo una coppia. Lui dev’essere mezzo cieco, perché scambia mio figlio per una bambina. Poi una volta usciti dalla scala vedo la cassa di latta, ed in uno strappo talmente doloroso che è come se il mio corpo venisse catturato da una forza aliena e scaraventato attraverso la parete fino a scotennarsi e a sbriciolarsi nelle più intime fibre torno a ricordare e di colpo è come se qualcuno avesse sgorbiato le pareti del museo e del mio cranio ormai vuoto con la scritta spray The Arsitect was here ––” E forse siamo io e te, aveva gridato Teresa, perché le era tornata in mente quella casa in cui erano entrate a Jakarta, una dall’ingresso principale e l’altra da una delle finestre, come sempre, ma questa volta si erano incontrate e ritrovate una di fronte all’altra senza nessuno nel mezzo da catturare e cui togliere gli stracci, e questo non era mai successo, ma qualcuno doveva per forza esserci, in bagno era ancora sospeso il vapore profumato di una doccia appena fatta, e delle orme ancora umide andavano verso il salone dove le due donne si erano incontrate, sparendo contro il bordo di una specie di bara di latta, vuota, come avevano verificato tirandole una pedata, E forse siamo io e te non smetteva di gridare Teresa, perché le era tornata in mente quell’altra volta nel luna park, quando tutti erano così agitati e persino in lacrime perché gli scoiattoli rosa avevano a quanto pare intrappolato un bambino nei cunicoli di non si sa più quale giostra, e in mezzo alla confusione loro erano entrate nella roulotte di un acrobata e proprio prima di andarsene con i suoi stracci avevano sentito una specie di cigolio venire da sotto il letto, e avvolta tra le pieghe di un frac nero avevano trovato una bambina che indifferente alla distruzione di ogni possibile impero sporgeva i piedi e le mani nel vuoto sopra di lei e sorrideva.

[continua il 22 maggio]

 Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera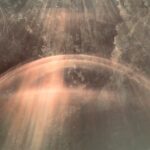 Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 51 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 51 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 55 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 55 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 27
Presiden arsitek/ 27 Got Rhythm?
Got Rhythm? Presiden arsitek/ 33
Presiden arsitek/ 33 Serenata per una costellazione invisibile
Serenata per una costellazione invisibile





















