
La voce poetica di Se la pietra fiorisce di Antonio Prete (Donzelli, 2012) ha nel suo timbro una limpidezza intatta, punto d’arrivo di lunghe consuetudini con la parola. Allo stesso modo della figura che la scandisce, di ragazzo del sud con lo sguardo rivolto a un passato orizzonte, soggetto di saggezza e infanzia tra mediterraneo e mediterraneo.
Vita, amore, poesia. Tre parabole per sperimentare il limite della parola e della lingua. Triade specchiata nella struttura del libro secondo un ordine significativo: Materia d’ombra, Cenere e figura, Rosa mutabilis.
Si tratta, per la prima sezione, di un’indagine intorno alla sostanza stessa dell’esperienza umana: questa vita “materia d’ombra con lampi” o, come avrebbe detto Jabès, “… ombra/che ci mostra il cammino”.
Nei modi, la sezione si apre alla sostanza degli astri, per elevazioni baudelairiane “fino all’orlo di una nuvola/ e ancora più oltre, di là dal cerchio lunare”. Tornano le suggestioni di una saggistica dai toni pazienti, fiorita nell’intenso Trattato della lontananza.
Una curvatura dello sguardo poetico dove la ferita e il dolore vivono inscritti nella nuova geometria “delle ellissi”, di cui questo libro, come un punto d’osservazione privilegiato, si fa costellazione.
E se la violenza potrebbe inaugurare la via all’imperfezione, “l’indifferenza degli astri” osserva dall’alto come un inganno benevolo.
Sennonché una nota più acuta sosta sul prima delle cose: “C’è un alfabeto che modula, insieme,/ il suono dell’origine e il ronzio dell’ape”.
S’insinua il dubbio, affacciato sulla soglia tra l’essere e il non essere, lì dove ciò che splendeva muta di segno divenendo possibilità d’oltremondi. Su questo varco, si dice, può incunearsi la parola, il pensiero.
Prevalgono le figure della notte e dell’addio nella lontananza. Una notte che risplende di caratteri naturali come di ricordanze civili: “la prima stella che trapunge sovrana/ il mantello della lontananza”; e ancora: “nel solco della notte […] quando appariranno laggiù/ le cupole lucenti dell’antica città”.
Il tempo vive nella caduta da lontananze a lontananze: “Dall’origine gettati nel mondo/ siamo respiro del tempo, diceva,/ del suo transito verso l’oltretempo”.
E ancora: “la terra ruota, imperturbata,/ tra le stelle”.
L’incontro della natura e con la natura diviene materia stessa dell’esperienza: “Camminavo una notte sulla strada che porta alla marina: sola luce, quella del pulviscolo stellare”.
È una poesia carica di prodigio, dove la parola sosta spesso sul ciglio della sua negazione se – vero l’insegnamento di Jabès – è “Il Nome, una favilla nella cenere”. Ma non per questo l’io lirico prova risentimenti, il dolore correndo in una vena dilatata, sul dorso di una mano, “un sé neppur tanto/ disperato per quella orfanità”.
L’albero assurge a figura di congiunzione dentro il cerchio azzurro. Come per “la stella che deflagra negli spazi”. E anche la sparizione è un segno. Sebbene non all’insegna della parola, ma dell’enigma del glifo, del “geroglifico”.
L’albero è nelle stagioni, nel marzo che “ha solchi nel verde/e squarci di celeste nelle nubi”. Spoglio, “spalanca le dita/perché il vento accarezzi sulla pelle/ le prime gemme”.
E poi ancora “la notte, in disparte, risvolge/ il mantello che coprirà il mondo”, regione delle costellazioni: Vergine, Leone, Orione nell’inverno. Quindi i nomi di stelle lontane: Sirio, Aldebaran.
Una “materia d’ombra” che chiude in armonia, con “l’albero che freme in pianura, solitario, le braccia spalancate nella sera”. È segno di crocifissione, di dolore muto? No, sulla pagina non c’è spazio per le resistenze dell’io eroico: “risponde allo stormire di foreste montane”, eco di “universale analogia”.
Di qui una seconda parte intitolata Cenere e figura, dove a immagini di erotismo sensibile viene associato il “racconto stellare dell’inizio”. L’armonia è sospesa, i suoni divenuti improvvisamente più duri: “il tempo è sferza d’acqua,/ amore d’acqua che sbalza le forme,/ azzurro che deflagra penetrando”.
Sentito come una piccola violenza nel quadro d’armonia, l’amore si condensa in figure sillabiche a forte concentrazione consonantica: “sco”, “sfe”, “sba”, fla”, gra”, “an-fra”, “fru-ga”, “spa”.
Quanto è reale questo amore, ci si chiederebbe, se risulta associato alla cenere? Se “paiono venature di una foglia/ […]/ quelle che furono figure di un amore”?
È dunque il sentimento del femminile “il fiore della vita/ e la sua irrimediabile ferita”? Un’armonia d’ombra attraversa l’ulteriore interrogazione: “è davvero incenerita quella che fu/ febbre d’abbracci, ebbrezza di calda/ prossimità?”.
Qui il femminile e il suo ricordo si velano. Come in Partenza, dove la madre al cancello, “buganvillea” renitente, testimonia la perdita della terra, del cielo, del colore e, nello stesso tempo, la sua reviviscenza. Così che il fanciullo, raccolta una pietra in riva al mare, simbolo di femminilità dispersa, marmorizzata e custodita accanto al foglio bianco, alla luce della lampada, può assistere al prodigio della sua materia vivente, respiro di silenzi.
Figura femminile, madre e sud, terra di “incantamento” e di “ferita”, come “grido dell’infanzia” che, spegnendosi al limite dei suoi confini, si mescola a quello dei migranti, delle vittime delle guerre democratiche, sulle sponde dei mediterranei.
Infine l’ultima sezione, Rosa mutabilis, giocata da subito nella verticalità del precedente Menhir, opera al nero costellata di dolmen come allusioni ad astri apparentemente immobili. C’è una consuetudine del cielo, nella poesia di Antonio Prete. Questo non significa però che ci si trovi dinnanzi all’esperienza di un’ascesi, di una potente configurazione mistica. Perché il rapporto con la volta celeste, “mantello di lontananza”, è figlio di una vertigine piccola, familiare. Sarà il viaggiatore, colui che cammina, come già in Leopardi, a farne esperienza cogliendone il fiore. In questo vivendo della sua saggezza.
Dalla terra al cielo, dunque: “il fiato della terra la dischiude/ al brivido di fragilità e vertigine, e il cielo/ frugando nel suo cuore,/ la fa pensosa del mondo,/ della sua follia,// mutabilis rosa, poesia.”
Sennonché il momento della poesia è nel prima, “nell’attesa paziente della forma”. Perché “forse soltanto in questa incerta vigilia/ la poesia sfiora, tremando, verità e bellezza”.
E il tema del tempo, in quest’ultima sezione, gioca per variazioni tra la lirica Rispondenze, dove vive in accordo analogico tra l’umano e il naturale, e l’altra, Il tempo in Bach, dove si trasforma nella possibilità stessa di dar corpo a ciò che è assente. Finché in Crepuscolo, “il celeste nelle mani della sera/ si traveste d’eternità”.
Una saggezza prima del tempo ma senza la grandezza patetica e solenne del sacrificio. Tanto che il componimento dal titolo Suite temporale ne disegna la trama, nonostante o forse proprio a causa della ciclicità delle stagioni, come una sostanza immobile ma attiva, già annunciata ne Il tempo in Bach: “il tempo è quieta forma/ di tutto quello che da sempre è assente”.
Si tratta di un’esperienza vissuta attraverso la trasfigurazione del vento: “vento privo di voce” ma che “ascoltava/ le voci dei sogni”. Luogo dove la “poesia è forse più vicina/ al respiro dell’albero”. Una “sostanza che è già ombra di sostanza”. Fino a farsi soggetto di predicati significativi, fiammeggianti: “trascorre tempo”, “dorme tempo”, “agisce tempo”, “tempo sventaglia”, “tempo racconta”, “lampeggia tempo”. Compiendosi in un’ultima interrogazione: “È l’infinito l’assillo del tempo?”.
Finché in Sul silenzio diventa il sogno stesso della poesia, il desiderio di “scorgere nel cristallo della parola / il lampo dell’accadere e il suo vanire”; anche se si è consapevoli che ciò che resta è solo “l’azzardo della lingua e la sua impotenza”.
Sennonché troppo forte è la fiducia nella poesia. Una poesia che si gioca al di là della parola stessa. Sia essa “disadorna o sontuosa”, oltre la lingua o, come si intuisce in un varco di luce, prima della lingua. A contatto con un’essenza che lega l’albero e il vento, la pietra e il fiore. Per dar corpo al cuore di questo libro tra desiderio dell’origine e avventura nel presente.
Non si tratta di un percorso a ritroso in vista di una consolazione materna, perché “il dolore non attenua il suo grido: / solo lo eleva fino / alla deflagrazione della stella”. È assunzione del prima, essenza che lega tra loro fenomeni e creature, compreso il dolore e il sacrificio del vivere, in grado di trasfigurare la materia poetica di questo Se la pietra fiorisce.
Prete cerca spesso le figure interrotte da poter ricongiungere a un inizio. Ma senza forzature, accogliendole nel loro sogno di continuità, come un filo d’acqua piovana “privo di sorgente, / privo d’approdo” o “un ciuffo d’erba / tenera, che un monticello di sassi / interrompe”.
A tratti, come in Pioggia, questa propensione per l’essenza delle cose, per il loro spirito originario, provoca uno sprofondamento nell’indistinto, dove gli stessi nomi delle piante sono inghiottiti in un’unica essenza di “verde”; e persino il vento “cancella la linea dei poggi” ogni cosa ricadendo nel vortice “di nubilose sfigurate parvenze”.
Di qui ogni ripartenza, ripercorrendo le pagine della memoria. Come se solo il ricordo di una fanciullezza lontana, sul limitare orientale affollato di luce, potesse aiutare a risalire “verso l’alba d’un suono”, sperando nella “promessa della parola”. “Il battito di un tempo che è prima della lingua” verso “la musica di un senso che si perde appena pronunciato”. Perché è l’ombra “di quel che è assente a far fiorire, ogni giorno, la lingua”.
E la realtà che appare all’occhio è allora “geometria del visibile” se il “velo oscuro” congiunge “paesaggio e bellezza”.
La fiducia nella lingua e nella parola non è mai acquiescenza alle forme del bello, alle figure che si scolpiscono una volta per tutte. La parola segue una sua mobilità imprevista, parla per altri cori, si fa soggetto di altre istanze puntando ogni sua acquisizione in un nuovo azzardo, in vista di un’analogia improvvisa. Affinità che sprofondano, di solito, verso l’alto, dove a cenni di richiamo rispondono costellazioni che hanno rinunciato a ogni solennità. C’è una temperanza, infatti, nella poesia di Antonio Prete che supera i vani tentativi di separazione delle cose dalle loro forme. Una poesia che imita la vibrazione, la polvere invisibile, la “filigrana dell’apparire”.
Per Antonio Prete la bellezza è legame, ed ha come suo fondamento una “percezione unica, armoniosa” capace di cogliere il racconto del fiume fatto di “cieli e lune, balzi d’anse,/ mulini e sconfinamenti”. Non si tratta solo di un ricordo della natura divenuto vivo; la parola o, meglio, la poesia, è essa stessa potenza d’impulsi naturali se “basta salire in cima a un verso / per vedere la distesa del mare”.
Testimonianza ne è l’ultima lirica della sezione, Màtrima, lu ientu, in cui la consustanzialità di dialetto (come lingua delle origini), madre ed elementi è portata alle sue estreme conseguenze. Se la pietra fiorirà, infatti, sarà solo perché “l’ombra sa ascoltare il respiro del fossile”.
Con questa fiducia, crediamo, occorrerà leggere ancora oggi, come un tempo, un’opera di poesia.

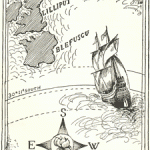 Le Voyage - Antonio Prete
Le Voyage - Antonio Prete Luna nera - Antonio Prete
Luna nera - Antonio Prete Ricordando Pascal Gabellone - Antonio Prete
Ricordando Pascal Gabellone - Antonio Prete Giacomo Leopardi e la luna salentina - Antonio Prete
Giacomo Leopardi e la luna salentina - Antonio Prete Il libro esperienza
Il libro esperienza Ettore Frani: verso l’esperienza del mistero e delle sue intuizioni
Ettore Frani: verso l’esperienza del mistero e delle sue intuizioni





















