
Conosco bene una ragazza del Senegal. Viene da uno di questi villaggi sereni, scanditi da luce e ombra, suoni, voci, vento e sabbia rossa. Le donne con i bambini legati da sempre dietro la schiena e gli uomini chini da sempre sulle zolle aspre. Il fiume che corre poco lontano e le mangrovie che frugano stancamente con le radici nell’acqua torbida.
È venuta a lavorare qui in America, fra i bianchi stressati e pallidi. Pieni di paure e di rimpianti. Pieni di strane domande su tutto quello che ci si può domandare. I bianchi buffi, che vogliono sempre sapere che succede, e perché e come fare a farlo succedere ancora se gli piace o non farlo succedere più se non lo vogliono. SI preoccupano delle malattie che scivolano insidiose fra i respiri dell’aria cittadina. Delle malattie che il loro stesso maligno corpo si mette a inventare per farli soffrire, imbruttire e crepare. Ribellioni, ribellioni e scontentezze. Terreno che sfugge sotto i piedi e i bianchi lì a pensare di poterci fare qualcosa, contro questo scivolare del terreno sotto i piedi, si aggrappano, sudano, si disperano e bestemmiano.
Tentando di fermarlo, di costruire prolunghe, salvagenti, ponti… che buffi.
A me mi viene spesso da pensare come fa una come lei, che aveva il passo lento e lo sguardo vago. Lei che aveva la serenità del vento fra i baobab. Come ha potuto, con cosa ha scambiato la sua condizione? Per la paga che i bianchi le danno, per questi quattro soldi, diceva sempre quello, e questa gloria da stronzi. Lei tornerà al villaggio coperta di gloria, fra qualche anno. Coperta di esperienze che i suoi, fra i baobab hanno solo sentito raccontare, tessere sui fili dei discorsi passati di mano la sera sotto lo scintillio infinito del cielo africano. I racconti su come i bianchi hanno questo e hanno quello. Hanno case grandi enormi e ci vivono da soli. Hanno macchine, ce ne hanno tante, una per uno, e ci vanno a spasso anche dove potrebbero camminare. Hanno la televisione, ne hanno più di una. Una in ogni stanza perché ognuno se la guarda da solo. Hanno i computer e le radio, le macchine per lavare i panni e quelle per lavare le stoviglie. Hanno medicine e tanti dottori e ospedali enormi grandi come città e quando ti ammali ti portano lì e esci guarito. Hanno soldi e soldi e soldi e non li dividono con nessuno perché sono egoisti e cattivi. Ognuno di loro è tanto ricco e si tiene i suoi soldi per sé, stretti e tanti tutti intorno finché crepa e allora li deve lasciare per forza a qualcuno. Hanno cibo finché gli va e anche di più. Hanno tanto cibo che ci devono stare attenti e fare la dieta, perché di cibo ci crescono e ci ingrossano, ci ingrassano e si ammalano. Hanno cibo a casa e nei ristoranti, nei bar, nei negozi, per la strada. Cibo di tutti i paesi, cibo anche africano, che trabocca, trasuda dai loro corpi pieni di cibo fra i pori della pelle mentre corrono e corrono per smaltirlo via. Tutto quel cibo.
Gli africani con le loro pelli dure. I loro corpi asciutti. I muscoli lunghi e tesi sotto il vento brillante di luce. La sabbia a coprire i pori e velare i capelli. Sottile sabbia leggera che si infila fra le ciglia e i vestiti. Come un borotalco dei poveri.
Perché partono, vengono qui? Perché?
Ti si affligge il cervello non poco su questa questione. Perché l’uomo insegue da sempre questo miraggio vago che gli trema davanti dalla notte dei tempi. Che lo fa sforzare, lavorare, tramortirsi di aspettative e paure pur di crescere, ingegnarsi, trasformare quello che ha intorno e andare avanti, inventare, impaurirsi e superare. Lacune, spazi, misteri. Via hop là. Un salto e andiamo oltre. Ma tanto c’è un altro ostacolo più avanti, chi te lo fa fare? E mentre corri e salti diventi sempre più è pallido e stressato e stanco. Fermati, per l’amor di te stesso, fermati! Stai ad ascoltare il tempo che passa e le voci, senti il vento che scorre e solo quello e il sangue che pulsa, finché pulsa. Osserva, procedi lento e guarda cosa hai davanti!
Eppure.
Nessuno si è mai fermato. Nessuno si è seduto davanti all’ostacolo. Nessuno si accontenta di vagare per il grande mondo con il passo lento, guardandosi intorno. Neppure le donne dei villaggi senegalesi, se possono. Se possono se ne vanno a stressarsi e ingrassare fra gli uomini pallidi.
Perché?
Forse dovevamo nascere con le zanne. E gli artigli. O con una mole grossa. O Col cervello così piccolo da saper correre via davanti al predatore solo dopo aver annusato il suo odore. Non un minuto prima, non un minuto dopo. Oppure con braccia molto lunghe per penzolarci dai rami e osservare il mondo che oscilla. O fatti di gelatina velenosa, che nessuno ci può mangiare perché poi muore.
Ma invece siamo su questa terra con poche unghie fragili e pelli delicate e allettanti. Con denti ridicoli e gambe goffe.Non siamo discesi da una scimmia qualunque, no. Quelle non si sono mica evolute, andavano bene così com’erano. Infatti sono ancora lì appese ai rami che si grattano la pancia e ci ghignano in faccia.
Noi dovevamo essere una sottospecie particolarmente inetta a stare sugli alberi. Forse avevamo una forma congenita di scoliosi che ci rendeva inetti a arrampicarci. O forse una malformazione alle orecchie ci dava la labirintite cronica e cascavamo giù dagli alberi come pere. Magari invece soffrivamo tutti di alopecia e guardavamo con invidia i fitti mantelli delle nostre consorelle mentre noi avevamo queste chiazze nude e esposte su cui rivolava l’acqua ghiaccia dei monsoni. O magari soffrivamo di piorrea acuta. Tutti, anche i piccoli neonati di uomini primitivi, Già mentre succhiavano il latte c’avevano questo problema delle gengive retrattili e succhiavano male il latte, crescevano brutti e gracilini. E per sommo della congiura cosmica non è che avevamo un cervello minuscolo come quello della gazzella. Noi, in mezzo alle erbe alte della savana ci camminavamo già con le budella strette di paura, guardandoci intorno e senza poterci fare niente, se arrivava il predatore. Lei, quella maliarda della gazzella, se ne stava lì con l’occhione sgranato a biascicare l’erbetta, tranquilla, e noi acquattati a tremare, mentre frugavamo fra gli sterpi a cercare semini commestibili. Che andassero bene per quelle poche gengive che avevamo, mentre la schiena scoliotica ci doleva, da tutto quello stare chinati, e ci girava un po’ la testa per via della labirintite. Ci grattavamo la pelle scoperta bruciata dal sole a e frugavamo il terreno spezzandoci le unghiette fragili e sapevamo, intanto, che il vento della savana spandeva qua e là il nostro odore tenero e lo portava fino alle narici di un qualche predatore. La gazzella, lei anche aveva un buon odore e se lo lasciava catturare dal vento e portare in giro, da quel vento mezzano, fino a un grande predatore cattivo. Che forse la stava già guatando, di fra le alte erbe della savana. Appiattito contro il terreno con i muscoli tirati fino a creare torciglioni di spasimi sulla pelle. E poi ecco, il predatore sceglie la sua preda, molla tutto e si lancia. L’uomo primitivo e la gazzella, si voltano e lo vedono nello stesso istante, lo vedono saettare verso di loro. Ma mentre la gazzella fino a un istante prima era tranquilla e si assaporava l’erba lunga della savana, l’uomo era già tutto tremante e sudato, e si spezzava quelle poche fragili unghie che aveva per far presto a scavare i suoi miseri semini dalla terra.
Il predatore balza rapido fra l’erba, saetta e si avventa. La gazzella in un tuffo di cuore ha già tutto il corpo in fuga, e il cervello, con tutti i sensi insieme galoppano via e sanno dove andare, con che velocità, come gli fosse comparsa davanti agli occhi, una via di fuga disegnata dall’istinto la spinge lontano e veloce, a balzi lunghi e precisi, calibrati, zig zag imprendibili, via, lontano dal predatore, in un altro punto della savana. E poi la via scompare, all’improvviso. E il cuore si acquieta, di colpo. Non c’è più pericolo di zampate veloci sul terreno. Di odore aspro di inseguimento dietro di lei. L’istinto le si sopisce e si mette in attesa. E lei scrolla la testa e sbatte gli occhioni, zampetta lenta fra l’erba.
L’uomo primitivo è lì, con i suoi semini stretti nella mano polverosa. Ha osservato la scena e si è bloccato. Anche lui ha un istinto, certo. E l’istinto gli dice che deve prendere quelle sue gambe stortignaccole e corte e mettersele in spalla, sopra la schiena curva e fragile, e correre con quanto fiato c’ha in gola verso…. Verso niente. Gli dice il cervello grande e sviluppato. Verso niente, povero disperato che non sei altro. Il predatore ti vedrà e correrà e ti raggiungerà ovunque. Quanto puoi correre? Fino a dove? Su un albero? Ci si arrampicherà più veloce di te. Nell’acqua? Affogherai prima di lui. In una tana nel terreno? Ti ci incastrerai, brutto culone storpio che non sei altro, e resterai con le natiche all’aria a farti dare il primo morso proprio dove fa più male.
La gazzella scatta via una mosca con il piccolo orecchio, china placida la testa e riprende a brucare.
L’uomo vede l’erba ondeggiare poco più avanti a lui. Sente che il predatore ringhia sottovoce. Non ha bisogno di nascondersi all’uomo primitivo. Sa che non può scappargli, è una preda facile. Il predatore si avvicina e l’uomo non riesce più a inghiottire, stringe ancora i semini in mano e li stringe tanto da conficcarsi le poche fragili unghie nel palmo. Suda e geme e si guarda in giro. Almeno ci fossero altri uomini primitivi… lo sa, che non servirebbe, ma sa che gli piacerebbe di più se ci fossero. Gli piacerebbe morirgli davanti. Ma così, solo, davanti al predatore… Il predatore sente l’odore di paura dell’uomo primitivo e si avvicina ancora, ronza di soddisfazione con la gola e si acquatta, la pancia agile contro il terreno duro. Ogni muscolo teso da attorcigliare la carne sopra. La coda appena sollevata a fremere nell’aria immobile. Ed ecco che scatta, il predatore e si lancia, rapido come uno scroscio e fragoroso ruggendo di vittoria si avventa e balza sull’uomo primitivo, rannicchiato in terra e tremante di paura.
L’uomo primitivo lo vede e lo sente, lo teme e gli sgrana tutti gli occhi spaventati addosso… poi afferra una grossa pietra, la stringe al posto dei semini e con la mano indurita dal terrore e i muscoli che si tendono e fanno attorcigliare la pelle dallo sforzo, con i pochi peli ritti di paura e di rabbia l’uomo primitivo scaglia la sua grossa pietra contro il muso del predatore. E lo ammazza.
Io guardo la scena, dallo sprofondo dei millenni e delle ere dopo. Guardo la scena e mi si strizza il cuore. Vorrei andare lì. vorrei andare da quell’uomo primitivo trionfante, che stringe la pietra nella mano e ogni tanto la guarda, incredulo e grato. La guarda, la stringe, e poi guarda il predatore con la testa fracassata lì ai suoi piedi e caccia un urlo, un urlo che non gli era mai uscito dalla gola. E poi si guarda intorno e vede di lontano qualche altro uomo primitivo che si è alzato sulla punta dei piedi stortignaccoli per capire che è quel’urlo che non aveva mai sentito prima e vede il nostro tutto bello gonfio e soddisfatto, che si è messo in piedi sulla carcassa ancora calda del grande predatore per farsi vedere meglio e grida ancora e agita in aria la pietra perché tutti la vedano e comincino a correre da quella parte.
Io lo prendo dolcemente per un avambraccio, quel’uomo primitivo orgoglioso da scoppiare e lo tiro giù dalla carcassa, che gli devo parlare con calma e mi dà noia che lui stia lassù a sventolare il sasso in aria. Allora lo tiro giù e lo calmo, cerco anche di prendergli la pietra ma quello tira indietro la mano e fa la faccia brutta: se non sto attento, dice quella faccia, faccio la fine del grosso predatore cattivo. Io allora lascio perdere la pietra e con uno sforzo sovrumano gli spiego con i gesti quello che le sue povere orecchie labirintitiche non potrebbero mai capire: gli dico che la deve buttare, quella pietra, perché da lì vengono tutti i suoi guai e quelli di tutte le generazioni a venire. Giù, giù nello sprofondo dei tempi fino a epoche e luoghi e uomini che lui nemmeno può immaginare ma che esisteranno davvero, per certo, dopo di lui e che lui ha condannato, con quella pietra, a essere infelici infelicissimi per tutta la loro misera esistenza. Gli spiego che deve stare tranquillo a raspare la polvere, a cercarsi si suoi semini. E che è inutile che acchiappi la prima pietra che trova, tanto ci sarà sempre un predatore ad aspettarlo, nell’ombra dell’erba, e se non un predatore un serpente, e se non un serpente una diarrea o la siccità, l’avanzamento della piorrea, un colpo al cuore, una piaga infetta…
Insomma gli spiego che per il bene suo e di tutta l’umanità a venire lui adesso deve buttare via quella pietra e non farla mai vedere a nessuno. Deve starsene d’ora in poi a raspare semini col cuore in pace, concentrandosi sul suo respiro e sul colore delle foglie intorno e sulla sensazione della terra sotto i suoi piedi. Deve starsene lì, pensando e non pensando, senza idee nella zucca e senza paure nella pancia. Tanto, gli spiego a gesti, che tu ti stressi o meno, che tu pianifichi e preveda, che tu ti metta a saltare tutti gli ostacoli lungo il cammino o meno ci sarà sempre un predatore in agguato, per te. E prima o poi il grande predatore nero ti porterà via, a te e tutti i discendenti tuoi.
Lo vedo che apre la bocca e sgrana gli occhi, l’uomo primitivo. Poi corruga i folti sopracciglioni scuri e si gratta gli ispidi capelli sulla testa. Corruccia la fronte e stringe gli occhi. Sta pensando, mi dico. E penso che forse ce l’ho fatta, forse ho salvato l’umanità da tutta la sofferenza dei millenni e delle ere a venire…
Poi l’uomo primitivo mi fissa con l’occhio maligno, la bocca gli si apre, larga e fonda e mentre la gola gli raschia di quella che è forse la prima risata del mondo lui solleva le braccia tozze polverose. Le solleva in aria, prende lo slancio e mi fa un poderoso gesto dell’ombrello. Io arretro e allibisco. Ma… lo conosce?
Lo conosce, lo conosce. E poi, siccome si diverte a vedere la mia faccia perplessa e imbarazzata, si mette le grosse manone pelose sulle chiappe rugose e ci batte sopra dei clap clap rumorosi.
Alloraio me ne torno indietro, anzi in avanti, nel tempo. Mi siedo buona buona a guardare la gente che si stressa e suda e si impegna. Che teme, pianifica e spera. E mi viene una triste rassegnazione e anche l’inizio di una risata. Che pensavo? Che era scemo? Ce l’ha anche lui un istinto ma un istinto che non gli fa vedere vie di fuga come alla gazzella. Un istinto loffio, povero, inefficiente. Che gli dice solo di sopravvivere, e di farlo il più a lungo possibile. E cosa si può contro l’istinto? Si può dire ad un uomo di accontentarsi, di lasciarsi andare, di non prevedere le necessità in arrivo, di non armarsi contro i pericoli futuri? O di non rimpiangere i passi falsi? O di non invidiare il vicino più ricco?
Scuoto la testa, per rispondermi da sola. E riapro con pazienza uno dei tanti tomi di filosofia orientale. Mi accendo gli incensi. Cerco di dimenticare il predatore che mi si annida vicino, mi siedo per ore ed ore ed ore. E riesco per qualche secondo di grazia a sentire solo il mio respiro, e il terreno sotto i piedi. L’aria che entra ed esce dal naso, l’erba alta intorno…
La neve è venuta e andata.
L’abbiamo aspettata tanto… per mesi ci siamo preparati, noi e tutta la città di Washington, per questo evento che può essere molto fastidioso, a volte catastrofico. Accumuli davanti alle porte, strade bloccate, ghiacci infidi, anche rotte e nasi blu.
Allora ci siamo letti i cartelli stradali, dove si può mettere e dove no l’auto in caso di neve. E ci siamo letti le istruzioni delle scuole, cosa fare e dove informarsi in caso di precipitazioni. E ci siamo comprati pale di ogni tipo per spalare. Più grande per il papà, più piccola per la mamma e più piccola ancora per quello dei tre figli che avrà forse, una volta, un po’ voglia di aiutare. Così attrezzati , sentendoci un po’ come la famiglia di orsetti di riccioli d’oro, ci siamo messi ad aspettare. Con la legna accatastata in garage e scorte di cibo nella cantina. L’anno passato siamo stati bloccati , in casa tre giorni, ci hanno detto. Anche quattro, ci hanno ribattuto. E io ho aggiunto un po’ di pelati, agli acquisiti, e pasta e grana congelato. Sia mai che stiamo tre giorni senza spaghetti…
Gli scarponi c’erano, le maglie termiche anche. Cappelli avanzati dalle settimane di sci degli anni passati e guanti e calzettoni spessi. Abbiamo cominciato a usarli anche prima della neve, certo. Perché per noi con i delicati zefiri del mediterraneo nei cromosomi appena la temperatura è scesa sotto lo zero non c’era speranza: neve o non neve dovevamo girare come la pubblicità progresso contro il raffreddore. Non che fossimo soli. C’è questa cosa bella, qui, che non sei mai l’unico. Sai quanti immigranti da climi molto più caldi? Sai quanta gente che se ne infischia dell’estetica? E quanti ipocondriaci? Pieno. Quindi camminiamo fra gente col colbacco, gente con cappelli peruviani che pendono sulle guance, gente con l’ultimo modello hi-tech contro il freddo. E non ci sentiamo mai strani. Nemmeno quando ci passano vicino rari esemplari in camicia. A volte, ci sono. Anche se, per lo più, sono i vicini di casa tedeschi che resistono stoicamente al freddo, con le facce pallide.
Attrezzati di fuori e con un senso di epifania dentro ci mettiamo in attesa dell’evento.
La temperatura scende e scende. Taglia il respiro, il freddo, ghiaccia gli occhi e l’aria del naso. Respiriamo acute scaglie di vento e aspettiamo. Il cielo si fa basso e greve, a volte. Grigio e agitato sopra lo strato vicino a noi. Un ventre grigio che matura le perturbazioni, si vede ad occhio nudo.
E gli alberi non hanno più ricordi di foglie. Stanno spogli e chiari a lanciare i tronchi verso il cielo grigio. Dormono, si vede. E dorme tutto quello che gli zampettava intorno. Sono spariti gli scoiattoli, le lepri, i cucù e le volpi. C’è molto silenzio, intorno ai tronchi e il terreno nudo dove le foglie macerate si sono assimilate alla terra e fanno un suolo duro e ghiaccio che non attutisce più i passi. Le casette anche sembra che si siano messe zitte. Perché tutto tace intorno a loro e sembra che abbiano perso la voce anche le loro finestre chiuse, le loro porte senza decorazioni, il loro giardini gialli di erba bruciata dal gelo e grigi di rami spogli. Il cielo greve, sopra, passa e ripassa le nubi gonfie e basse, turbinanti di perturbazioni, su nelle alte sfere.
Poi, una sera, una luce che si spande dappertutto. Il cielo ancora più basso e chiaro, quasi una nebbia densa e altissima sopra gli alberi e le case. E il riverbero di quella luce riflessa che prolunga il crepuscolo, quasi ci volesse fare un piacere. Il silenzio è come denso, stasera. E il freddo è quasi gradevole. Domani nevicherà, sentenzio io ai miei bimbi. O forse anche stanotte. L’emozione ci ammutolisce tutti, mentre entriamo in casa.
E infatti di notte iniziano a piovere fiocchi piccoli e veloci di neve. Una sferzata di ghiaccio giù dal cielo che imbianca qua e là e niente più. Facce deluse, scuole aperte in ritardo, intoppi nel traffico e niente più. Il ghiaccio soltanto, trionfa sui vialetti e i gradini, sui marciapiedi e in fondo alle grondaie. Sghignazza infido dove meno te lo aspetti e ti fa battere il culo quando ti distrai per un secondo dalla sua esistenza.
Abbiamo tutti un po’ un senso di perdita, di questa neve breve. Due, tre nevischiate misere, che creano solo fastidi. Questo c’era anche in Italia! Ci diciamo, un po’ arrabbiati. Mettiamo via le pale e ci imbronciamo dentro.
Però, una sera, la solita nevischiatina non passa dopo poco. Prosegue insistente e punge la terra con aghi sempre più bianchi, sempre più grossi e più lenti di neve. Poi smette di piovere e scende. La neve cala e si avvolge, turbina, si confonde davanti ai fari di luce delle lampade del giardino. Davanti al lampione della strada. Forse questa volta è la volta buona, dico. E infatti dopo pochi minuti davanti alla casa non c’è più un giardino, non c’è più una strada fra le case e non c’è più un vialetto davanti alla porta. Davanti al garage non c’è più accesso. Ritiro fuori la pala della misura mamma, mi imbacucco meglio di James Cook al polo e impiego buona ora e mezzo della sera a liberare l’accesso per il rientro di papà orso.
La mattina alle cinque la scuola comunica che resterà chiusa. Mi affaccio e vedo sulla ringhiera del terrazzo uno strato alto come due mani di neve. E la neve che viene ancora giù come avesse appena iniziato. Mi metto sotto le coperte con un brivido e un sorriso di non so quale contentezza.
E iniziano giornate così, di gioia pura nel vedere il mondo bianco intorno. Il silenzio che rimbomba sulle orecchie e il cielo a volte bianco, a volte azzurro. La neve che giace senza luce o che scintilla di sole. Le case e le auto, i giardini, le palizzate e gli alberi sotto un telo informe e puro. Annullate le differenze, annullato tutto. Rimane solo di camminarci in mezzo, a questo strato di uguaglianza, e affondarci i piedi e sentire scricchiolare il peso mentre va giù, e schiaccia la neve.
E poi la soddisfazione dei bimbi, che gongolano nel calduccio dei letti sapendo che quello doveva essere un giorno fra i banchi e invece sarà un giorno a casa, a fare solo quello che si ha voglia di fare, un paio di amici, forse, che vengono a trovarci camminando a fondo nella neve, per trascorrere insieme le lunghe ore buie del pomeriggio. Io mi godo la loro felicità e mi metto a scrivere tranquilla, nel caldo della mia stanza, mentre fuori, nel buio, c’è lo strato uguale e candido su tutto, a farci vivere sereni, al caldo, in casa.
“Cosa??!! Ma non avete avuto il black out voi?” Le voci degli amici tremano, incredule. E così mi incuriosisco e sbircio e scopro dai giornali che mentre noi ce ne stavamo a goderci il caldo tranquillo dei pomeriggi lunghi e bui interi quartieri di Washington e dintorni sono rimasti senza luce, senza riscaldamento, senza frigo e senza acqua calda. Bivaccate per giorni intorno ai caminetti, intere famiglie a intirizzirsi e illividirsi di rabbia contro la società elettrica, che li ha abbandonati al proprio destino.
Di nuovo quei cavi che penzolano bassi, fra i rami degli alberi, ovunque. Basta un colpo di vento, una pioggia violenta, una nevicata più forte per strapparli dai pali, gettarli sui marciapiedi o le corsie della strada.
E traffico bloccato, ingorghi, raffreddori. Bimbi a casa da scuola infilati nei caminetti come piccole fiammiferaie dei giorni nostri.
Noi, caldi, pasciuti e sereni, ce ne andiamo a comprare un set di slittini. Di varie misure, perché ormai ci piace giocare agli orsetti. E giù per le discese dietro casa, a gonfiarci veloci le guance di aria fredda e di spruzzi pungenti. Rotoloni , ansimi, grida e sghignazzi. “Dàai, vediamo chi arriva prima!” E poi su, indeboliti dalle risate mentre affondiamo nella salita. Ci pieghiamo, spezziamo il fiato, ci spingiamo e risaliamo sempre gridando e ridendo, sguaiati di felicità.
Poi mi guardo intorno e vedo altri bambini, a parte i miei. Che scivolano composti giù per i piccoli dirupi, poi si alzano, prendono in mano la cordicella e si mettono pazienti a risalire la discesa, con un delicato suono frusciante dietro.
Noi, soliti italiani caciaroni, abbiamo fatto tremare i vetri di tutte le case intorno con i nostri versi esagerati. Penso per un momento di dover intervenire, di imporre un po’ più di compostezza, che diamine! Vogliamo farci riconoscere ovunque? Poi il mio piccolino mi sfida e si lancia. “Arrivo prima io, culona!” Io mi getto sullo slittino, mi spingo avanti con le mani e mi lancio all’inseguimento in un lunghissimo grido giù per la scarpata.
Pochi giorni dopo, tutto è finito.
Ha un po’ piovuto. Una pioggia ghiacciata che non ha sciolto la neve, non l’ha alimentata. Ha solo creato pozze di ghiaccio negli anfratti bui delle strade. Poi il sole, e la temperatura che sale. E la neve che si scioglie e perde il suo strato di uniformità sulle cose. Tutto ridiventa quel che era prima. Come nella fiaba di cenerentola. Ogni cosa al suo posto, niente è più nascosto, niente è più uguale a tutto il resto. E con le strade che sono di nuovo strade e bordi e giardinetti e siepi spoglie, panchine, alberelli grigi, altalene abbandonate al vento, i bambini tornano a scuola, l’elettricità ce l’hanno tutti.
Le giornate crescono, i pomeriggi sono sempre più striati verso la luce, adesso. Ogni giorno un po’.
Fa una strana impressione, il mondo d’inverno con la luce lunga del pomeriggio. Non c’è traccia di primavera, ancora, solo più luce a illuminare la natura morta. Gli stessi tronchi grigi. Gli stessi rami ritti verso il cielo. Gli stessi colori smorti sulle foglie dei sempreverde.
E la luce quasi impietosa che rivela tutto, lo scandaglia, lo addita. Guarda questa pietra piena di muschio! Dice. Guarda quel rivoletto ghiacciato, guarda quel mucchio di neve annerita, quei fili di erba bruciata dal gelo!
La neve è venuta e andata, e io mi sento di nuovo scoperta, me stessa, in piena luce.
(II – Fine)
Vai a Cronache americane /1

 La prima volta che ho letto una lapide - Francesca Andreini
La prima volta che ho letto una lapide - Francesca Andreini Cronache americane / 3 - Francesca Andreini
Cronache americane / 3 - Francesca Andreini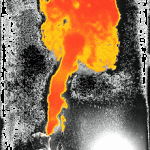 Gino/ 21 - Francesca Andreini
Gino/ 21 - Francesca Andreini La prima volta che ho abitato in cielo - Francesca Andreini
La prima volta che ho abitato in cielo - Francesca Andreini La prima volta che ho partecipato a una riunione di contea
La prima volta che ho partecipato a una riunione di contea La prima volta che ho capito l’inno americano
La prima volta che ho capito l’inno americano Armate notturne
Armate notturne





















