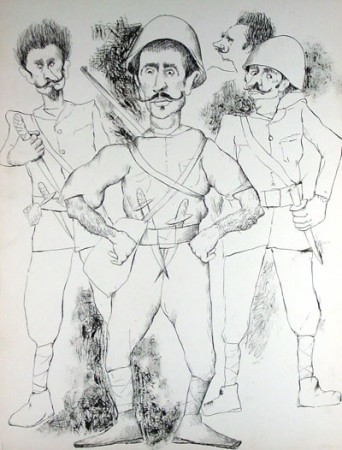
Essi sono sempre in ritardo di un anno, di una annata, di un’idea”.
Rivarol
Tutti lo sanno, ormai, che il conte di Cavour, sul letto di morte, esclamava: «Abbiamo fatto abbastanza, noialtri: abbiamo fatto l’Italia, sì, l’Italia: ‘e la cosa va’…».
«La cosa va»: in quelle tre parole, a pensarci su, a ripetersele col tono di voce di chi sta per rendere l’anima a Dio, c’è un ottimismo contenuto che non persuade, che resta lì, a mezz’aria, a dirci che il povero conte di fiducia non ne aveva troppa nelle nostre capacità di tener in piedi l’Italia. Sì: «la cosa va». È sempre andata dalla morte del conte; la cosa «va» ancora… Ma è una «cosa» misteriosa, una misteriosa cosa «che va», e non se ne sa il perché. Tutto quel che a noi sembra falso e provvisorio, tutto quel gran correre avanti e indietro senza precisi scopi, tutto il disordine e l’arruffiio, tutto il fare e il disfare, tutte le affannose e inutili e ridicole e patetiche contraddizioni che accadono in Italia, forse ci sono indispensabili; forse noi non riusciamo a scoprire il segreto senso che promuove e alimenta la vita italiana. Ma è pur vero che a guardarsi attorno c’è da chiedersi: «Come mai funziona la luce elettrica? Come mai qualcuno ancora si preoccupa di accenderla? E perché mai lo spazzino raccoglie le foglie secche nei viali? E perché la maestra non insegna agli alunni di uccidere i compagni? E perché l’operaio non fa la rivoluzione? E perché ancora c’è chi dice: ‘Prego, signore’?». La risposta a tutto ciò è ancora quella di Cavour: «la cosa va». E «va» perché è sempre «andata»; perché una cosa che seguita ad andare avanti per quasi un secolo ha una forza di durata ancora lunga e occorre una forza altrettanto solida per arrestarla. Ora, all’ingrosso, si può dire che la forza organizzata che ha fatto le ossa al paese e l’ha tenuto in piedi con dignità fino a ieri è stata la borghesia italiana; una classe dai confini imprecisi, da cui uscirono grossi fusti come Giovanni Giolitti, anime vaghe come Gabriele D’Annunzio e solide menti come Pacinotti, senza ricordare quell’esercito di uomini mediocri, ma di ossa dure, come l’ammiraglio Riboty. 1
Ma della borghesia italiana di ieri restano soltanto le cassette di ghisa rossa per imbucare le lettere, altrettanto solide, cordiali, decorose; restano i vecchi marchi di fabbrica, gli alti abeti piantati dai nonni nei giardini delle ville, resta la bottiglia del Fernet, resta la rete ferroviaria, ma l’animo di quei borghesi è rimasto attaccato al loro gilè bianco, non vive più sotto i pullovers degli eredi. I figli, i nipoti, i pronipoti di quei vecchi borghesi non chiedono di rimanere borghesi, non vogliono più esserlo, non vogliono più sembrarlo; vogliono diventare qualcosa di diverso, qualcosa d’altro. Essi ripudiano la loro storia: la storia pesa loro, li annoia, li copre di polvere. La storia attira l’agente delle tasse; la storia impone dei doveri; la storia chiede anche di morire. E al borghese d’oggi, la sola cosa che gli sta a cuore è di vivere, di vivere coi quattrini, anche a costo di perderli a poco a poco, ma lentamente, dolcemente. * È ricco, ma è debole questo nuovo borghese, perché «intimamente ed eternamente incapace di ricchezza»; potente, trema per un dazio, sussulta per una circolare, palpita per un articolo di giornale. Il capitale ha perduto forza: è soltanto un peso, un peso da difendere: non seleziona, non raffina. Chi possiede un miliardo, possiede novecentonovantanove milioni di più di chi ne possiede uno soltanto: è una differenza di zeri, fra gente che vale zero. Non esiste più un bello per i ricchi e un bello per i meno ricchi; l’ideale di bellezza del grosso borghese non differisce da quello del droghiere suo; l’uno e l’altro sfogliano lo stesso giornale illustrato, le abitudini loro sono identiche, e identiche sono le loro opinioni politiche. Ostili alla monarchia, dopo averle chiesto decorazioni e titoli, ora, in mancanza di una regina, ripiegano su Wanda Osiris. Ieri collezionisti di quadri di Bazzaro e di Nomellini, oggi acquistano Picasso; proprietari di ville e di giardini, abitano negli attici dei grattacieli per «ridurre la servitù»; cavalieri di Malta avvolti nei mantelli crociati, portano gli slips; liberisti, invocano l’Iri. Senza fiducia in se stessi, si affidano a fatti esterni per procedere: se il proletariato attende la spinta della storia, il grosso borghese attende quella dello stato; se al primo occorre una gerarchia politica che sostituisca la classe dirigente, il secondo ha bisogno di tecnici e di prestiti; l’uno e l’altro preferiscono al capitale privato gli enti governativi, più vaghi e sciuponi; entrambi tendono a liberarsi del peso di ogni responsabilità per riversarlo, il primo sulla burocrazia politica; il secondo sulla burocrazia statale.
Rileggete quello che Ruskin, il buon Ruskin, quasi cento anni fa, scriveva sui doveri dei ricchi: «E come il capitano del bastimento è obbligato a essere l’ultimo uomo che lascerà la nave in caso di naufragio e a dividere la sua ultima crosta coi marinai, così, il fabbricante, in qualsiasi crisi o calamità commerciale, deve accettare le sofferenze insieme ai suoi uomini e anche prendere su di sé più di ciò che permette ai suoi uomini di soffrire; come un padre sacrificherebbe se stesso per il figlio in caso di naufragio, di carestia o di battaglia». Certo, oggi, a rileggere Ruskin vien da sorridere, eppure, dopo quasi cent’anni, la morale è ancora quella, non è invecchiata, e nessuna rivoluzione economica, nessun mutamento sociale la muta. Quando udite la nostra classe dirigente levare lamenti contro la concorrenza straniera, quando vi ripetono fino alla noia che il nostro paese non ha materie prime, quando vi spiegano che i nostri costi di produzione sono troppo alti e che la nostra bilancia commerciale soffre di squilibri troppo frequenti, e vedete versar lacrime su questa nostra disgraziata condizione, cercate di uscire dal vicolo dei luoghi comuni: l’economia non è una scienza esatta; la finanza, l’industria, il commercio non ubbidiscono alle vecchie verità matematiche; la matematica è una, ma di mille specie, come l’arte; non prestate ascolto alle verità che sembrano vere, che sono soltanto il risultato di premesse false, soltanto modi di dire: anche la scienza muta, perché la scienza, come l’economia, è frutto della fantasia: e la ricchezza è soltanto frutto di fantasia e di ordine, due qualità che sembrano contraddirsi, ma che si compendiano. Ora la nostra classe dirigente manca di fantasia e vive nel disordine: disordine tecnico, disordine politico. Le crisi, qui, sopraggiungono inattese come tempeste a cui nessuno aveva mai pensato; e nessuno si chiede mai se davvero si potevano evitarle seguendo metodi diversi. La facilità con cui si fondano vaste imprese è pari alla incapacità di sorreggerle nei momenti di crisi. E il rimedio a cui si ricorre per arginare i disastri non varia mai: è allo stato che si ricorre in nome di una solidarietà umana fino allora trascurata. Il pane degli operai garantisce il finanziamento di ogni pessima industria. La tecnica che vale, la fantasia che vale, la capacità che vale è una sola: quella di ingrossare l’impresa, d’allargare la fabbrica, di ingigantire l’azienda il più possibile. Perché lo stato teme la fame, quando la fame è improvvisa, quando la fame esce dalle fabbriche, quando la fame è organizzata. La fame individuale, la fame privata, la fame stabile, la fame che vive di fame apolitica non lo disturba: resta fame inerte, passa nel pittoresco, nel colore locale.
Lo stato non ha occhi, non ha orecchi per il cittadino, per l’italiano: lo stato lo affida a cattive scuole, a cattivi militari, a cattivi funzionari, a cattivi dirigenti, poi lo abbandona ai grossi borghesi. E il povero italiano si dibatte e tira avanti, stretto fra due grossi elefanti: deve spingere, consumare e ubbidire. Deve leggere giornali che non dicono mai la verità, perché non esiste la verità: esistono soltanto due punti di vista: quello dei grossi borghesi e quello dei grossi proletari. Egli non ha modelli a cui ispirarsi, perché esistono soltanto i vizi di quei due grossi elefanti: il borghese e il proletario. Egli non ha, in casi estremi, via di scelta: o coi grossi borghesi o coi grossi proletari.
Pubblichiamo questo testo per gentile concessione di Ettore Bianciardi, ideatore di una iniziativa editoriale particolarissima ed encomiabile, I BIANCIARDINI (“libri fuorilegge rispetto alle leggi di mercato”) della quale si possono leggere notizie su: www.riaprireilfuoco.org.
- Riboty Augusto. Senatore. Ammiraglio (1817-1883). Nato a Pugel-Teniers, presso Nizza, iniziò la sua carriera nella marina sarda. Intrepido comandante del Re di Portogallo a Lissa, fu primo tra coloro che, nella giornata infausta, salvarono l’onore delle armi italiane, riportandone, più prezioso della medaglia d’oro al valore, l’aperto riconoscimento del vincitore Tegethoff. Ministro della marina, il R., pur essendo personalmente niente più che un buon manovriero sottovela, presentì le grandi trasformazioni tecniche imminenti, e avviò la costruzione delle grosse corazzate tipo Lepanto; fu lui che designò al sovrano, come successore, il Saint Bon. Uomo di altissimo senso del dovere, non esitò, da ministro, a troncare la sua carriera, ponendosi da sé a riposo, per poter togliere dal comando altri sei ufficiali superiori scadenti, più anziani di lui, senza che questi potessero accusarlo di prepararsi l’avanzamento. (Il Borghese: dizionario degli italiani illustri e meschini) ▲























