
Tanto alla morte inclina
D’amor la disciplina…”Giacomo Leopardi, Amore e Morte
Dopo un’eternità trascorsa ad aleggiare per il mondo in qualità di puro spirito, che tutto sa e comprende, un bel giorno Damiel, uno dei due angeli protagonisti del film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, confessa apertamente i propri dubbi. “A volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa. E allora non vorrei più fluttuare così, in eterno: vorrei sentire un peso dentro di me, che mi levi questa infinitezza legandomi in qualche modo alla terra… Per esempio… non so… sedersi al tavolo da gioco, ed essere salutato… In fondo sarebbe già qualcosa ritornare a casa dopo un lungo giorno, dar da mangiare al gatto come Philip Marlowe, avere la febbre, le dita nere per aver letto il giornale; non entusiasmarsi solo per lo spirito, ma finalmente anche per un pranzo, per la linea di una nuca, per un orecchio…”. È così che, mentre si aggira sotto la tenda di un circo, l’angelo dubbioso finisce per innamorarsi di una trapezista. “Amore”, scrive Emanuele Coccia in Fine di Amore, “non ha natura angelica. Angelo è infatti, secondo la teologia medievale, ogni individuo che raccoglie in sé tutta la materia possibile della specie. Si chiama invece demone, l‘individuo che la respinge da sé, la espelle […]. Eros è un demone, ed è solo grazie ai propri demoni che una vita entra in amore: si ama sempre l’individuo assoluto e mai il genere; e si amano in ogni uomo i suoi vezzi, i suoi capricci, le sue vite minori, tutto ciò che lo separa dal resto dei viventi”. Alla fine del suo percorso di meditazione e osservazione della realtà, rapito dai propri demoni, l’angelo Damiel entra in amore. Smette la sua natura spirituale e sceglie di diventare mortale, umano.
*
Per diventare mortale, umano, l’angelo ha dovuto amare l’individuo assoluto (sciolto dall’appartenenza alla specie umana) rappresentato dalla trapezista, la sua singolare immagine di umanità, non più tutta l’umanità, come gli accadeva prima, nella sua esistenza spirituale, generale e generica. Cominciando ad amare, ha dovuto accettare la fine che abita in tutte le cose mortali. “Amore”, scrive ancora Coccia, “non è il dio delle origini. Non sta all’inizio delle cose, ma sempre e solo alla loro fine. È il dio della rovina, non il nume tutelare della nascita o della genesi. Ogni rovina non è che lo stato di tutto ciò che è immagine. Perché immagine […] non è che ciò che resta di una vita alla sua morte, quanto gli resiste, ciò che testimonia di una vita che è stata attraversata dalla morte”. Eros è il segreto demone dell’immaginazione, che consente il passaggio dalla generalità dell’esistenza alla particolarità post mortem di qualsiasi essere o cosa. Grazie a Eros, che si presenta quando ai nostri occhi l’oggetto del desiderio è finito o rovinato, noi cominciamo a immaginare, ovvero non ci resta altro che immaginare: “perché immagine non è che ciò che resta di una vita alla sua morte”.
*
“Come sfuggire all’ossessione della Fine?”, si interroga Massimo Rizzante nelle ultime pagine della sua raccolta di saggi Non siamo gli ultimi (Effigie, 2009), fornendo così, anche al più distratto dei lettori, la chiave decisiva per entrare nella sua opera. “Fine della giovinezza. Fine del comunismo. Fine dell’arte…” – e si potrebbe aggiungere, a piacere: Fine della Storia, Fine dell’Umanesimo… Non siamo gli ultimi è il racconto di una ricerca, sostenuta da una disciplina scevra di pedanterie, “per sfuggire all’ossessione della Fine”, ovverosia per dare un senso a questa medesima fine, quindi per continuare a immaginare. Non a caso, il demone di Eros attraversa in lungo e in largo il libro di Massimo Rizzante. Senza Eros, Non siamo gli ultimi non sarebbe mai nato, come del resto tutte le cose che amiamo in quanto immagini o rovine, in quanto “segni di una nuova giovinezza” (Jean-Luc Nancy, Cronache filosofiche). “Il tempo dell’amore è questo tempo carsico. È il tempo in cui tutte le cose rovinano. Non che le cose effettivamente si distruggano; rovina è per definizione ciò che sopravvive alla propria fine – e alla fine del proprio tempo” (Coccia). Si capisce che Rizzante non nutre alcun interesse per la letteratura o per l’opera letteraria in sé (anch’essa peraltro finita, come lui stesso dichiara, esibendone il certificato di morte nel sottotitolo del suo volume), ma amore per le immagini della letteratura divenuta rovina. Immagini che, anche grazie alla sua opera, risorgono dai più impensati anfratti, sprigionando una luce intensa e vivificando i discorsi.
*
Come interpretare, altrimenti, definizioni come la “fine della Repubblica delle Lettere”, la “fine della percezione letteraria del mondo”, la “fine delle élites letterarie” evocate nelle prime pagine di Non siamo gli ultimi? Certo non come esempi di un facile nichilismo professorale, smerciabile in forma di innocui pensierini nei licei e nelle università. La risposta di Rizzante all’idea della fine non è concettuale né teorica, ma è una risposta per immagini: ad esempio, l’immagine delle catacombe, dove ormai vive la vera arte; del turista che consuma la letteratura come un hot dog; ma soprattutto della miriade di personaggi e autori che affiorano dalle sue pagine come fantasmi mezzi veri e mezzi falsi, portatori ciascuno della propria verità esistenziale, del proprio sentimento umano della fine, del proprio aver saputo rovinare facendosi immagine. Mezzi veri e mezzi falsi perché perfino gli autori, in Non siamo gli ultimi, diventano immagini. Spogliati dell’ultimo residuo umanistico che ancora potrebbe rivestirli, sono ridotti a figurine miniaturizzate ai bordi delle pagine, facendo il paio con il ritratto di Kafka disegnato in copertina su una bustina di zucchero per caffè. Anche questo ritratto è una figurina, e dalla bustina esce dello zucchero, come dal libro di Rizzante esce l’amore per gli autori presentati in effigie sui bordi delle sue pagine a costituire una folla amichevole e a farsi anch’essi – perfino essi! – materia d’immaginazione, come nel romanzo 2666 di Roberto Bolaño, al quale Rizzante dedica pagine mirabili.
*
Leggendo Non siamo gli ultimi, viene in mente che nella cosiddetta “epoca delle immagini”, impauriti come siamo da qualsiasi fine, ciò di cui sentiamo la mancanza, paradossalmente, sono proprio le immagini, intese piuttosto come puri corpi e oggetti, come “qualcosa che oppone innanzitutto resistenza piuttosto che veicolo, termine e forma del desiderio” (Coccia). Ma i puri corpi, come le merci, non possono mai diventare rovine, non essendo frutti di demonici atti d’amore. La forza dell’immaginazione di Rizzante, al contrario, è tutta nella capacità erotica di sapere ancora scorgere la rovina di ciò che è corpo o pensiero, di sapere ancora estrarre linfa vitale dai morti e dai personaggi romanzeschi, e di riuscire così a penetrare l’esistenza e il destino di qualsiasi cosa o essere vivente. Non siamo gli ultimi nasce alla fine di un’epoca non per subirne le implicazioni nichiliste, bensì per guardare, senza vergogna o moralismi, all’avvenire. La letteratura, in quanto finita, torna a essere popolata non più di teorie o astrattezze, ma di immagini e, per questo motivo, risveglia il nostro amore per essa. Soltanto così si spiega forse il senso della fine che ha ossessionato e animato la ricerca critica di Rizzante negli ultimi quindici anni, che altrimenti rischia di apparire come una stucchevole conferma al mondo ottuso e privo di Eros del “sistema letterario”, avido soltanto di simulacri inviolabili (il simulacro della “fine”, appunto, come quello della “realtà” o della “verità della parola”). Rizzante, come il Damiel di Wenders, avendo abdicato a qualsiasi concezione totalizzante, riesce a scorgere la meraviglia prosaica di cui si narra nei romanzi e in ogni momento in cui aleggia la fine – meraviglia che rende pazzi e sbandati, innamorati.
*
Viceversa, la letteratura che si allontana dall’idea della morte, e che non accetta il passato se non come testimonianza autorevole, la letteratura che non sbanda mai per l’impazzimento provocato da Eros – questa letteratura che domina il mondo tecnologizzato e non ammette la conoscenza veicolata attraverso le rovine dell’immaginazione, è una letteratura senza fine. Essa si nutre solo di simulacri masticati e risputati dal Lucifero dei dispositivi mondiali del profitto – dispositivi editoriali, cinematografici, artistici in genere, dove non a caso l’idea di “creatività” domina su quella di “creazione”. La “creatività” che tutto deve rendere attuale perché tutto deve essere velocemente consumabile, che tutto deve far brillare come un’immagine pop perché deve accecare, che tutto deve dominare con una tecnica facile facile perché deve rimbambire e imbambinire. Ma “la creatività, naturalmente, non ha niente a che fare con la creazione, così come per un cristiano i miracoli di Simon Mago non possono essere comparati a quelli di Gesù Cristo”, scrive Rizzante. Il quale inanella, alla luce della sua immaginazione letteraria ispirata dall’Eros del romanzo, una serie di intuizioni che diventano punti di fuga fondamentali per il lettore del ventunesimo secolo: via dall’arte intesa come décor, che distrugge qualsiasi pensiero dell’opera come creazione di una sapienza artigianale; via dall’eterno desiderio di plot, che annichila il piacere della forma; via dal mito del giovanilismo e dal culto dell’immaturità, che annullano le età e il dialogo con il passato; via dalla grafomania internettiana, che distrugge la meditazione; via dal mondo inteso come laboratorio a cielo aperto, in cui l’uomo è solo una cavia tra le altre…
*
… E spazio, invece, al gioco degli umori, che serpeggia tra le pagine di Non siamo gli ultimi e anima, come raramente avviene, il pensiero critico; alla sapienza musicale, che tiene insieme i discorsi e le loro parti, facendo apparire il tutto sempre armonico e dilettevole; al dialogo con i morti e con gli erranti, che rendono visionarie e classiche le argomentazioni più ardite; alle possibilità conoscitive del ricordo e della memoria, nettamente superiori a qualsiasi tecnologia scientifica. Ma soprattutto, spazio alla umile prosa, e alla vita prosaica e insignificante che diventa luce del mattino per il lettore che verrà, e a tratti quasi una guida nel mondo dominato dal potere che tutto sa e controlla. È proprio grazie a una concezione liberatoria del tempo quotidiano anche a partire dall’interno del più temibile degli universi totalitari (i. e. il nostro), che Rizzante può suggerire una soluzione plausibile: “Per non cedere a un potere che pur ci domina, è necessario imparare a preservare la nostra solitudine. Lunghi anni di apprendistato (e di internato) sono necessari. Solo così, in età adulta, potremo permetterci il piacere voluttuoso di nasconderci in un essere subalterno. Permetterci il vizio della mistificazione. E ricordare”. Solo così il demone di Eros avrà compiuto la sua impresa maggiore – un’impresa politica in un mondo disamorato – riuscendo ad innalzare sulle rovine e sulla fine del presente e della Storia, l’altare di sabbia dell’immaginazione e della bellezza prosaica.
*
Quando Damiel comincia a innamorarsi della trapezista, i fotogrammi del film di Wenders all’improvviso si colorano, facendo risaltare la roulotte in cui vive la donna, il suo attrezzo, il letto e le lenzuola, il rosa vellutato delle spalle e del fondoschiena. L’immagine della donna – la donna divenuta immagine, la sua rovina – rende improvvisamente tutto prosaico, comune, e quindi colorato, agli occhi dell’angelo. Il mondo abitato da Eros e dalla prosaica realtà è colorato, il mondo del puro spirito è in bianco e nero (come sapeva bene il grande fotografo Luigi Ghirri, che in bianco e nero non fotografava mai, sostenendo che con il colore si può fotografare il bianco e nero, ma non viceversa). È a partire dalla prosaicità del mondo finito che l’angelo comincia a capire e a vedere, non dall’alto del suo essere spirituale infinito e onnisciente. Allo stesso modo, se la letteratura è solo un oggetto (merce) come tanti, generico e seriale, non potrà mai finire né essere fecondata da alcun tipo di Eros. Torna utile, allora, il demone di Non siamo gli ultimi, anche per mettere in luce come la maggior parte degli scrittori moderni abbia smesso di praticare l’umile prosa come arte del particolare, producendo infine solo libri universalmente validi, colmi di scrittura indifferenziata e di eventi tanto improbabili quanto realistici. Tutti libri scritti in un angoscioso e anodino bianco e nero.
*
Ma a scapito delle astrazioni realistiche e dei diktat merceologici, con i quali vorrebbero inculcarci l’ideologia dell’immaturità, la facoltà immaginativa persiste e dura. Anche perché la fine è tra gli uomini da sempre, come dice Leopardi ghignando nel Dialogo di un folletto e di uno gnomo, ed è folle chi pretende di non vederla. Soltanto scrivendo dal capolinea del mondo, la letteratura può rigenerare l’umanità, a maggior ragione nell’epoca del quotidiano e del prosaico, dove è ancora Amore a dettar legge, e nessun altro. Amore che, sempre secondo il ghignante poeta recanatese, è fratello di Morte… “E sorvolano insiem la via mortale”.

 Devo dirglielo a Enrico De Vivo - Gianni Celati
Devo dirglielo a Enrico De Vivo - Gianni Celati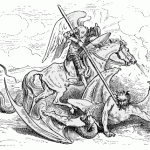 Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando
Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando Credere nel movimento oltre se stessi - Stefania Conte
Credere nel movimento oltre se stessi - Stefania Conte L’ultima favola - Enrico De Vivo
L’ultima favola - Enrico De Vivo Un altro novellino – Premessa
Un altro novellino – Premessa Caimano a chi?
Caimano a chi? Un altro Novellino/ 2
Un altro Novellino/ 2 Il crogiolo magico svelatore/ 4
Il crogiolo magico svelatore/ 4





















