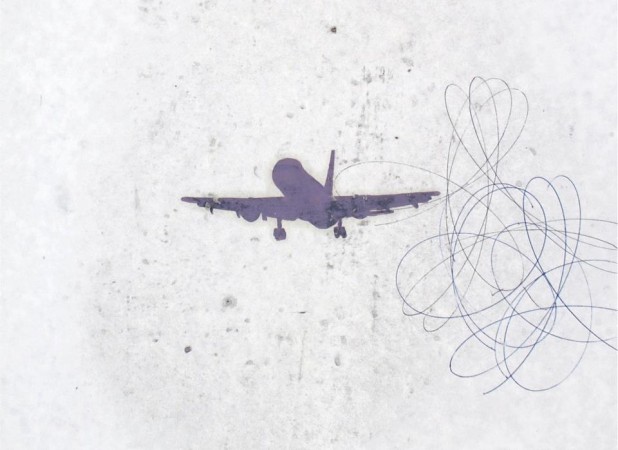
Luca Coser, Untitled 2012
CANTO I (prima parte)
La vicenda eroicomica ha inizio là dove Omero concluse la Batracomiomachia, guerra di topi e rane. I paralipomeni sono la continuazione.
I topi, vinta la guerra contro le rane, sono a loro volta scacciati dai terribili granchi e fuggono lontano. È il valoroso topo Miratondo a mettere fine alla ritirata: i topi si riorganizzano. Il problema è che il re Mangiaprosciutti non ha eredi. Si elegge come capo provvisorio Rubatocchi, che riorganizza l’esercito e decide di mandare un ambasciatore ai granchi. Viene scelto per questo il conte Leccafondi.
Una bella serie di divagazioni. Nell’ordine: sugli spropositi filologici dei linguisti tedeschi; sullo scarso sentimento nazionale degli italiani che non scelgono nomi gloriosi per i propri figli; sull’odio degli stranieri contro l’Italia, tutta invidia per la grandezza di Roma e del Rinascimento.
I topi avevano vinto, le ranocchie erano circondate. Ma arrivarono i granchi, all’improvviso, per un volere superiore.
Vennero i granchi per rimpiazzare i plotoni delle ranocchie sconfitte, le quali dei granchi non avevano mai avuto nemmeno lontana idea, ma è così che ha voluto l’iddio padre di noi tutti, e la sorte si ribaltò così che i topi vincitori furono dispersi, le loro grandi e belle imprese vanificate, per il campo di battaglia erano disseminate ormai berrette, code topesche e baffi; nella campagna fuggivano insanguinati i topi, si disperdevano nella sera galoppando e sul calare del sole tu vedevi già la pianura nera: come spesso vedi su un muro, quando brilla la sfera d’oro del sole autunnale – ricordi quelle belle ottobrate con il cielo limpido? –, un nuvolo di mosche scuro e brulicante rendere bruno quel bel radiore.
Ecco, c’è una guerra. I topi hanno vinto la loro battaglia finale sulle rane, ma i granchi non hanno perso tempo: hanno sorpreso i topi e li hanno dispersi a loro volta nella campagna, li vedi laggiù che galoppano laceri nella sera.
La storia fino a qui l’ha raccontata Omero, adesso tocca a Giacomo Leopardi.
Il conte Giacomo Leopardi abitava nella città di Napoli, insieme al suo più caro amico Antonio Ranieri. Questa è la sua ultima opera. Ranieri racconta che Leopardi non aveva ancora finito questo poema – che i letterati chiamano eroicomico – e che le ultime ottave gliele ha dettate proprio il giorno prima di morire. Vabbè, c’è Leopardi, vengono subito fuori le disgrazie… ci diciamo che era un tipo allegro, invece? E che è morto perché ha mangiato troppi confetti di Sulmona, la sera prima? Che non ne poteva più dell’ambiente serioso e noioso degli spiritualisti napoletani, dei patrioti risorgimentali, dei sospirosi romanzieri romantici? E per questo ha scritto questa cosa comica. L’ultima.
Il conte Giacomo Leopardi dettava le strofe – ottave, in termini adeguati – al suo amico Ranieri. Si sente che in certi momenti devono aver riso come i matti.
La storia va avanti così. C’era un tal generale austriaco Michelangelo Alessandro Colli Marchini di cui si parlava ancora verso il 1830: conduceva all’assalto le truppe papali contro i francesi invasori – illuministi, giacobini, rivoluzionari! – dalle parti di Faenza, nel 1797. Le bandiere francesi ridevano nel vento romagnolo. Dicono che il Colli dopo la sconfitta tirò il fiato per la prima volta ad Ancona dov’era volato con la sua carrozza d’oro, neanche Apollo sarebbe stato più rapido.
Era pieno di guerre, a quei tempi: Leopardi cercava paragoni per descrivere la fuga dei topi e non faceva fatica. I belgi – vabbè, il conte detta “fiamminga gente” – dissero: «Non siamo mica napoletani, noi!» perché i napoletani guidati da Gioacchino Murat a Tolentino nel 1815 le avevano prese secche dagli austriaci. Loro affrontavano i cugini olandesi, siamo nel 1831, a Lovanio; aspettavano gli aiuti dei francesi. Ma niente: anche loro, i belgi, via in fuga.
Insomma, mentre cerca di rappresentarci la scena, Giacomo Leopardi ci dice anche: vedete, si vince, si perde, c’è sempre qualcuno da qualche parte che fugge insanguinato nella sera.
E poi dice ai sognatori patrioti italiani: massì, aspettate pure l’aiuto dei francesi, contro questi austriaci invasori, vedrete come arrivano…
C’è chi sostiene che i granchi, in questa storia, assomigliano agli austriaci e i topi un po’ agli italiani.
I topi – continua il poema eroicomico – per più di cento miglia hanno voltato le spalle al loro destino.
Passata era la notte, già il secondo giorno stava sfumando nella sera, ed ecco che un guerriero topo, il Miratondo, arrivò di corsa su un’altura. Forse era coraggioso o forse la stanchezza è più forte della paura, si fermò; spiare era la sua passione e si guardò intorno. Il primo topo che ebbe il coraggio di voltare il muso indietro. Guardava più lontano che poteva, di qua, di là, verso i quattro venti, l’acqua e la terra, il monte e il piano, spiò le selve, i laghi e i fiumi, le vaste campagne e l’oceano: stranieri non ce n’erano, solo farfalle e molte vespe giù per la valle. Né granchi né granchietti, nessun segno di armi nemiche. Sussurravano solo i venti della sera, dolci, muovevano i rami e l’erba, accarezzavano fra le orecchie i capelli del buon soldato. Era il cielo senza nubi, la sera rosseggiava, il mare calmo.
Davanti a tanta quieta beltà il Miratondo sentì tornare le forze e riprese coraggio. Quattro volte intorno le pupille girò e capì che l’ora della paura era passata e che era inutile averne ancora, e allora osò rivolgersi ai suoi compagni, tanto si fidava dei suoi occhi.
Qui il conte Leopardi, con tutta la sua leggerezza, dice che è perlomeno da ingenui credere sempre e solo nei propri occhi. La verità non è quello che si vede. Questi topi riflettono poco sulla verità, sono abbastanza pavidi, fanno grandi proclami quando il pericolo è lontano, perdono volentieri le battaglie, si fanno passare altrettanto volentieri da eroi e da martiri. Dicono gli interpreti che assomigliano ai liberali del nostro Ottocento.
In certe altre sue pagine il conte Giacomo Leopardi dà una definizione stupenda della “doppia vista”: non vedi solo quella torre o quel paesaggio, ma hai sotto gli occhi – anche gli occhi della mente – i sentimenti collegati alla torre e al paesaggio, la memoria l’affetto la paura lo stupore l’amore. Vedi quella torre e anche il suo fantasma.
Il poema eroicomico è fatto anche così: prende a prestito dai serissimi poemi epici certe forme stilistiche, come i paragoni – e poi li mette in ridicolo; pone a confronto grandi esempi dell’eroismo antico con le meschinità del presente. Come più sopra il generale Colli: scappava sì ma lo faceva come se fosse sul cocchio di Apollo.
E anche i topi, qua, sentono tutto il sollievo della fine dei loro travagli, come i diecimila che racconta nell’Anabasi il generale e scrittore greco Senofonte, che con il suo esercito viaggiò per mezza Persia e Siria e Turchia, arrivarono finalmente di fronte al mare e si urlavano uno con l’altro «Thalatta, thalatta» mare mare! finalmente si torna a casa… Anche i topi, dunque, esultarono, anche se erano al limite della loro resistenza, per la fatica e per la paura, quando udirono il grido del buon esploratore, il Miratondo, un grido grandioso che echeggiava nelle caverne marine con le acque mugghianti del mare e annunciava che tutto intorno fino dove si poteva vedere era tranquillo e senza pericoli.
Capiscono i topi che devono riunirsi, fermarsi e rialzare la fronte. Arrivano da tutte le parti, dal poggio e dalla pianura, questi qua che la paura aveva fatto rovesciare qua e là per mille rivoli, ancora smarriti e incerti, spossati e semivivi: non sanno bene cosa fare perché ci sono un presente che preme con le sue necessità e il pericolo dei granchi all’inseguimento.
C’era Venere, lassù, che già brillava prima di tutte le stelle e della luna: taceva tutta la campagna, si udivano solo il mormorare di uno stagno, il ronzio delle zanzare – si sa, no, che la sera la mosca cede alla zanzara? – una musica naturale che veniva dalla foresta a spandersi nell’aria bruna: il sereno riflesso di quella stella che fa sperare riluceva con le sue bellezze nel lago. Invece i topi tacevano, magari temevano di svegliare i granchi, per quanto fossero lontani, discorrevano fitto fitto ma in silenzio, con le zampe e con la coda, ricordandosi uno all’altro con dei gran gesti l’orrore di quell’esercito di bruti ingordi e strani; tentavano di mettere insieme qualche rimedio per questo rovescio disgraziato.
Ve la ricordate, la Batracomiomachia di Omero, quella di cui qui sto continuando la storia? dice il conte Leopardi ai suoi lettori. Ecco, Omero ha raccontato, e voi sicuramente l’avete letto, che Mangiaprosciutti – ehi, Mangiaprosciutti primo, il re dei topi! – nella battaglia era morto. Nelle sue ultime parole non aveva designato nessun successore, nella sua vita non aveva messo insieme uno straccio di erede che gli Dei dovessero riconoscere come nuovo re. C’era bene una sua figliola, chiamata Leccamacine, che aveva sposato un certo Rodipane: era anche la madre di quello che vola sulle bocche di tutti, Rubabriciole il bello, ve lo ricordate, quello per cui è scoppiata la guerra fra i topi e le rane… la sapete, no, la storia? No? Allora «con agio in Omero la leggerete» dice il conte Leopardi.
Ma niente da fare. La legge sàlica afferma che l’erede se è femmina è come se non esistesse.
Qui il conte Leopardi, che per chi non lo sa è stato il più grande linguista e filologo dei suoi tempi e forse anche dopo, si mette a prendere in giro i maestri di tutti i filologi, i tedeschi. E già che c’è prende in giro anche quel vizio che avevano lassù, quei romantici, di ammantare tutto di misteri e di ombre e di fumi. Il conte preferiva la luce. Gli piaceva di più il Settecento con l’Illuminismo che l’Ottocento con il Romanticismo, «secol superbo e sciocco» lo definisce in una sua poesia famosa. A proposito, provate a notare, anche qui in questo povero libro che leggete, quanto i topi si fanno affascinare dalle ombre, mentre avrebbero tanta luce per illuminare la loro vita. Ma ognuno, insomma, fa le sue scelte.
Allora, come si diceva, un filologo tedesco di quelli bravi e famosi, di quelli che dimostrano che il greco e il tedesco anticamente venivano dalla stessa lingua madre, anzi che il latino e il tedesco erano la stessa cosa, e addirittura che Roma fu una città germanica, proprio uno di questi filologi con tanto di documenti e di bei ragionamenti ti può dimostrare che nel popolo dei topi vigeva la legge sàlica. Niente maschi niente eredi. Le femmine: niente.
Diciamoci due cose anche noi sulla questione dei filologi tedeschi: ce n’erano che si erano montati la testa e vedevano origini germaniche dappertutto. Uno, che si chiamava Wilhelm Kuithan, aveva scritto un trattato dal titolo I Germani e i Greci: una lingua, un popolo, una storia risorta. E poi sentite quest’altro, un tale Ernst Jaeckel, ha scritto L’origine germanica della lingua latina. Già nei titoli c’è il delirio nazionalistico. Mah, sono gli stessi anni in cui si comincia a mettere insieme la teoria dell’origine comune dei popoli “indoeuropei”, chissà se il conte autore del nostro poema eroicomico sarebbe stato d’accordo…
Cosa non ti dimostrano questi alemanni? Per loro, dice il conte, un giorno sappiamo tutto delle cose oscure e l’altro invece no; sulle cose chiare, ecco che creano dubbi e paure e cortine fumogene: una cosa però è accettata da tutti, il mondo è frutto del seme tedesco. Ecco: spiritualismo, idealismo, astrazioni, religione, mitologie del mistero, nazionalismo popolare senza eroismo, queste nebbie che nel Romanticismo tedesco piacevano tanto il nostro conte le manda gambe all’aria con una risata bella e un po’ amara.
(I – continua)

 Giacomo Leopardi e la luna salentina - Antonio Prete
Giacomo Leopardi e la luna salentina - Antonio Prete La tomba di Leopardi - Redazione
La tomba di Leopardi - Redazione Paralipomeni della Batracomiomachia/ 4 - Michele Ruele
Paralipomeni della Batracomiomachia/ 4 - Michele Ruele Giacomo Leopardi in Germania - Antonio Devicienti
Giacomo Leopardi in Germania - Antonio Devicienti Paralipomeni della Batracomiomachia
Paralipomeni della Batracomiomachia Ensogni
Ensogni Porcella amorosa
Porcella amorosa





















