
Calvino, vent’anni dopo. Niente di più ozioso che porre la domanda sull’attualità o inattualità della sua scrittura. O la domanda su quale delle due figure contemporanee messe spesso a confronto – Pasolini e Calvino – sia più presente, oggi, più prossima alle grandi questioni del nostro tempo. Ogni scrittore, quando diventa quello che diciamo un classico, ha una sua presenza. Agisce nel silenzio della lettura, nel dialogo che le pagine dischiudono con il lettore, con le domande e i pensieri del lettore. La presenza di Calvino è anzitutto un invito ad affinare lo sguardo sul mondo, sapendo che l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande si corrispondono, dialogano tra loro, come si corrispondono, anzi talvolta si sovrappongono, caos e geometria, stupore e conoscenza, reale e fantastico. L’attenzione di Calvino al razionale, al lineare, al dimostrabile ha il suo confine in un’altra attenzione, che è anche una passione: la passione per lo sconfinato, il cosmologico, l’impossibile. La passione per l’inatteso, l’eccedente, l’estremo. Come comporre queste due tensioni, o se sia giusto comporle, è stato il problema di Calvino. Un problema diventato scrittura, narrazione, ma anche riflessione saggistica. Un giocatore di scacchi che non abolisce l’enigma. Uno che ama l’arabesco e il misterioso e l’oscuro ma lo vuole rintracciare nella maschera della trasparenza, nella chiarezza, nella razionalità. “A me – dice Ludmilla, la lettrice di Se una notte d’inverno un viaggiatore – piacciono i libri in cui tutti i misteri e le angosce passano attraverso una mente esatta e fredda e senza ombre come quella di un giocatore di scacchi”. Per questo il maestro di ogni scrittura fantastica è Edgar Allan Poe. E, a questo proposito, si può dire che Calvino più di ogni altro scrittore del Novecento italiano ha contribuito a costruire quella disciplina che Novalis auspicava e che in analogia con la Logica o l’Estetica, doveva chiamarsi Fantastica. In questa disciplina – disciplina come rigore di descrizione, esattezza linguistica, misura narrativa – la fiaba è fonte costante, universo tematico e oggetto di studio. È modello di narrazione: “M’interessa della fiaba, scrive Calvino nella raccolta di saggi Una pietra sopra, il disegno lineare della narrazione, il ritmo, l’essenzialità, il modo in cui il senso di una vita è contenuto in una sintesi di fatti, di prove da superare, di momenti supremi”. La narrazione per Calvino è questa ricerca di essenzialità. Dove l’avventura, con i bagliori dell’ estremo, con la sfida dell’ostacolo, è come velata da un pensiero che vi trascorre sopra, un pensiero dell’esistenza individuale osservata in relazione con l’esistenza universale: il singolo e l’infinito, il caso e le leggi dell’universo, i fosfeni che guizzano sotto le palpebre chiuse e le supernovae che esplodono in lontane galassie. In questo senso tutte le opere di Calvino – dal Sentiero dei nidi di ragno, del 1947, alla famosa trilogia che comprende Il visconte dimezzato(1952), Il barone rampante (1957) Il cavaliere inesistente (1959), dalle Cosmicomiche (1965) alle Città invisibili (1972), da Marcovaldo (1963) al Castello dei destini incrociati (1973) – sembrano compendiarsi nel personaggio di Palomar. In quel rimbalzare della mente di Palomar tra le peripezie logiche dell’immaginazione e le peripezie fantastiche della ragione. Ossessione della percezione minima. Sguardo che vuole cogliere la profondità della superficie, sapendo che “la superficie delle cose è inesauribile”, è talmente sconfinata che prima di oltrepassarla ci si può perdere. Vertigine della misura, del limite, del visibile. Palomar è un paradosso del pensiero occidentale, che pretende, attraverso le procedure di un pensiero chiuso, di attingere la conoscenza interiore, la conoscenza esatta di sé. Come Monsieur Teste, il personaggio di Valéry, anche Palomar fa della propria mente un mondo da esplorare, da abitare. Vuole attrarre tutto nel cerchio del sapere: per questo cerca una continuità tra il filo d’erba e i corpi celesti, tra il fischio del merlo e gli abissi del linguaggio. E vuole dare una forma all’informe, una lingua al silenzio, una rappresentazione al nulla. Ma come ad Agilulfo, il bianco cavaliere del vuoto, è la parola a dargli certezza del nome e dell’avventura, così a Palomar è il pensiero a dargli certezza delle cose, del loro stare. Una certezza che però via via si dissipa ad ogni nuovo ragionamento sul visibile, ad ogni nuova osservazione. Così, proprio mentre immagina un tempo senza tempo, e vuole separare sé dal pensiero della morte, Palomar muore. La morte è l’irruzione del silenzio, dell’aporia, dell’indescrivibile nel linguaggio, e nel pensiero. Palomar, uscito nel 1983, è davvero il punto d’approdo di una lunga ricerca narrativa.
Nell’ultimo Calvino la narrazione rende più esplicita la tessitura per così dire riflessiva che sottende la costruzione fantastica e allo stesso tempo scopre sempre di più le arcate dell’impalcatura, l’ordito del discorso. Le lezioni americane, scritte nell’estate di vent’anni fa, e uscite postume, possono essere lette non solo come una meditazione elegantissima su alcune figure della rappresentazione letteraria e della struttura stessa del linguaggio, ma anche come una trasposizione sul piano saggistico di un’esperienza e di una ricerca e di una sfida condotte in proprio sul piano della narrazione.
Calvino è un esempio nel nostro Novecento di singolare equilibrio tra l’attenzione al classico, alla tradizione – stili e forme e generi del passato che sentiva a lui più consonanti – e l’attenzione a quegli aspetti del romanzesco contemporaneo in cui più esplicite fossero le strategie narrative, le tecniche combinatorie, l’ipertestualità. Ci sono nella sua vicenda di scrittore alcune presenze che sono allo stesso tempo fonte, riferimento, passione di lettore. Ariosto, per esempio. Cioè l’equilibrio straordinario tra incantamento e misura, tra fascinazione dell’avventura e intrico romanzesco, tra piacere del racconto e ironia.
O Stendhal, che sa unire la tensione morale individuale con la tensione storica, lo slancio della vita con il gusto del romanzesco. O Leopardi (il Leopardi soprattutto delle Operette morali: “il libro da cui deriva tutto quello che scrivo”, dirà in una lettera indirizzata al sottoscritto). In Leopardi ritrovava il nesso forte tra domanda sull’infinito e meditazione sul tragico, l’armonia tra leggerezza della lingua e profondità dello sguardo. Ma anche la passione per la scienza cosmologica che si trasforma in poesia, in confronto tra la finitudine dell’uomo e l’infinito che lo sovrasta, infinito che resta indecifrato, inconoscibile. E altri nomi appaiono nella costellazione genealogica di Calvino: Galileo, Sterne, Voltaire, Fourier, Flaubert, ma anche Conrad, al quale dedicò la tesi di laurea, e Hemingway. E, soprattutto Borges, per la tessitura narrativa che è insieme libresca e fantastica, ironica e speculativa.
Un’altra linea di confronto che presiede alla ricerca letteraria di Calvino è quell’insieme di testi e di teorie che sono attraversate dal fascino della formalizzazione, della scrittura al quadrato, dell’arte combinatoria. Che insomma fanno del linguaggio stesso la materia del narrare. George Perec aveva scritto: “Lo spazio comincia così, soltanto con delle parole, dei segni tracciati sulla pagina bianca. Descrivere lo spazio: nominarlo, tracciarlo, come quei fabbricanti di libri di navigazione che riempivano tutte le coste con nomi di porti, nomi di capi, nomi di insenature, tanto che la terra finiva per essere separata dal mare soltanto per effetto di un nastro continuo di testo”. E Calvino è stato sempre attratto da questa pulsione a nominare, descrivere, tracciare mappe o carte nautiche e celesti, e fare esistere la cosa attraverso il suo nome. Eppure, nonostante la sua amicale attenzione a Queneau e a Perec, nonostante il piacere del gioco linguistico e formale, Calvino ha sempre avvertito da una parte il richiamo di un’etica della scrittura che ha come orizzonte l’interrogazione sulla condizione umana, dall’altra la consapevolezza che di là dal segno c’è quel che il segno non può rappresentare.
La sua idea di labirinto (La sfida del labirinto era un saggio pubblicato sul numero 5 del “Menabò”, 1962, la rivista che aveva fondato insieme a Vittorini) da una parte implicava appunto l’esplorazione, l’attraversamento, alla ricerca della via d’uscita, dall’altra riconosceva il fascino della stessa forma-labirinto, con la possibilità dello smarrimento, della perdita. Ma proprio nel tenere insieme queste due tensioni consisteva la ricerca di Calvino. Che da “cercatore di segni”, come il Marco Polo delle Città invisibili, sapeva che di là dal segno si apriva la regione sconfinata del non descrivibile, di là dal pensiero, l’impensato, di là dal limite l’oltrelimite. Era poi questa la vera lezione leopardiana. E anche galileiana.
E proprio in questa certezza consisteva la politicità dell’atto di scrivere. Che era sempre un atto di interrogazione dell’estremo, dell’al di là della superficie. Per questo soprattutto l’ultimo Calvino cercava una via d’uscita dal formalismo un po’ ludico della ingegneria testuale, una via di fuga dal gioco della lettera. E come le Lezioni americane sul piano della riflessione e del saggio, così gli ultimi racconti usciti postumi (Sotto il sole giaguaro) sul piano della narrazione, ripropongono un’idea di scrittura fondata sul rapporto tra corporeità e immaginazione, tra sensi e linguaggio, tra sguardo e meditazione. Fisica e metafisica dello sguardo, vertigine della misura, etica dell’immaginazione: è forse questo il cerchio di riflessione al quale Calvino oggi ci invita.
(Pubblicato in Liberazione del 18 settembre 2005)

 Chiacchiere e preludi - Enrico De Vivo
Chiacchiere e preludi - Enrico De Vivo Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete
Tutti i poeti sono in esilio - Antonio Prete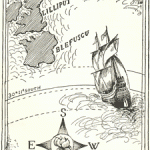 Le Voyage - Antonio Prete
Le Voyage - Antonio Prete Letteratura e democrazia - Antonio Prete
Letteratura e democrazia - Antonio Prete Ricordando Pascal Gabellone
Ricordando Pascal Gabellone Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio
Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione
Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione





















