
Grazie per questo invito, grazie anche alla preside per le parole che ha detto e grazie al professore Virgilio per questa presentazione perché già ha proposto alcune possibili riflessioni intorno a Leopardi. Mi piacerebbe che venissero fuori delle domande da parte vostra, che facessimo un dialogo, perché l’aspetto più interessante della scuola è il dialogo, la possibilità di conversare insieme e conversando conoscere, approfondire, scoprire.
Già il professore Virgilio ha accennato a una serie di cose interessanti su Leopardi, alcuni punti che potrei riprendere.
Partirei anzitutto da un discorso personale e autobiografico dato che mi trovo in una scuola e in un paese non lontani dal paese dove io sono nato, dove ho passato l’infanzia e l’adolescenza, cioè Copertino. Tante volte ho fatto in bicicletta, da ragazzo, Copertino-Galatina o paesi vicini, quando andare in bicicletta era più consueto di oggi perché c’erano poche macchine in circolazione.
Da adolescente ho cominciato, proprio mentre studiavo come voi, sui banchi di scuola, a conoscere Leopardi. Mi ha colpito soprattutto un fatto, da ragazzo: la presenza assidua della luna. La luna, anche nel nostro paesaggio salentino, è una presenza forte perché in pianura, soprattutto certe notti, la luna piena dà una presenza alle cose, cioè rende tutte le cose (le piante le persone gli oggetti) più presenti, pur nascondendoli; la luce lunare ha questa doppia capacità: da una parte nasconde le cose nell’ombra, dall’altra, proprio perché c’è la luce nell’ombra, le rivela; insieme vela e rivela le cose, le nasconde e le mostra. Nella luce lunare le cose sono indefinite, i contorni non li vediamo bene, però vediamo che c’è un albero, un muro, una siepe, una strada, ecc.. Credo, quindi, che questa esperienza della luce lunare e del rapporto tra luce ed ombra che la luna crea, della luna che appare solennemente, nella sua quasi sacralità come fosse una divinità che si leva nello spazio notturno e sorge e tramonta, ciascuno di voi l’abbia vissuta e la viva e la può vivere con un certo incantamento. Io, da ragazzo, avevo percepito questa particolare magia della presenza lunare. Quando lessi Leopardi per la prima volta, scoprii che è il poeta della luna, il poeta che ha dato alla luna versi bellissimi, che ha fatto apparire la luna nei suoi versi in tante situazioni, in tanti modi, in tante forme e che ha riflettuto con la sua poesia sulla natura di questa luce lunare. E quando, sempre nell’adolescenza, durante il primo viaggio dal Sud, andai a vedere l’Appennino dell’Italia centrale, attorno ad Assisi e poi a Recanati, mi accadde che nella notte, dalla vetrata dell’albergo, scorsi una luna splendida, straordinaria; non riuscivo ad andare a dormire perché quella luna mi affascinava e ritrovavo lì la luna leopardiana, appenninica, non più la luna del Salento, che è una luna che sorge sulla pianura e tramonta magari nel mare o dietro un mantello di ulivi; eppure questa luna aveva le stesse caratteristiche, dal punto di vista della luce, di quella che avevo visto da ragazzo nel Salento. Allora nacque il rapporto con Leopardi, a quell’epoca risale l’inizio di un amore, di una passione per Leopardi e per la sua scrittura; e in questa nascita di un amore letterario, come spesso accade anche per altri tipi di amore, la luna è stata complice, la luna del Salento e l’esperienza della luna appenninica, che ha sempre un rapporto diretto con la linea oscura del monte e il cui tramonto è totale: come dice Leopardi in un verso del Tramonto della luna: “Scende la luna; e si scolora il mondo”; “scende la luna”, e vi è una cesura, un intervallo, una pausa , “e si scolora il mondo” , seconda parte del verso che chiamiamo emistichio, che ha quasi un’intonazione barocca, dice una dilatazione assoluta. È questa l’esperienza della luna appenninica che tramontando dietro il monte in realtà non è ancora tramontata perché dietro quel monte c’è una valle, e la luna è ancora su quella valle, ma non la si vede più; e quindi devo immaginare una luna che c’è ma che allo stesso tempo non c’è davanti ai miei occhi: ecco il discorso leopardiano sulle cose che io vedo sapendo che dietro c’è un’altra cosa; ma è quell’altra cosa che c’è dietro che è importante, perché risveglia l’immaginazione, attiva la rappresentazione mentale. Quando sorge la luna nei componimenti di Leopardi, il poeta non solo la guarda, ma comincia, attraverso la luce lunare, a rivolgersi verso di sé, alla propria interiorità. Pensiamo al libro dei Canti, magari nell’edizione di Firenze del 1831: quando appare la luna, notiamo l’apertura di un teatro interiore, cioè il poeta mette in scena un “io” lirico, che non va identificato con l’ “io” biografico, ma che sta ad indicare anche l’ “io” di un qualunque lettore. Dobbiamo leggere la poesia non come pura rappresentazione di un “io” dell’ autore, ma come rappresentazione di un teatro in cui siamo noi e il “tu” convocati accanto a quell'”io”. Quando appare la luna, lo sguardo del poeta si muove verso la propria interiorità, verso la coscienza, le ombre della coscienza; è come se con la sua luce la luna volesse scoprire qualcosa che è nascosto dietro le ombre, rivelasse ciò che è nascosto nella coscienza, qualcosa che abbiamo dimenticato. Il poeta con questa luce fa muovere verso la lingua qualcosa che era perduto, nascosto: ecco l’infanzia, il ricordo che viene dall’infanzia, quello che Leopardi chiama ricordanza. Questa luce lunare non solo rivela il paesaggio e lo vela allo stesso tempo, ma rivela qualcosa che è nascosto nel paesaggio interiore, dentro la coscienza, nelle ombre della coscienza, e che possiamo chiamare oblio, qualcosa di dimenticato, un ricordo dell’infanzia, un’immagine che sale da lontano, che era perduta e che il poeta coglie nel linguaggio e fa vivere nel linguaggio. Perché la poesia ha questo compito: come dice Foscolo, “vince di mille secoli il silenzio”, cioè la poesia trapassa il tempo della dimenticanza. Noi viviamo esperienze che rimangono chiuse in una prigione che è l’oblio: esperienze, incontri, voci e tutto quello che viviamo, allontanandoci noi nel tempo, vengono ovattate, imprigionate nell’oblio, come se l’oblio fosse una scatola, uno scrigno che chiude il nostro vissuto. Le cose vissute sono ancora nel nostro corpo, nella nostra mente, ma sono chiuse, sigillate, e ci sono delle occasioni esterne – per Leopardi è il sorgere della luna, per Proust un raggio di luce, il volo di un uccello radente sul ramo di un albero, il campanile percepito in lontananza a una curva della strada – insomma c’è una cosa inattesa che all’improvviso rivela ciò che abbiamo dimenticato. La poesia è il linguaggio che accoglie quello che è dimenticato, è in relazione con il tempo. Il tempo è irreversibile, una volta che è passato non torna, è passato, diventa cenere, diventa qualcosa di vissuto e basta. Leopardi è angosciato da questa percezione del tempo. Nello Zibaldone ci sono delle frasi molto intense su questo argomento, sul tempo che è finito, che non torna più. Leopardi ci racconta che quando era bambino si svegliava all’improvviso angosciato quando sentiva qualche suono che dava il segnale della partenza di una persona, per esempio di quella cugina che aveva fatto visita in casa Leopardi, e pensava all’idea che quella persona non l’avrebbe mai più vista, che non sarebbe più tornata, e non poteva pronunciare quel “mai più” se non con una grande angoscia. Leopardi aveva il senso forte dell’irreversibile, cioè che il tempo arriva e si allontana. Mentre nello spazio c’è la possibilità di tornare indietro, nel tempo questo non è possibile.
La poesia è quell’insieme di ritmi, di tecniche, di regole che accoglie dal tempo finito qualcosa che di per sé non potrebbe tornare; la poesia trafora l’irreversibilità del tempo e fa apparire qualcosa che era sparito. Leopardi nelle Ricordanze fa apparire le immagini della sua infanzia, della sua adolescenza. Quando è a Pisa, nel ’27, comincia a pensare improvvisamente ad una figura, ad una voce che non sente più e che torna nella sua mente: è il canto di una ragazza che aveva ascoltato nella prima giovinezza: il canto della tessitrice, di Silvia. E così nasce la poesia A Silvia, e Silvia diventa presente: “Silvia, rimembri ancora” – il poeta si rivolge a Silvia come se fosse lì, accanto a lui – “quel tempo della tua vita mortale, / quando beltà splendea / negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi”. Ecco il miracolo della poesia: un verso bellissimo a cui ho dedicato nel libro che il professore Virgilio citava, Il deserto e il fiore, un saggio; questo verso recitato così sembrerebbe uno dei tanti versi, ma questi due aggettivi –ridenti e fuggitivi– non sono mai stati usati nella poesia italiana in questo modo. È stata usata la parola ridente per descrivere gli occhi di Beatrice, anche da Petrarca per Laura e dagli stilnovisti, oppure l’aggettivo fuggitivo è usato da Tasso, ma ridenti e fuggitivi insieme viene usato da Leopardi come un hapax, come una cosa insolita, causando un effetto straordinario. Così nasce A Silvia, così nascono altri versi leopardiani: attraverso questo tempo irreversibile – che è oblio, prigione, perdita, mancanza, fine – torna qualcosa; la poesia rende vivo quel che non c’è, ravviva, permette che una cosa che non c’è più torni ad essere nel linguaggio, diventi una presenza. Questa è la forza della poesia: portare alla presenza qualcosa che non c’è più. Quando dico portare alla presenza, dico rappresentare: la funzione vera dell’arte è quella di portare alla presenza, rappresentare: i Greci usavano una parola per dire questo, usavano la parola poiesis e il verbo poiein. La poiesis per i Greci, come Platone fa dire a Socrate nel Simposio, era questo portare alla presenza qualcosa che non esisteva. Far sì che quel che non è sia. Il poeta era colui che creava, infatti la parola poiesis in italiano è tradotta “creazione”, ma se vogliamo approfondire questa parola dobbiamo tradurla con “rappresentare”, cioè portare alla presenza. La poesia di Leopardi è questo continuo portare alla presenza qualcosa che era sommerso, che era perduto; e per questo Leopardi coinvolge anche i giovani, la sua è una poesia giovanile; dovete pensare che la poesia più famosa della letteratura italiana e tradotta in più lingue è L’infinito: è la poesia che ha più traduzioni in lingue europee, africane, ispano-americane, asiatiche, in arabo e in tante varianti del dialetto arabo. Questa poesia è stata scritta a ventuno anni, quando Leopardi è un giovane quasi della vostra età. Ma già a sedici, diciassette, diciotto anni Leopardi ha scritto dei versi e dei testi anche di riflessione che sono straordinari: La storia dell’astronomia, per esempio, e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi sono due opere in prosa filologiche, di grande erudizione che Leopardi ha scritto da adolescente, alla vostra età o anche qualche anno prima, perché aveva una formazione classica estesissima e una passione particolare per il mondo antico, per le lingue antiche. Dopo aver appreso benissimo il latino ed il greco (si adoperava già da adolescente a scrivere in greco e a leggere direttamente i greci) era passato a studiare l’ebraico, scriveva scorrevolmente in francese, leggeva l’inglese e lo spagnolo. Passioni di un adolescente che viveva a Recanati in un palazzo nobiliare, totalmente immerso in questa grande biblioteca paterna della quale sarebbe interessante raccontare tutta la storia – di come Leopardi ragazzo si trovò in casa sedicimila volumi e come il padre aveva raccolto tutti questi volumi. Leopardi è un poeta, un filosofo, uno scrittore che già nell’adolescenza comincia a pensare con profondità e a scrivere, e quindi voi ragazzi dovete sentirlo come prossimo, perché alla vostra età ha scritto grandi cose.
Dicevo delle Ricordanze: Leopardi definisce la ricordanza anche sul piano teorico. Leopardi infatti non è solo un poeta. È anzitutto uno che pensa: la sua poesia è il punto di filtro, è l’esperienza affinata, quasi distillata di un pensiero. Leopardi è un pensatore, un filosofo: lo Zibaldone – quella serie di quaderni che comincia a scrivere nel ’17-’18 e chiude nel ’32, quindi dai 19-20 anni fino ai 34 anni, che si porterà dietro in tutti gli spostamenti chiusi in alcune casse – è lo smisurato manoscritto che rappresenta il deposito di un pensiero filosofico straordinario, il più grande momento della filosofia italiana dell”800, ed è di un’intensità, di una ricchezza che si può definire una selva di saperi. Vi troviamo riflessioni di carattere metafisico, teorie letterarie, delle riflessioni sul gusto, sul piacere, sulla vita quotidiana, parti autobiografiche, riflessioni sulla politica, sul dispotismo, sull’eguaglianza, sul rapporto tra eguaglianza e potere, sulla scienza, sulla lingua e le lingue, sulle guerre, sull’antropologia, sugli animali: lo Zibaldone è davvero una miniera su cui dovreste ogni tanto sporgervi per prendere qualche passaggio, qualche elemento, qualche frammento. È un insieme di frammenti che si muovono verso tanti campi tematici più unitari.
Leopardi è un poeta che pensa. L’espressione è di Nietzsche, riferita appunto a Leopardi. Non dobbiamo separare, dunque, la poesia dalla filosofia di Leopardi. Quello di Leopardi è un Pensiero poetante (così intitolai il mio primo libro leopardiano, che proponeva appunto una lettura di Leopardi che non separasse la poesia dal pensiero filosofico). Nella filosofia leopardiana troviamo un’idea di filosofia diversa da quella tradizionale, e da quella moderna, ma una filosofia che si apre alla vita, come la poesia, una filosofia che diventa interrogativa, che non si chiude nel sistema, che attraversa il mondo della perplessità, del dubbio ed anche una filosofia che si pone come scrittura, così come nella poesia troviamo un movimento filosofico, interrogativo, aperto sulle domande ultime, sulle domande che più importano. Finalmente, dopo una serie di ristampe, Il pensiero poetante verrà stampato dalla Feltrinelli riversato in edizione economica (così potrà forse circolare tra i più giovani).
Voglio chiudere questa chiacchierata, cominciata dall’esperienza adolescenziale della luna ritrovata in Leopardi, se avete ancora qualche minuto di pazienza, ricordando la poesia L’Infinito che prima il professore Virgilio menzionava, perché è la poesia italiana, come ho già detto, più tradotta; è una poesia sulla quale anche degli scienziati e dei filosofi stranieri hanno detto che c’è un’idea di infinito che uno scienziato può condividere; quindi non è solo una poesia, ma è anche una meditazione, una riflessione scientifica sull’infinito. Adesso passo a leggerla mentre voi la ripasserete nella vostra mente. Se qualcuno non l’ha presente, la ascolti, anche se suppongo che tutti almeno una volta l’abbiate sentita, e poi cercherò di fare qualche osservazione su questa poesia:
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovviene l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
Ora dedichiamo qualche minuto alla riflessione intorno a questa grande poesia che, tra l’altro, per quelli che fanno l’ultimo anno del liceo, credo che sia una poesia da tener presente perché è proprio una specie di viatico che uno si porta con sé dopo il liceo. Qui potremmo sostare quanto vogliamo, ma vi assicuro che cercherò di essere il più breve possibile.
Una poesia di questo tipo ci fa pensare ad una voce nascosta: non è la mia voce che voi avete ascoltato prima, ma è la voce del poeta che ognuno di noi, leggendo una poesia, riesce a ricomporre. Per questo, L’ infinito può essere letto in tanti modi; per esempio c’è una lettura de L’infinito di un grande salentino come Carmelo Bene che sottolinea volutamente, nell’ultimo verso, il movimento di dilatazione assoluta. La voce va naufragando nel mare, e quindi c’è una specie di sospensione prolungata del finale. Carmelo Bene, se voi avrete l’occasione di ascoltare l’incisione della sua lettura de L’infinito, ha dato una sua interpretazione, perché ogni lettura è un’interpretazione, e ha voluto interpretare l’ultimo verso come veramente un perdersi della voce nel mare, perché Carmelo Bene dava molto rilievo a quello che lui chiamava phoné, appunto alla voce.
Il primo verso e l’ultimo verso hanno qualcosa in comune: Sempre caro mi fu quest’ermo colle e l’ultimo verso e il naufragar m’è dolce in questo mare: cosa c’ è in comune? Al centro del primo e dell’ultimo verso c’è “mi”, c’è l’io, c’è il corpo. Il corpo compare proprio nella poesia de L’infinito, una poesia dedicata all’infinito: ebbene, questa è la forza di Leopardi, parlare del corpo, rendere presente il corpo, i sensi, in una poesia che rappresenta un’odissea della mente, dell’immaginazione che tenta di rappresentare l’infinito. Sempre caro mi fu, quindi un movimento affettivo, il sempre, questo ermo colle, il colle solitario, e quella siepe; ma vedete subito, e questo l’avrete notato tutti, che la poesia de L’infinito non solo è la poesia della presenza del corpo, ma è una poesia della presenza forte del questo e del quello, la presenza di quegli elementi che i linguisti chiamano deittici, cioè gli aggettivi dimostrativi; questo e quello sono presenti quasi a voler tenersi attaccati a qualcosa di concreto; ma la poesia in realtà è come un tema musicale, ha due grandi movimenti: un primo movimento che è un adagio musicale vero e proprio, ed è un movimento molto aperto, per cui il poeta, quello che dice “io”, cerca di rappresentare, di rendere presente alla mente, nella mente, l’infinito, cerca di raccogliere, fingere, nella mente l’infinito. Ma questa esperienza, questa avventura porta a nulla, è un’esperienza che porta allo smarrimento, perché voler rappresentare l’infinito a partire dal limite, da quello che impedisce di vedere oltre, cioè dal colle, dalla siepe, dall’ultimo orizzonte, vuol dire immaginare, stare fermi, seduti – sedendo e mirando – in una posizione meditativa e contemplativa quasi orientale. È la contemplazione, analoga alla contemplazione dell’infinito rappresentata dal pittore romantico Friedrich (anche se lì il personaggio è in piedi). Per Leopardi questo vuol dire tentare di rappresentare l’infinito attraverso l’estremo, cioè gli interminati spazi, cioè spazi senza fine, non terminati, senza termine, i sovrumani silenzi, cioè silenzi al di là dell’umano, la profondissima quiete, cioè quiete più profonda del profondo: quindi la mente tenta di avere esperienza dell’eccesso, dell’oltre-limite e però si accorge che non riesce, nonostante questa grande odissea nell’estremo, a rappresentare l’infinito: il pensiero mostra il suo limite, la sua incapacità, e anzi il corpo ha un tremito, il cuore si spaura. E comincia un secondo movimento. Il secondo movimento comincia da un senso, l’udito: prima era la mente che immaginava, adesso è l’udire posto al centro dell’attenzione. È come l’ascolto dello stormire, tema romantico che ritroviamo nella poesia di Keats e d’ altri poeti.
Il poeta, il soggetto poetante, ode il vento tra le piante: questa presenza così concreta, così definita, del vento tra le piante porta il poeta ad una comparazione con quella forma dell’infinito spaziale e temporale che è l’eterno. Ma la comparazione non riesce perché il poeta che vuole comparare questa voce con quell’infinito silenzio, vuole, in questo momento, in questo istante, comparare la stagione che freme, che è viva e dall’altra parte invece, le morte stagioni, il tempo perduto, irreversibile, vuole mettere insieme, accostare il suono di questo tempo con il suono dell’oltre-tempo che è l’eterno; questa comparazione il poeta non la regge, non riesce a mettere insieme questa presenza vocale del vento con la cancellazione di questa presenza, questo tempo con l’altro tempo che non c’è più e quindi non può apparire di nuovo. Questo secondo tentativo di rappresentare l’infinito naufraga in quella immensità che il poeta cerca di evocare. Ed è l’esperienza di un naufragio dei sensi, della mente: l’impossibilità di dire l’infinito. Ma in questa odissea, in questa avventura della mente la poesia fa esperienza di un passaggio delle cose, dei sensi, dell’ascolto, della natura; si conosce, avverte che c’è un insondabile, un oltre-limite, un infinito di cui non possiamo mai appropriarci. La poesia de L’infinito è la poesia dell’esperienza forte dei sensi, del naufragio dei sensi, ma che ci dà la consapevolezza che al di là dei sensi vi è un oltre-limite; e dunque l’ultimo verso il naufragar m’è dolce in questo mare fa apparire il corpo come una zattera. In questo naufragio c’è un io, un corpo che è la zattera a cui mi attacco per sopravvivere. Un richiamo dei sensi, della loro dolcezza, proprio in questa impossibilità di dire l’infinito. Il pensiero mostra la sua impotenza: L’infinito è una poesia che dice come il pensiero dell’uomo sia impotente nel rappresentare l’infinito. La filosofia, d’altra parte, non può dire l’infinito perché l’infinito coincide col nulla (lo dirà Leopardi nello Zibaldone) e l’infinito e il nulla non si possono dire se non nel linguaggio. In quanto linguaggio non sono più infinito, ma parole, figure, approssimazioni. In questo naufragio, dicevo, c’è il corpo dell’uomo che resiste, c’è il piacere (il naufragar m’è dolce) di questa avventura dell’immaginazione, di questa esperienza che attraversa il limite e guarda verso un infinito di per sé irrappresentabile, indicibile. Questa, in Leopardi, e concludo davvero, è l’esperienza della poesia: cioè L’infinito è una poesia sulla poesia, ci racconta qual è l’esperienza vera, profonda, della poesia: voler dire l’infinito e riconoscere l’impotenza del pensiero, e della lingua poetica, a dire l’infinito. E questa è una grande esperienza del linguaggio, che coincide con un’esperienza di sé, del corpo.
Questo direi che è in poche parole, riassuntivamente, ciò che possiamo pensare intorno a questa poesia, per tornare poi a rileggerla con un’attenzione che si depositi tra verso e verso, tra parola e parola e tra i silenzi, perché in ogni poesia sono importanti i silenzi ed in particolare L’infinito è costruito da tanti silenzi che sono come il vero infinito: sono quei silenzi che si depositano tra le parole, che la parola non riesce ad accogliere ma che stanno lì, tra le parole, ed è importante che stiano lì; quella è la vera presenza dell’infinito, che non può diventare parola, non può diventare linguaggio. Grazie.
(Molti e calorosi applausi)

 Prestare parola al desiderio.
Prestare parola al desiderio. La linea leopardiana della prosa - Gianni Celati
La linea leopardiana della prosa - Gianni Celati Quando lo stupore finisce davvero - Enrico De Vivo
Quando lo stupore finisce davvero - Enrico De Vivo Arte didascalica. Il mio pomeriggio al cinema con Martone e Leopardi - Simona Carretta
Arte didascalica. Il mio pomeriggio al cinema con Martone e Leopardi - Simona Carretta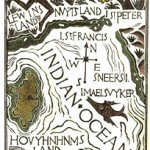 Soyumba
Soyumba Ricordando Pascal Gabellone
Ricordando Pascal Gabellone Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione
Leopardi tra le lingue: traduzione, imitazione, affabulazione Un racconto per Cécile
Un racconto per Cécile





















