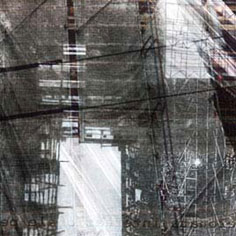
L'immagine è le lettera "B" della serie Frammentato abbecedario di un viaggio, di Raffaella Garavini.
Timeo Danaos et dona ferentes”
Virgilio, Eneide, II, 49
… contro la rinuncia preventiva a qualsiasi contatto
con l’altro che possa minacciare la compattezza
dell’individuo, [Bataille] cerca la comunità in un
contagio provocato dalla rottura dei confini individuali
e dalla infezione reciproca delle ferite”Roberto Esposito, Communitas, Einaudi 1998, p. 142
A cosa serve quello che scriviamo? Che valore ha quello che leggiamo? Scrivere e leggere sono ancora attività utili alla comunità nella quale viviamo? Esiste davvero la libertà per tutti di scrivere e di leggere? Negli ultimi mesi, a partire da questi interrogativi, abbiamo trascorso una buona parte del nostro tempo a dialogare con persone anche diversissime da noi in un blog collettivo ( www.nazioneindiana.com ) e a meditare contemporaneamente su quella che noi definiamo la “comunità avvenire”: ovvero una comunità che non si costituisce a partire dal potere attribuito dai mediatori culturali e dal sistema letterario dominante a pochi e sparuti servitori, che non accetta le briciole di chi ha già sbafato; quindi la comunità di chi non tollera gli striminziti spazi che le sono concessi, e che si fonda a partire dalle proprie forze e dalle proprie idee, a partire da qui, dal presente che è già futuro, se vissuto con passione e intensità.
Nei nostri sforzi di avviare una discussione a partire da tali domande e argomenti – prima che dai nostri gusti letterari e dalle poetiche e individualità artistiche – abbiamo dovuto affrontare non poche difficoltà, intemperanze e silenzi degli altri, e siamo stati costretti a difenderci e ad aggredire anche noi. Ma alla fine un contributo siamo riusciti a strapparlo a molti e ci lusinghiamo di averlo dato anche noi, nel nostro piccolo, alla discussione ancora in corso.
Nei mesi scorsi (a partire dal luglio scorso), dunque, è nata una polemica culturale e letteraria, sviluppatasi, come dicevamo, sulle colonne virtuali del blog collettivo Nazione Indiana, dove si sono intrecciati i pensieri di autori e commentatori in gran numero. Il blog è uno strumento particolarissimo, “nuovo”, che consente, a chi ne abbia voglia, di gestire senza spese e con facilità una pagina internet e di dialogare con i lettori e visitatori intorno agli argomenti più svariati. In genere, l’uso che si fa del blog è diaristico, pertanto sono per lo più scritture semiprivate e personali quelle che vengono alla ribalta. Ma ci sono anche blog usati in maniera più particolare, collettivamente o per trasmettere contenuti politici, culturali o di altra natura. Nazione Indiana è un blog collettivo gestito da una dozzina di scrittori, uomini di teatro, cineasti, artisti diversi che autonomamente, senza alcun filtro redazionale, pubblicano ciascuno le cose che preferiscono: articoli, brevi o lunghi saggi, lettere, interventi di attualità, racconti, poesie. Una delle caratteristiche del blog è lo spazio riservato ai “commenti”, quindi la possibilità, per il lettore, di inserire in tempo reale propri scritti o anche brevi pensieri e commenti relativi ai differenti testi.
Noi ora, nel ricostruire la polemica che si è sviluppata in Nazione Indiana e per dare una risposta alle domande dalle quali abbiamo preso l’avvio, abbiamo tagliato e scremato molto, per recuperare il recuperabile, e cioè tutto quello che con le questioni attinenti al dibattito andava salvato. In un blog, dove la finestra dei commenti è aperta a tutti, di interventi ne arrivano tanti, stucchevoli gli uni, ributtanti altri, altri ancora interessanti, ma fuori tema. Ma perché, in una finestra di commenti può esserci un tema? Il nostro sforzo è stato quello di proporlo e riproporlo, e ci scusiamo con tutti se a volte abbiamo dovuto dare l’impressione di insistere un po’ troppo su certi argomenti. In ogni caso, crediamo che entro un calderone di verdure, uno possa sempre scegliere quelle che più gli piacciono. Così un blog può essere letto in molti modi. Che sia legittimo anche il nostro? Noi lo speriamo vivamente, ma soprattutto speriamo con questa selezione di aver impostato nelle sue linee portanti il dibattito sulla “comunità avvenire”, che può essere, deve essere ancora sviluppato, il che ci proponiamo di fare sulle colonne di Zibaldoni e altre meraviglie.
Stroncare un libro o mostrarne, al contrario, le virtù riposte, raccontare una bella storia o raccogliere i propri pensieri in uno zibaldone, sono tutti modi per contribuire all’edificazione della “comunità avvenire”. Purtroppo però non è cosa facile dare l’avvio a una simile costruzione. Abitiamo tra le rovine di una collettività dispersa e fatta a pezzi, riedificata poi, o meglio, gonfiata come fosse una bambola di plastica da chi comanda la “comunità data”. Sta a noi sgonfiare lentamente quella bambola, ricostruire sulle rovine, riedificare una casa abitabile. Sta a noi tutti radunare le diverse esperienze, riunirci e comunicare, dare vita al futuro. Questa selezione vuole essere un contributo preliminare alla “comunità avvenire” di cui tanto si è discusso. Ad essa è dedicata.
P.S.: Per i nomi degli autori degli interventi che abbiamo estrapolato dai “commenti” del sito di Nazione Indiana, non ci assumiamo alcuna responsabilità. Diamo per scontato, non avendo letto smentite nel corso del dibattito, che tali nomi siano reali, ma siamo consapevoli che, essendo possibile, in un blog, assumere nicknames, qualcuno potrebbe aver ben dichiarato un nome falso. Pertanto, se le persone citate dovessero riconoscere che quanto è scritto qui a loro nome non corrisponde a quello che hanno scritto o pensano, possono scriverci e comunicarcelo a info@zibaldoni.it. Provvederemo immediatamente a rettificare.
*
La discussione ha inizio su L’Unità dell’11 luglio 2003, p. 25, in cui compare un articolo a firma di Carla Benedetti dal titolo L’Occidente senza l’altro, che viene ripreso nel blog collettivo Nazione Indiana il 14 luglio col titolo Prendersi sul serio: la nuova eresia. Benedetti rinviene nella “società occidentale tardomoderna” un “nuovo dogma” che così formula:
“Ogni cosa, dunque, può avere il suo posto nel mondo, purché rinunci alla propria radicalità”. Il che significa che per “l’ideologia artistica dominante, euforicamente terminale, ironicamente repressiva”, “pretendere di esprimere un impensato è infatti l’eresia massima”.
*
Il giorno dopo, 15 luglio, Tiziano Scarpa pubblica in Nazione Indiana un nostro commento all’articolo di Benedetti, dal titolo Che cos’è oggi la radicalità?, nel quale, riprendendo le tesi di Benedetti, aggiungiamo che ognuno nel suo campo dovrebbe perseguire sempre il “bene della comunità”, “senza farsi trascinare dalle menzogne che ad ogni piè sospinto trasudano dai mass media e dalla cultura televisiva”; concludendo poi con una domanda:
“È possibile dire qualcosa di non contaminato dalla logica dei mass media…? È ancora possibile, oggi, per i letterati, la ‘radicalità’?”
*
L’11 luglio in Pontiggia e gli altri, Helena Janeczek ritorna sul tema della comunità e del ruolo dello scrittore:
“Però credo che come indica il suo [di Pontiggia] esempio, possiamo recuperare a modo nostro l’idea che fare gli scrittori (i poeti, i critici ecc.) significhi anche assumersi un ruolo e una responsabilità nei confronti di una società letteraria che è ormai irriconoscibile…”.
*
Le risponde lo stesso giorno Benedetti in Pontiggia e la collettività che manca:
“…è importante il senso di collettività. Ma faccio fatica a identificarlo con la “società letteraria”, neanche con quella appena passata (quella dei Pontiggia, per intenderci).
Ho aderito a Nazione Indiana anche perché non è una collettività di letterati (…). E perché uno dei nostri desideri più forti è di creare nell’intero campo della cultura (compresa la politica e il giornalismo) quel tessuto connettivo di scambio, senza il quale ogni lavoro individuale deperisce. Uno dei nomi che avevamo pensato era addirittura quello di Vasi comunicanti – che ora è rimasto come titolo di una sezione.
Questa vasocomunicazione oggi manca in Italia. Al suo posto c’è una comunicazione orizzontale che ha per modello la pubblicità, con le sue regole di promozione e autopromozione, con le sue modalità di posizionamento nel discorso. Cioè un vuoto spaventoso…”.
*
Nel dibattito tra Benedetti e Janeczek il 15 luglio interveniamo noi con un articolo dal titolo Che cosa è possibile oggi? in cui scriviamo:
“…nella nostra società, dove tutto è permesso, ma dove, di fatto, nulla lo è realmente, l’unica cosa che non è permessa realmente è la costituzione di una comunità alternativa, cioè di una comunità che regoli i suoi rapporti in modo diverso rispetto al modo in cui li regola la società. Che possa esistere una società in cui all’utile è preferibile il piacevole, alla precisione, il caos, alla leggerezza, la pesantezza dell’esistenza, ai buoni sentimenti i cattivi sentimenti, ai corpi scolpiti nelle palestre i corpi plasmati dall’ambiente, tutto questo il potere non lo potrebbe tollerare (e non lo tollera), neppure se fosse rappresentato in effigie”.
E avanziamo la nostra proposta:
“La risposta noi l’abbiamo rinvenuta in un testo di quasi due secoli fa, nello Zibaldone di Giacomo Leopardi, che a nostro avviso ha coniugato la radicalità critica con la creazione letteraria, scrivendo giorno dopo giorno un’opera che non era destinata al mercato editoriale (che ne sarebbe inorridito), ma a fungere da esempio di come si possa creare una breccia nei rapporti di potere – criticandone le false illusioni – anche standone fuori, nella biblioteca di un paese di provincia. Oggi il web ci offre l’occasione per mettere a frutto in maniera nuova la lezione di Leopardi, in una raccolta di testi che nessun mediatore culturale potrà promuovere o bocciare, perché essa si farà da sé superando il solo esame del meraviglioso e dell’impensato; perché noi siamo convinti che la letteratura non sia affatto finita né siano finite le storie insolite da raccontare, e che la rivista-zibaldone può assolvere questo compito, di raccogliere ad infinitum le innumerevoli narrazioni oltre che il lavoro critico necessario a farci distinguere la spazzatura dalle cose che meritano di essere lette. Forse questa è solo una delle azioni di “allagamento di vasi” che oggi sono possibili, ma noi non ne vediamo tante altre nel panorama grigio che ci circonda. E visto che di possibili parliamo, è possibile che Benedetti, mettendo da parte per poco la sua acribia critica, o meglio, mettendola a frutto, ci parli della pars construens del suo pensiero? Che cosa vieta che questa volta si riparta da qui?”
*
Qualche giorno dopo, il 22 luglio, torniamo a sollecitare lettori e redattori di Nazione Indiana con un intervento dal titolo APAX:
“C’è qualcosa di misterioso in questo continuo invito, da più parti, a discutere intorno alla questione della “comunità inesistente”. Spesso l’invito arriva e suscita entusiasmi in tutti, ma all’improvviso vi si fa il vuoto intorno e cade, si smorza, si spegne. Come mai?
(…) Nemmeno tra i fondatori di ‘NI’ c’è stato chi ha ripreso questi temi, nonostante ‘NI’ abbia tra i suoi obiettivi espliciti quello di mettere in “vasocomunicazione” le energie. (…) Come mai, allora, questo silenzio? Vuoi vedere che tutto questo discorrere di comunità è l’ennesimo imbroglio teorico che con la prassi non ha nulla a che vedere? Perché la prassi, ancora una volta, è quella che mira soltanto all’esibizione in vetrina delle proprie scritture (…)?
L’impressione che spesso siamo (tutti) delle monadi incomunicanti (altro che vasi!) è fortissima. Come mai, poi, proprio qui? Come mai la comunità – invocata – non reagisce? Cosa c’è che non va? Noi qualche ipotesi ce l’avremmo per cominciare a smatassare questo griummolo, ma ci fermiamo qui, anche perché il legittimo sospetto di parlare nel vuoto, a questo punto, ci invita a sgranellare il rosario del silenzio”.
*
Il 24 luglio Benedetti pubblica sull’Espresso, n. 30, e poi in il 29 luglio su Nazione Indiana, L’uomo che ride, in cui si chiede:
“Cosa sta succedendo in Italia? Un paese lacerato da conflitti: un paese che ride.
Lo scatto, gioioso o satirico, del riso è un forza liberatoria, dirompente, contro la plumbea seriosità del potere e delle sue gabbie concettuali. Ma questa risata generalizzata in cui si incanala la voce di tutti, del governo e dell’opposizione, della televisione e della scrittura, non ha più antagonisti. Non solo il potere si esprime con battute, ma la battuta ironica o sarcastica è diventata una modalità comunicativa coatta. Il riso si staglia su tutte le bocche e non si capisce cosa dovrebbe rovesciare. È un paradosso, ma oggi la serietà è più eversiva. Proprio in quanto non ammessa.
Questa paresi facciale della comunicazione non ammette, e quindi reprime, altre modalità di espressione. Obbliga a spezzettare lo spazio del ragionamento in piccole schegge. A alleggerirti di ogni contenuto propositivo antagonista, di ogni disperazione o conflitto. Eppure ci sono cose che non si possono dire senza il tempo lungo dell’articolazione del pensiero. E ci sono anche cose di cui non si può parlare senza indignazione. Altrimenti dai per scontato che siano inevitabili, che tutto ciò che accade è necessario, e non può che essere così”.
*
Il 30 luglio Raul Montanari pubblica La verità, vi prego, sul sesso: parlano gli uomini, un pezzo già pubblicato in Glamour, che scatena le critiche di molti commentatori, per lo più negative, sintetizzabili nel giudizio di Gustavo Paradiso:
“Lo stile di Montanari è esattamente quello che il mercato vuole, e coincide con quello che la signora Benedetti si affretta a voler demolire giorno per giorno senza farci capire perché, cioè in cambio di che cosa o per che cosa”.
*
A noi, intanto, il 3 agosto Carla Benedetti risponde con questa lettera:
“Cari Enrico De Vivo e Gianluca Virgilio,
ho letto con attenzione i vostri commenti, fatto tesoro, aperto file mentali da riempire per il futuro…. Ma vi rendete conto che quando avete mandato il vostro primo commento era già luglio inoltrato, e ora è ormai agosto, periodo di ferie anche per i collaboratori di Nazione Indiana? Cos’è questa pretesa di volere vedere il dibattito dispiegarsi al meglio, con tutti le voci presenti, che si arricchiscono a vicenda, in una settimana, per di più nell’ultima settimana di luglio?
Ho già detto queste cose a Marco Rizzo, in un commento che ho inserito in Nazione Indiana, e che qui vi riporto in parte:
“Vuole che facciamo crescere in un battibaleno quella collettività che non
c’è (e a cui stiamo nel nostro piccolo lavorando), con tempi televisivi?
Cos’è questa impazienza? Non siamo mica una trasmissione con il pubblico che interviene in diretta telefonica! È ridicolo tutto ciò. Vuole lo spettacolo e subito? Può cercarlo da altre parti. Qui abbiamo tempi più lunghi. Magari non combineremo niente, ma almeno ci lasci provare, con i tempi e le modalità che ci siamo scelti”.
E poi soprattutto mi pare che chi scrive commenti nel sito lo faccia quasi sempre mettendosi in un ruolo passivo, quello dello spettatore che sta seduto in poltrona a guardare i programmi… Invece di contribuire con idee, proposte, riflessioni, si lagna di ciò che nel sito manca, di ciò che a sua detta si dovrebbe fare e non si fa.
Non so che cosa succede sul vostro blog, ma su Nazione Indiana non ho mai trovato, tranne in rari casi (tra cui il vostro), dei commenti che contribuissero davvero a un qualsiasi dibattito. Per lo più sberleffi rancorosi, ricerca del pretesto per aggredire i collaboratori, e poi un’incredibile quantità di lagnanze per disservizio, quasi fossimo, non una rivista o uno spazio di discussione, ma appunto un servizio pubblico di erogazione del gas! Nessuno che parli mai di cose, di idee, di problemi, di opere. Nessuno che faccia delle obiezioni severe ma vere, nel merito di cose, argomenti, idee.
C’è qualcosa di distorto in questa comunicazione che il blog apre, non so dire cosa , ci devo pensare meglio. C’è tanto narcisismo infelice, dispiegato in maniera cattiva, nessun rispetto per la differenza, per l’impegno altrui, ma solo ricerca continua del pretesto per aggredire, per prendere in castagna l’altro, per denigrarlo… Cosa ne pensate voi, in base alla vostra esperienza di Zibaldoni e altre meraviglie? Un cordiale saluto”.
*
Noi rispondiamo il 6 agosto a Benedetti, chiarendo quali sono le modalità del nostro lavoro, con uno scritto dal titolo La collettività che manca, che Carla Benedetti pubblica in Nazione Indiana, premettendo la seguente breve introduzione:
“Molti dei commenti ricevuti, anche dei più critici verso Nazione Indiana, contengono riflessioni importanti che vorrei riprendere, con i miei tempi, e con i miei modi, superando quel tono conflittuale che, a un certo punto, sembra aver preso il sopravvento. Così mi auguro che facciano anche gli altri collaboratori di Nazione Indiana. Intanto, prima di congedarci per le ferie, pubblico questa interessante doppia lettera mandata da Zibaldoni e altre meraviglie, la prima indirizzata a me, la seconda ai Lettori e scrittori di Nazione indiana (C.B.)”.
Ecco uno stralcio dal nostro testo:
“(…) Secondo noi, una comunità intellettuale può nascere solo dall’amicizia (intesa, platonicamente, come Eros che favorisce l’intonazione comune, non come melassa), dal desiderio di contribuire attraverso un’opera comune all’edificazione di qualcosa che infine oltrepassi noi stessi e faccia bene al mondo. Non a caso abbiamo scelto di fondare una rivista – alla quale, nonostante tutta l’anzianità di strumento e la tradizionalità, “si torna sempre”, come diceva Roland Barthes. La rivista è il luogo ideale per il dibattito delle idee (e non a caso pochi amano oggi le riviste, primi fra tutti gli editori, ma anche gli scrittorucoli pervenuti), in cui il contributo personale serve a un discorso comune in vista del superamento di se stessi.
La rivista non è un BLOG, non può mai esserlo, con tutta la buona volontà. Nel BLOG, qualsiasi forma esso abbia, si resta pesantemente ancorati all’ego, all’esibizione da vetrina, non si oltrepassa mai se stessi (e la sua analisi, a proposito di queste forme di scrittura, è esattissima). L’impedimento principale è la struttura stessa del BLOG: autoreferenziale, chiusa, narcisistica. La rivista è esattamente il contrario: in essa l’amicizia, come nei dialoghi platonici, è il presupposto necessario per la ricerca della verità, è l’unica condizione che può fondare e dare senso alla ricerca di un luogo e di un discorso comuni”.
*
Poi, rivolgendoci ai lettori e scrittori di Nazione Indiana, così cerchiamo di spiegare il motivo per cui Benedetti si era astenuta dall’intervenire più decisamente nel dibattito:
“…secondo noi Benedetti svicola e aggredisce perché l’obiettivo (del suo discorso) non è (ancora) stabilire chi sono gli scrittori e quali sono i modi poetici di espressione che vanno incoraggiati. Benedetti è ancora al di qua di un tale ragionamento, perché forse punta prima di tutto a definire in che maniera e se si può parlare (ancora) di una comunità letteraria o intellettuale nel mondo attuale. Naturalmente, leggendo la sua ultima missiva, verrebbe di pensare immediatamente che una comunità del genere di quella immaginata da “Nazione Indiana” è ben lontana dall’avverarsi. Se, infatti, la falsa comunità dei pedanti che governano le diverse discipline è chiaramente improponibile, questa qui in cui siamo, in cui molti di quelli che scrivono lo fanno innanzitutto per lasciare una traccia più o meno narcisistica di loro stessi, non è certo la “vera” comunità che tutti auspicano. Ecco l’atroce dilemma che, a nostro avviso, non consente (ancora) a Benedetti di affrontare le pur serissime questioni che noi e altri avevamo posto.
Se prima, infatti, non si scioglie questo nodo delle modalità della partecipazione, diciamo così, questo nodo tutto politico, a che serve – giustamente – perfino discutere di letteratura, di cinema o di qualsiasi altra cosa? Se, come qualcuno ha scritto qualche tempo fa, ci hanno rubato l’anima, come è possibile anche solo immaginare di impegnarsi in imprese tanto ardite e gagliarde come l’edificazione di una comunità letteraria e intellettuale, che dal possesso di certe facoltà profonde non può prescindere? A pensarci bene, quando abbiamo dato vita alla nostra rivista, partivamo anche noi da presupposti del genere: volevamo una comunità, non ci bastava essere o desiderare di essere scrittori, artisti, etc. Anzi, a voler dirla tutta, le stesse definizioni di “scrittore”, “artista”, etc. ci sembravano, e ci sembrano, assolutamente inadeguate. E poi, non è mai bastato a nessuno scrittore, in nessuna epoca, scrivere e basta, dipingere e basta, musicare e basta – se poi non esisteva un pubblico almeno immaginabile per le proprie opere. Un pubblico almeno immaginabile, cioè una comunità: perché senza comunità l’atto creativo è generato dal nulla e cade nel vuoto, nel narcisismo.
Noi – oltre tre anni fa – eravamo sperduti, isolati, in paesi lontani, ognuno con la sua bella poetica, i suoi manufatti aggraziati, i suoi scartafacci. Ma sentivamo una mancanza. Non ci fregava niente dei critici che scrivevano sui giornali i loro canoni per fare i loro loschi affari, volevamo mettere insieme degli scrittori e degli artisti con la nostra stessa esigenza/urgenza di comunità, non ci fregava assolutamente nulla degli editori e di pubblicare libri. Il progetto degli “zibaldoni” poteva essere il giusto punto di partenza: era un’idea aggregante, malleabile, versatile, che ci consentiva innanzitutto di girovagare in tutte le direzioni possibili per edificare quella cosa che ci mancava e che ci aveva spinto ad agire: la comunità. Inoltre era, questa nostra, un’idea “militante” fino in fondo: cosa c’è, infatti, di più naturale e antimercantile di un prodotto che non è un prodotto, di un libro che non è (ancora) un libro, quale appunto è uno zibaldone? Abbiamo capito che in questo modo potevamo aprirci tutte le strade verso la ricerca artistica, che è la cosa che maggiormente ci preme e ci spinge ad agire: ripetiamo, in un mondo nel quale conta solamente il prodotto finito e vendibile, non il prodotto in divenire, scabro, incompiuto.
Se dovessimo fare una considerazione a partire da quel poco che abbiamo fin qui costruito, forse diremmo che porre le basi all’interno di forme ben definite, come ad esempio una rivista, è un possibile punto di avvio – ferma restando la chiarissima coscienza del furto delle anime che abbiamo già subito e delle quali dobbiamo prima riappropriarci se vogliamo almeno cominciare a parlare. Ci tocca scontare questo gran castigo, che è la fatica del recupero di un’anima, attraverso azioni dure, scontri e polemiche, incomprensioni e disfacimenti. Dobbiamo farci capaci che qui è come essere sopravvissuti a una catastrofe, dopo la quale ci siamo ritrovati tutti muti: dobbiamo ritrovare un modo per parlare insieme, per capirci, dopo essere partiti alla ricerca della luce del “discorso comune”, per dirla con Eraclito. In un secondo momento verrà la discussione sullo scrittore e sulla sua poetica, anzi, come fa intuire Benedetti, questo è davvero l’ultimo cruccio.
Però, se nel corso di questa ricerca un qualche scrittore con la sua bella e rispettabilissima poetica non avrà mai offerto contributi al “discorso comune” suddetto, evitando di confrontarsi sulle possibilità dell'”armonia discorde”, volete dirci perché mai dovremmo leggerlo, oggi che tutti sanno scrivere un romanzo, una sceneggiatura e un sonetto, oggi che tutti sanno “far finta” con la penna in mano? Noi siamo convintissimi che se nelle opere (testi e azioni) odierne non vibra l’ardore della ricerca di una comunità, della ricerca del punto di intonazione comune, è bene non prenderle nemmeno in considerazione. Senza troppi patemi. Perché abbiamo bisogno di strade chiare da seguire per raggiungere il nostro obiettivo, e non dobbiamo ammettere distrazioni o indulgere a chicchessia. Chi scrive cazzate deve essere stigmatizzato; chi allestisce letteratura per fare spettacoli, per divertimento, per fare audience, deve essere messo da parte; chi scrive senza avere negli occhi e nel cuore la luce della comunità a venire, che parli pure da solo, tra lo squallore dei convitati di cera dei talk show.
Non bisogna aver paura nemmeno delle deviazioni che vengon fuori qui dentro, in Nazione Indiana. Si paga un prezzo per costruire qualsiasi cosa. Per quello che vogliamo costruire noi tutti qui dentro e anche fuori, si paga sulla propria pelle un prezzo durissimo, atroce. Benedetti ne sa qualcosa, come ne sappiamo qualcosa noi che facciamo Zibaldoni e altre meraviglie, e molti altri. Ma il prezzo pagato vale l’acquisto, ne siamo certi. Far cadere le proprie parole non nel vuoto, ma nel pieno di una comunità che ascolta e che cerca la verità, è un grande risultato, grandissimo. Non bisogna scoraggiarsi, né seminare rancori, né coltivare dispiaceri – e nemmeno allibirsi troppo spesso. Cosa credevamo, che bastasse metter su un paio di siti internet per riavere belle e pronte, integre, le nostre anime che ci hanno rubato, ovvero l’anima oltraggiata della comunità inesistente? Che ingenui! Bisogna sudare ancora, invece, sforzarsi, argomentare, perder tempo, scriversi, non comprendersi, poi cominciare a comprendersi, fino alla fine. L’unica cosa che conta, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è aver presente e vivo come un fuoco inestinguibile il punto luminosissimo comune verso cui tendere incessantemente. Il punto verso cui concorrono le voci discordi, e in cui finalmente si ricompone l’unità dei molteplici”.
*
Il 9 agosto Antonio Moresco pubblica Lettera da Leuca 1 e 2, e la discussione iniziata prima intorno agli articolo di Benedetti e poi a commento del pezzo di Montanari, immediatamente si sposta nei commenti al primo dei due pezzi di Moresco. Riportiamo la seconda parte del post di Gustavo Paradiso del 13 agosto, relativo a Moresco:
“Parliamo d’altro, dunque, evitando di continuare una sterile polemica, ma evitando anche i toni esulcerati di Moresco, che dovrebbe smetterla di rigirarsi il coltello nelle piaghe, e finalmente contribuire al dibattito non solo criticando i limiti dello scrittore alla Simenon, ma anche dicendo che cosa intende fare o già fa per non rimanere pure lui vittima di questo sistema industrial-artistico-letterario in cui un Montanari sguazza come il pesce nell’acqua.
L’analisi di Moresco del panorama culturale e letterario è impietosa e non lascia spazio a molte speranze. Ma il problema che ogni volta si ripresenta, ogni volta che l’analisi è compiuta, è, come dicevano quelli di Zibaldoni: che fare? Come rispondere a chi vorrebbe fare di noi dei funzionari della letteratura, a chi ci paga perché le nostre opere non superino il limite di Simenon (o di Montanari)? Che cosa facciamo noi nel concreto della nostra esperienza di vita per non cedere alle tentazioni del potente che vorrebbe fare di noi i suoi servi? Quale strategia d’azione noi siamo in grado di immaginare per non rimanere schiacciati dall’ingranaggio della macchina cultural-industriale che ci stritola mentre ci accarezza e ci lascia alla nostra solitudine, peggiore di quella solitudine alla quale pensavamo di essere scampati alle prime luci della ribalta? È forse sufficiente continuare a scrivere, ognuno nello spazio della sua venerabile poetica, senza alcuna coscienza (o con una falsa coscienza) del mondo nel quale viviamo e scriviamo? Compiuta l’analisi, sulla quale nessuno può nutrire molti dubbi, queste sono le domande a cui bisogna oggi cercare una risposta, perché ne va della nostra vita, prima che del cosiddetto sistema letterario.
Ebbene, l’esperienza della rete, del comunicare attraverso bit immateriali che trasportano così lontano le nostre idee e le nostre emozioni, mi sta convincendo sempre di più che è possibile immaginarsi una comunità “vera” saltando ogni mediazione di potere. Non si tratta di fare qui l’apologia della “libertà d’espressione”, perché qualsiasi libertà, se imposta dall’alto o dall’esterno, è sempre una libertà vigilata – e a tale logica non sfugge internet. Però la libertà che in internet ancora è possibile (forse non lo sarà a lungo), va sfruttata nel modo più intelligente, da parte di chi è interessato alle analisi fatte fin qui dalla Benedetti, da Moresco, da quelli di Zibaldoni e da tanti altri. Non va, ad esempio, vissuta passivamente o narcisisticamente come dalla maggior parte dei bloggers, ma non va nemmeno sottovalutata come di solito avviene da parte di tante anime belle. Va interpretata, va trasformata in letteratura, in forma che riforma e travolge. Se gli autori dei BLOG fossero degli scrittori, dei “veri scrittori”, forse avremmo finalmente la comunità che sogniamo, in cui la parola è segno di libertà e creatività insieme. Ma il guaio è che spesso i bloggers sono narcisi che, senza rischiare nulla, sognano di diventare “scrittori” nella maniera più deleteria possibile, ossia trasformandosi in “autori citabili”, o qualcosa del genere, e seppellendo tutto sotto una cumulo di prosaicità archiviabile e di tristezza inflazionata. Nessuno di loro cerca di capire perché, come sostengono quelli di Zibaldoni, nell’era della “comunicazione globale”, le nostre vite sono precipitate nell’abisso dell'(in)comunicabilità e la letteratura è ridotta ad accessorio ignobile del cinema o della tv.
Allora è sulle forme di internet che bisogna lavorare insieme, oltre che, individualmente, sulle nuove forme della letteratura; sulle potenzialità ancora (ma fino a quando?) disponibili della rete, come sta facendo NI, e come fanno altri forse ancora meglio. Non bisogna limitarsi a ‘comunicarci’ le nostre esperienze artistiche e di vita, non bisogna fermarsi alla prosaicità del mezzo tecnologico, al suo livello più basso, ma andare oltre, più in alto, e ‘raccontare’ le nostre storie, quante più storie, ipotesi, idee, è possibile, senza chiedere il permesso a nessuno che garantisca per noi, come fa Montanari, fidando solo nella nostra buona fede (fino a prova contraria) e nella sincerità creativa della parola – arrivando al punto in cui la letteratura sia opera di “scrittori che scrivono”, non di “scrittori che hanno scritto”. Lo “scrittore che scrive” può ancora scrivere tutto e liberare così tutta la potenza della parola; lo “scrittore che ha scritto” è solo uno strumento d’autorità nelle mani del cupo potere costituito, dei mediatori e degli editori. “Fare un uso improprio della letteratura” – questa frase così intrigante citata da Carla Benedetti, forse è questo che vuol dire: affidare la letteratura agli “scrittori che scrivono”.
Nulla, al momento, mi impedisce di pensare che giorno verrà che nessuno farà più un’esperienza come quella che racconta Moresco (il rifiuto di Pontiggia a Segrate) e nessuno si sentirà umiliato perché la sua buona fede è stata calpestata e la sua urgenza repressa. Ma perché ciò accada, bisogna lasciare aperta la porta del futuro, non adagiarsi in geremiadi senza scampo, continuare a guardare l’orizzonte leucano con fiducia che qualcosa possa da lì venire da un momento all’altro verso di noi. E nel frattempo operare nell’unico modo possibile, cioè contribuendo nel proprio piccolo a fondare e costruire quella comunità, sulla quale, come Moresco saprà, tanto si è discorso su NI nel mese di luglio e in queste prime settimane di agosto, e sulla quale forse è bene tenere sempre aperta la discussione; poiché mi appare chiaro che solo così la comunità si forma e si rinsalda. Questa è la mia unica speranza.
E lei, Moresco, che cosa ne pensa?”
*
Il 14 agosto Antonio Moresco risponde a Paradiso:
“Per quanto mi riguarda, mi pareva di aver evidenziato nel mio scritto un drammatico scontro in atto e una breccia da allargare nella tenaglia tra la “letteratura di genere” e quella che ho chiamato “genere letteratura”. Non solo di aver criticato Simenon e altri per il solo gusto di criticarli. Ma lei ingiunge: “Cosa intende fare o già fa per non rimanere pure lei vittima di questo sistema industrial-artistico-letterario?” Le posso solo dire che il mio lavoro di scrittore -buono o cattivo che sia- è lì, sotto gli occhi di tutti. Sta a lei stabilire di quale pasta sia fatto e in che direzione si muova. Mi accusa poi, implicitamente, di aver fatto delle “geremiadi senza scampo”. A me sembra invece di avere fatto il contrario. Ma se, dopo aver letto il mio pezzo per intero e da cima a fondo, è così che la pensa, io non possiedo evidentemente altre parole in grado di dimostrarle il contrario.
Mi pare, da quel poco che vedo e capisco, che domini in rete (non solo in rete ma un po’ dappertutto, anche se in rete viene forse enfatizzato al massimo) uno stile di confronto che stravolge e assottiglia il senso, lo spessore e l’urgenza delle argomentazioni, giuste o sbagliate che siano, scavalcando e banalizzando in vario modo i problemi che si cerca di porre. Io non ho certo nostalgia per i galatei e non ho paura della radicalità e della sincerità. Ma un confronto su queste basi è impossibile, non serve a niente, è da rifiutare.
Altra cosa. Vedo che lei divide con un colpo d’accetta “lo ‘scrittore che scrive’, che può ancora scrivere tutto e liberare così la potenza della parola, e lo ‘scrittore che ha scritto’, che è solo uno strumento d’autorità, ecc…” Lei sa -perché mi rimprovera di averlo ricordato- che solo all’età di 45 anni sono riuscito a pubblicare ciò che avevo scritto a 30 e ancora stavo scrivendo. Allora le chiedo: secondo lei, nel momento della pubblicazione, i miei scritti e la mia persona, che fino a un istante prima erano una cosa, sono diventati improvvisamente e quasi per magia un’altra cosa? La loro intima natura è cambiata? Sono diventati di colpo, come dice lei, “uno strumento d’autorità nelle mani del cupo potere costituito dei mediatori e degli editori”? E io, nonostante continuassi caparbiamente a essere uno “scrittore che scrive”, sarei diventato nello stesso tempo e di colpo solo uno “scrittore che ha scritto”?
A sentire queste argomentazioni, che anche altri fanno, sembra che ogni cosa viva, nel momento che viene toccata da “loro” diventi improvvisamente impura, che venga pietrificata come dallo sguardo di Medusa. Anzi, che sia già morta prima ancora di vivere la sua vita emersa, dato che il suo destino successivo non può che essere questo. Mentre la rete sarebbe invece e chissà per quale ragione una zona franca, la sola dove si può costruire ancora qualcosa d’altro, ecc… Si rende conto che così lei gliela dà vinta subito, non fa che consegnare nelle “loro” mani l’intero bottino? C’è qualcosa di bloccato in questo modo di vedere le cose. Tanto più considerando che tutto questo varrebbe anche per gli scrittori del passato, che non possono che rientrare per forza di cose nella categoria degli “scrittori che hanno scritto”. Invece per me Dante è ancora vivo, vivissimo, sta ancora scrivendo, sta scrivendo nell’istante stesso in cui poso gli occhi su una sua frase, la sua tensione si può ritorcere continuamente contro di “loro”, se siamo in grado di farla vivere dentro di noi, e così Kafka, Melville, Dostoevskij, Leopardi, molti altri, e anche più indietro nel tempo, Omero, lo sconosciuto autore del libro di Giobbe e di quello di Gilgamesh… Non bisogna, credendo di fare altro, finire per fare esattamente il loro stesso gioco. C’è, al contrario, tutto continuamente e drammaticamente -anche con il conflitto, se occorre- da vivificare, salvare.
Non se ne abbia a male e non mi giudichi un presuntuoso o un cafone se nel futuro non potrò rispondere che raramente e saltuariamente alle lettere che lei o altri mi scriveranno in rete, perché non sono collegato a Internet e devo ogni volta abusare della gentilezza di un amico, che tra l’altro domani partirà per le vacanze e starà via per un po’. Accetti – se vuole – i miei tempi, i miei limiti e le mie libertà (tra le quali c’è anche quella di non avere un indirizzo di posta elettronica e di non essere direttamente in rete).
Ma nella sua lettera ci sono altre cose che mi sembrano invece interessanti e che potrebbero avere sviluppi. Anche per questo abbiamo dato vita a “Nazione indiana”. Forse verrà il momento di riparlarne davvero e di creare nuovi vasi comunicanti, senza il diaframma o l’alibi della rete”.
*
Il 16 agosto Paradiso replica a Moresco:
“…lei dovrebbe prendere atto di una cosa: oggi la rete (e non “loro”, ossia il sistema editoriale, con il quale, tra l’altro, a me non interessa nemmeno interloquire più di tanto, e non gliela “do vinta” per il semplice motivo che io con “loro” non gareggio) consente ancora la “possibilità” – badi bene: solo la “possibilità” – di pensare più agilmente, insieme, una comunità svincolata dai pescecani del profitto. Tale “possibilità” consiste in sostanza nel permettere di allestire tanti luoghi di confronto e creatività che altrimenti sarebbero impensabili, per tutta una serie di ragioni, non ultima quella economica. Forse non a caso si dice che internet è il mezzo espressivo dei poveri. Lei disprezza e liquida la tecnologia con troppa superficialità, e perciò preferisce stare con un piede fuori e uno dentro (non si capisce perché). Dovrebbe invece imparare a scorgere nella rete – come in tutte le situazioni – un mondo variegato e infinito che potrebbe essere un’anticipazione del suo destino e del destino di tutti. Questo non vuol dire approvarla o subirla o usarla passivamente, la rete, e perciò io parlavo di “possibilità”, perché sta poi all'”azione” dei singoli e delle comunità che si immaginano il futuro, imparare a sfruttare uno strumento, qualsiasi strumento, nel modo giusto, cioè secondo giustizia. Magari prima che arrivino gli altri a imporci la loro usabilità, che certamente sarà consona al potere e ai suoi antichissimi, infelici, sempre ingiusti meccanismi di controllo”.
*
Segue il 18 agosto una nostra lettera a Moresco:
“… A noi interessa la parte etica della questione letteraria, la parte attiva, quella che spinge gli scrittori a confrontarsi e a parlare di cosa è possibile fare per difendersi dall’eventualità di essere ridotti a schiavi di un sistema fagocitante, e che inoltre esorta a resistere a tutti gli orizzonti di crisi e di morte che ci attraggono sempre, (…) ma ai quali bisogna almeno provare ad opporre una sostanza di vita o vita sostanziale, al di là di tutti i razionalissimi dubbi. È su questo che forse le chiedeva un parere, magari con modi un po’ bruschi, Gustavo P., caro Moresco, non sulle formule critiche o sulla sua poetica, che francamente possono interessare relativamente, almeno fino a questo momento.

L’immagine è le lettera “C” della serie Frammentato abbecedario di un viaggio, di Raffaella Garavini.
Non è ai suoi libri, insomma, che bisogna arrivare e fermarsi, ma ai libri del futuro, se mai ce ne saranno ancora di belli come certamente sono i suoi. Cosa fa, lei, Moresco, oltre che denunciare la situazione attuale, ovvero per controbatterla? Scrive libri? Ma ci sono milioni di persone che scrivono libri! “Sono uno scrittore” – lei replicherà – “cos’altro dovrei fare?”. Scrivere, certo; ma senza dimenticare che quello che scriviamo cade in un mondo nel quale viviamo insieme ad altri con certe regole, etc. Ecco perché la questione è tutta politica, almeno dal punto di vista che interessa qui a tutti, comunitariamente. Pertanto non si tratta di mettere avanti l’autorità dei libri scritti rispetto a un universo degenerato, non si tratta di sostituire a una autorità ingiusta un’altra autorità più giusta. Non è di questo che si tratta. In NI si sta discutendo della possibilità di sostituire all’autorità, che è sempre oppressiva, una comunità, ossia qualcosa di aperto e di mai definitivo che si svolge a partire dagli altri che sono diversi da noi, prima, o oltre, che da noi stessi. Lo “scrittore che scrive” citato da Gustavo P. è forse lo scrittore che non ha bisogno di pubblicare libri con questo sistema editoriale per affermare la propria identità; è lo scrittore che, se necessario, fa un uso talmente improprio della letteratura, da non pubblicare assolutamente da nessuna parte i suoi libri, o solo su fogli volanti o solo su riviste sconosciutissime o solo per pochi amici. Lo “scrittore che ha scritto”, invece, è esattamente lo scrittore impelagato nei suoi problemi di critica viscerale, ma di incapacità all’azione. La solita, vecchia storia: ‘il mondo fa schifo, io però resto nel mondo, perché… cos’altro si può fare?’
E invece bisogna uscire fuori da questo mondo, andare in alto, oltre, al di là. Come? Non lo sappiamo, non lo sa nessuno, bisogna scoprirlo. Ma qui sta il bello. Se voi ci state, bisogna partire insieme per fondare una comunità in una terra ancora da scoprire, bisogna abbandonare se stessi e portare il dono del proprio vuoto, della propria miseria, umilmente, a chi vorrà accoglierlo per farne tesoro e per ringraziarci a sua volta con il suo vuoto, la sua miseria. L’idea di comunità non indica una “proprietà”, una “appartenenza”, una “autorità” da conquistare. La comunità a cui pensiamo noi indica piuttosto una situazione di disperazione, di isolamento, e quindi la propria solitudine, il proprio isolamento che si fanno “munus”, dono, insieme a quello di altri (comunità = “cum” “munus”) nella nostra stessa condizione. La “comunità” non può avere a che fare con il “proprio”; ha a che fare, invece, con l’alterità, con il profondo abisso mortale dell’altro che ci insidia e ci guarda e ci chiede di accettarlo, e quindi di ascoltarne le ragioni – mentre noi vorremmo ucciderlo, perché Caino è nato prima di Abele ed è stanziale e assassino, “autoritario” per natura.
Nella sua lettera, Moresco, si sente a tratti un tono di pienezza poco gradevole. I suoi problemi e, come dice Gustavo P. con severità, le sue geremiadi riempiono tutto lo spazio della sua scrittura anche con discrezione e sobrietà, ma non diventano mai dono comunitario per gli altri, non indicano una via “alternativa”. Non a caso alla fine l’unica cosa che lei può rivendicare sono i libri che ha scritto. No, Moresco, non possiamo rivendicare i libri che abbiamo scritto, perché ce ne sono ancora moltissimi altri da scrivere, molto più importanti di quelli già scritti. È questi che dobbiamo sforzarci di immaginare, di aprire alla possibilità, di rendere vivi e presenti nel futuro a partire da qui. Sono i libri del futuro che dobbiamo salvare, non quelli “già scritti”. La sua frase: “Vogliamo esordire” ci pare che volesse significare proprio questo, o adesso non vale più?”
*
Il 18 agosto Raul Montanari polemizza con noi in questi termini:
“Se peraltro De Vivo e Virgilio (con un nome simile, poi…) evitano di sbagliare di brutto l’etimologia di “comunità”, siamo tutti più felici e l’effetto “Ora del dilettante” si attenua. Comunità naturalmente non viene da cum-munus (autentica insensatezza etimologica) ma da cum-munis. Munis, mune è un aggettivo che in origine significava “chi svolge una carica”. Quindi communis sta per “chi è partecipe di una carica”. A me sembra anche più impegnativo del romantico e floreale “partecipe del dono della solitudine”. Fra scrittori che scrivono e scrittori che hanno scritto, magari c’è bisogno anche di qualcuno che ha letto (un buon vocabolario). Per una referenza precisa, senz’altro consigliabile il Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine di Ernout e Meillet, quarta edizione, p. 421. Prima di pontificare sui massimi sistemi e deliberare sul nulla, può essere buona norma controllare il rubinetto del bidet”.
*
Il 19 agosto, scrivendo a Gherardo Bortolotti, così spieghiamo il nostro rapporto con la rete:
“…noi non pensiamo affatto che la rete sia il luogo della libertà assoluta, perché consideriamo la rete come la vita, cioè come un luogo dove bisogna lottare per assicurarsi qualche spazio di libertà che il potente di turno vorrebbe sempre comprimere o annullare. Le esperienze vitali, in rete, sono gocce in un mare di stupidità e di interessi contrapposti, ma sempre pronti a carpire la buona fede delle persone. La rete non è la nostra terra promessa, intendiamoci! Né il web è per noi l’unico luogo deputato alla letteratura e alla ricerca artistica. Tutt’altro: noi siamo giunti al web per necessità, non per elezione, ma, guarda un po’, proprio la necessità di utilizzare il web è da noi considerata ora la nostra virtù. La rivista-zibaldone, che abbiamo creato mettendo a frutto la geniale intuizione leopardiana, come tu hai ben capito, è la nostra virtù, nata dalla necessità di risolvere il problema estetico che il web ci ha posto e che nessun editore – attento innanzitutto alle ragioni del guadagno – avrebbe potuto e voluto risolvere. Questa è la “nuova idea di testo” che noi proponiamo, un’idea adatta alla comunità cui pensiamo, poiché lo zibaldone include, non esclude; esso è la metafora del mare magnum della letteratura e del sapere, che tutti gli uomini, più o meno consapevolmente, contribuiscono a scrivere ed elaborare. Siamo solo in due a curare le pagine di questa rivista, ma la redazione effettiva è dell’intera comunità intellettuale e culturale, laddove con questi aggettivi noi non intendiamo assolutamente qualificare una corporazione, una setta, e neppure un gruppo ristretto di persone, ma – ripetiamo – l’intera comunità scrivente, operante (nei campi dell’arte) e leggente, cui noi opponiamo un solo veto: l’esibizione del proprio “io”. Pertanto, chiunque ci mandi uno scritto o una foto o un disegno nel quale è assente questa esibizione narcisistica del proprio “io”, che è il peccato capitale dell’artista (soprattutto “moderno” e “postmoderno”, vedi anche le discussioni fatte in NI), quello a cui tutti gli altri sono riconducibili, noi lo prendiamo in seria considerazione.
E come non abbiamo preclusioni di sorta nei confronti di coloro che scrivono, così non abbiamo preclusioni nei confronti delle cose che si scrivono (con quell’unica eccezione di cui sopra). Siamo contro i generi, certo, ma non per edificare dei “controgeneri” o per sfruttare questo discorso a fini autopromozionali. Perché dovremmo respingere un testo che si presenta sotto forma di romanzo, se esso è il frutto di un’esperienza vitale e degna per questo di essere letta, cioè di diventare patrimonio comune?
A proposito dei “problemi estetici su cui lavorare in comunità”: noi pensiamo che essi debbano essere posti e risolti dalla comunità stessa in piena autonomia”.
*
Lo stesso giorno, così rispondiamo a Montanari:
‘… il primo significato che i dizionari attestano del sostantivo ‘communitas’ è quello che assume senso dall’opposizione a ‘proprio’… A questo primo significato canonico, tuttavia, se ne aggiunge un altro meno pacifico perché trasferisce al proprio interno la maggiore complessità semantica del termine da cui proviene: ‘munus’, che indica una caratterizzazione sociale… Benché generato da un beneficio precedentemente ricevuto, il ‘munus’ indica solo il dono che si dà, non quello che si riceve. Esso è proiettato tutto nell’atto transitivo del dare. Non implica in nessun modo la stabilità di un possesso… ma perdita, sottrazione, cessione… Il ‘munus’ è l’obbligo che si è contratto nei confronti dell’altro…’.
(Roberto Esposito, Communitas, Einaudi, 1998, pp. XII-XIV).
Veda, Montanari, nonostante le offese e l’accusa di dilettantismo, che per noi è piuttosto un elogio, poiché del professionismo alla sua maniera non sappiamo che farcene, anche la sua faciloneria pseudoprofessorale costituisce un ‘munus’, perché ci offre l’occasione per chiarire, a beneficio del “discorso comune”, qualche altra idea, e quindi di fare insieme ancora qualche passo.
Il ‘munus’, a differenza del ‘donum’, ha un carattere particolarissimo: non si può fare a meno di farlo, “si è chiamati a farlo”. Etimologicamente, secondo il filosofo Roberto Esposito, è questo il suo senso, che può avere a che fare con l’idea di ‘dovere’ espressa dalla ‘carica’ (ma non solo). La ‘carica’, quindi, cui lei, o meglio, il dizionario, allude, non si riferisce semplicemente, a una “autorità”, come lei, forse, è abituato a vedere, ma a un “dono”, a una “grazia”, che chi ricopre la ‘carica’ dovrebbe sempre sentirsi in “dovere” di fare agli altri.
Il carattere di “gratuità doverosa” del ‘munus’ a noi interessa fortemente ai fini del nostro discorso perché implica una certa idea di responsabilità e di sacrificio che obbliga quasi naturalmente ogni uomo a “fare” insieme agli altri. È per questo che parlavamo della necessità di perder tempo ad ascoltare gli altri, della fatica di mettersi in relazione per allestire una comunità, etc. “Abolire la relazione”, impedire di “alterarsi”, invece, è il presupposto di qualsiasi potere contrattuale, fondato non a caso sull'”immunitas” (veda i bloggers, “immuni” perfino da loro stessi, o il sistema culturale dei mediatori, che pompa tanti “scrittori” ognuno con la sua “poetica immunitaria”), opposta in tutti i sensi alla “communitas”, la quale, sia detto per inciso, ma non sarebbe neppure necessario, perché chi mastica un po’ di latino e legge con attenzione e fino in fondo i vocabolari, coglie a volo (“sente”) che l’origine di ‘munis’ è ‘munus’ – “communitas”, dunque, la quale ha a che fare con un “dono” (“munus”) che non si può non fare (la “doverosità”) alla pari con gli altri (“cum”), in un circolo partecipativo che è l’esatto contrario del potere costituito, anche perché alla sua base dovrebbero esserci, come suggerisce Esposito citando Bataille, lo spreco e il nostro nulla costitutivo, ovvero il punto sempre sfuggente dell’orizzonte (la “comunità” come nostra radice più propria) verso cui si tende nonostante tutto, ma che non si afferra mai, e la nostra fragile natura mortale.
Ma a lei, Montanari, è risaputo che queste cose non interessano, preso com’è dalle sue ansie difensive della posizione “professionale”, perfino in questo angolo sperduto di universo che è la finestra di un micronico forum.
Per concludere, notiamo soltanto che la citazione di Esposito proviene da un ambito di ricerca di filosofia politica e morale che persegue tutt’altri approdi, ma è molto interessante perché tira in ballo dinamiche e argomenti di cui stiamo discutendo in questi giorni: la sua nozione di “comunità” ci è sembrata subito aderente ad alcune nostre intenzioni, per questo l’abbiamo utilizzata, anche se in tutt’altra prospettiva, è chiaro (per chi ha letto i nostri interventi). D’altronde, che la questione sia anche “politica” lo hanno già detto in molti, ragion per cui questi riferimenti non ci sembrano affatto campati in aria.
Legga meglio i vocabolari, dunque, caro Montanari, e, soprattutto, legga il libro di Esposito e i nostri scritti, se vuol saperne di più. Di cosa? Del suo destino, naturalmente.
E se ha bisogno di un idraulico, ci faccia un cenno”.
*
A questo punto della discussione segue una serie di interventi dei commentatori e il dibattito sulla comunità si impantana in una questione etimologia. Da dove deriva communitas? In altra occasione ci promettiamo di tornare su questa questione, che pure può presentare un risvolto istruttivo, ma per ora tralasciamo tutti gli interventi che la riguardano, per isolare meglio i più significativi contributi alla discussione. Riportiamo un breve passaggio di un intervento di Raul Montanari (il 23 agosto):
“…Pensare a un attacco frontale al mondo editoriale e alla sua sempre maggiore sudditanza verso le vendite (i comici, ecc.) è difficile, e l’ironia surreale di Andrea sulle iniziative che si dovrebbero prendere è totalmente giustificata. In teoria, dovrebbero essere anche (soprattutto?) i critici e i lettori a premiare e punire, nel modo giusto; ma a un certo andazzo si fa presto l’abitudine. Vi ricordate lo scandalo che ci fu quando Einaudi pubblico le Formiche di Gino e Michele? Per diverso tempo, nelle pagine letterarie dei quotidiani, si parlò con indignazione di questi due bravi autori comici messi in catalogo insieme a Calvino e a tutti gli altri (in pratica, a tutti i maggiori nomi della letteratura mondiale). Adesso, qualcuno si stupisce? Non ho nessuna soluzione da proporre, nel rapporto con gli editori, sul problema della visibilità, dell’attenzione critica, delle scelte di fondo. Vi espongo la mia personale “etica del successo”, e accetto qualunque critica.
1. Come ogni scrittore, io desidero essere letto dal maggior numero possibile di persone. Non date retta a quelli che dicono che non voglio avere successo di pubblico: sono balle. Non esiste nessuno che non sogni di vendere non un milione, ma un miliardo di copie. Non solo per diventare famoso e avere la foto sui giornali, è ovvio, anche se la vanità è un dato costante di qualsiasi uomo, pure dei Santi e dei Giusti: molto di più, per provare, davvero, a cambiare il mondo con le proprie parole, e sentire di avere la forza di farlo.
2. Qual è allora la differenza fra me e uno scrittore “commerciale”? Semplice: che io non sposto di una virgola le mie tematiche (disturbanti) e la mia ricerca formale (elaborata) per andare incontro a questo potenziale miliardo di lettori, per rendere più commestibile il mio prodotto. Sogno di vendere un miliardo di copie, ma di libri MIEI, interamente miei, senza compromessi. Sogno di condividere la mia visione del mondo (disturbante) con un miliardo di persone, di cambiare la testa a quelli che secondo me (posso sbagliare!) stanno facendo scelta sbagliate, stanno pensando la realtà in modo sbagliato: ma il passo devono farlo loro. Se la storia che sto scrivendo non richiede un amore infelice, be’, non ce lo metto, anche se so che un amore infelice (specie se a lieto fine) è un buon “ingrediente” per un romanzo e mi farebbe vendere dieci o ventimila copie in più. Se invece la storia me lo chiede, ce lo metto. E’ tutto qui. Sono al servizio del mondo, e al servizio della storia che racconto.
È poco? Non lo so. È qualcosa, e guardandomi intorno, al di là degli amici di NI per i quali ho una stima enorme (con Tiziano e Aldo Nove abbiamo anche fatto un libro di poesie insieme, per esempio), vedo alcuni autori mossi dalla stessa onestà (forse, credetemi, più di quanti si pensi di solito); ne vedo altri che questa onestà non perseguono (i soliti nomi, più i casi penosissimi di quelli che ad avere successo con le “ricette” ci provano, e manco ci riescono!).(…)”.
*
Il 29 agosto interviene Moresco nello spazio dei “commenti” alla sua Lettera da Leuca 2:
“(…) Rispondo adesso a un paio di questioni sollevate da alcune lettere.
Il mio impegno “politico”, umano e sociale generale e la mia attività di scrittore.
Io non vedo così separate le due cose. La mia vita è stata attraversata violentemente da entrambe e non sono mai stato -né mi pare di esserlo adesso- un ignavo. Si dà addirittura il caso che buona parte della mia vita l’abbia passata in un coinvolgimento e in un deragliamento politico forse inimmaginabile a chi mi chiede conto adesso di questo, e abbastanza fuori misura anche per gli standard di allora. Non voglio scendere in particolari, perché vedo che ogni cosa viene presa nel suo verso peggiore. Vorrei solo dire che forse adesso non starò facendo di più, ma ho l’impressione di non fare neanche di meno di quando ero sprofondato nell’attività politica rivoluzionaria separata.
La comunità, gli scrittori, ecc…
Gli amici di “Zibaldoni” insistono sul fatto (lo fanno qui e l’hanno fatto anche in una lettera a Carla Benedetti) che, in un certo senso e in una certa misura, l’attività dello scrittore non sarebbe del tutto legittimata (e sarebbe anzi facile preda quando non resa inerte dai micidiali meccanismi mercantili e di potere dominanti) senza la presenza di una “comunità che persegua la verità in tutti i campi del sapere e della conoscenza”, che questo lavoro sarebbe più importante delle “opere” e che se non c’è questa comunità legittimante l’attività dello scrittore sarebbe in qualche modo contrassegnata da sterile narcisismo, isolazionismo ecc… A parte il leggero brivido che mi metterebbe anche una comunità di questo tipo (in molti casi nelle società che si sono autoproclamate tali gli scrittori e i poeti erano al bando come “antisociali” o si suicidavano), io credo che tutti noi che abbiamo dato vita a Nazione Indiana siamo sensibili al problema di creare un allargamento di spazio anche in questo senso, tanto più in un momento così irrespirabile e plumbeo della vita culturale e civile del nostro paese, altrimenti avremmo continuato tutti a fare solo quello che già stavamo facendo, che era di per sé abbastanza impegnativo. Invece siamo qui a discutere anche di questo, perché ne capiamo l’enorme portata. Ma questo modo di porre il problema non mi convince, né mi convince questa sottovalutazione delle “opere” rispetto al contesto, che può a volte essere modificato anche dalle prime oltre che viceversa. Non avrebbe convinto neanche Leopardi (al quale voi vi richiamate con la vostra denominazione) che ha usato anzi parole dure a questo proposito. Ma anche sul resto del problema, così come voi lo ponete, il mio dissenso è profondo.
Facciamo appunto l’esempio di Leopardi. Sapete bene che Leopardi ha lavorato per tutta la vita in una quasi totale solitudine culturale, politica e spirituale, che solo poche persone nell’Italia di allora interagivano con lui ed erano in grado di comprendere la portata di quanto andava facendo. Bene. Cosa doveva fare allora Leopardi? Smettere di scrivere per dedicare invece il suo poco tempo al tentativo di costruire prima questa “comunità”, che avrebbe sottratto il suo lavoro al rischio di narcisismo, isolazionismo ecc…? A me pare che sia stato meglio così, e che – nonostante sentisse la mancanza di tutto questo – il suo impegno, la sua radicalità, la sua intelligenza e la sua passione abbiano potuto incarnarsi in “opere” piuttosto che in discorsi generali sulle sole possibilità, che abbia creato cioè, nel cuore stesso di questo dramma, degli organismi espansivi, che li abbia posti in questa ferita non rimarginata e che in questa tensione sia riuscito a raggiungere molte altre persone attraverso il tempo e lo spazio. Molte di più di quelle che sarebbe riuscito a raggiungere cercando – probabilmente senza riuscirci – di creare queste condizioni nel suo duro presente.
Ma si potrebbero fare molti altri esempi di artisti e pensatori che hanno dovuto vivere in situazioni plumbee e senza sbocchi (dittature, tirannidi ideologiche o glaciazioni collettive di ogni genere e tipo). Eppure hanno compiuto ugualmente, umilmente, persino in assenza di una qualsiasi speranza, un gesto di incarnazione. Cosa dire allora di persone come Emily Dickinson, che ha scritto per tutta la sua vita in balia di questo sogno, senza alcuna consolazione “comunitaria”, o come Van Gogh e tanti altri? Che erano dei narcisisti isolati? Che la loro opera era senza reale legittimazione? E perché pensare che oggi sia necessariamente meglio di ieri, solo perché le forme di questa stessa oppressione si presentano in modo diverso? Il fatto è che, da come la ponete voi, sembra quasi che ci siano due tempi. Uno per creare le condizioni culturali, politiche, sociali ecc… perché il gesto artistico e di conoscenza possa essere umanamente, socialmente e spiritualmente utile e legittimato. E uno in cui lo scrittore, legittimato dalla presunta presenza di tali condizioni, lo può mettere in atto. Le cose non stanno così. Non ci sono due tempi. La vita nasce quando nasce, l’onda si muove quando si muove, la ginestra di Leopardi fiorisce anche se non trova un ambiente favorevole e legittimante, ma anzi solo una parete di lava pietrificata, non aspetta il permesso di nessuno, se ne frega di chi, autoinvestitosi di questo ruolo, crede di poterle dire quando può fiorire e quando no. Ho già conosciuto in passato logiche di questo tipo, magari anche generose e in buona fede ma che possono risultare alla fine altrettanto padronali e castranti di quelle a cui intendono opporsi. Confrontiamoci sì, ma da pari a pari, senza meccanismi mentali che possano mettere l’altro in inferiorità ideologica e in soggezione.
Può darsi che, da tutto quello che abbiamo messo in ballo, possa venire fuori qualcosa di buono. Io credo che sarà così. Però le posizioni devono essere libere, chiare, argomentate e – sia pur nello scontro – improntate a rispetto reciproco. Se no pazienza. Non tutto si può conciliare. E ciò che non si può conciliare è meglio che resti inconciliato.
Scusate la lunghezza di questa lettera, dopo la quale comunque non disturberò più per un pezzo, per le ragioni che già vi ho detto, ma anche perché, nonostante e contro questo stato di cose, mi ostino a essere uno scrittore che scrive e che continua a esordire”.
*
Il 31 agosto rispondiamo a Moresco:
“Gli scrittori, le opere e la comunità avvenire, dunque: questi sì che sono argomenti che ci interessano. Noi crediamo fermamente che misurarsi su di essi significa oggi davvero dare un senso alla nostra attività quotidiana, che altrimenti rischia il vaneggiamento, lo sproloquio, il narcisismo, l’immunità.
In realtà, caro amico, lo scrittore non sarebbe nulla senza una comunità, addirittura non avrebbe ragione d’esistere, perché, puoi tu dirci a chi lo scrittore dovrebbe destinare la sua scrittura, se non ci fosse una comunità pronta ad accoglierlo? Anche il più grande e ostinato e solitario dei poeti – rimasto solo, senza nessuno in grado di ascoltarlo, impossibilitato a “mettersi in relazione” anche con un solo altro uomo, probabilmente resisterebbe ben poco a scrivere, per cadere presto in un silenzio assoluto; il silenzio di chi è “immune”, solo con se stesso. Chi scrive, invece, deve sempre sperare in chi legge, altrimenti non può nemmeno cominciare a scrivere: la scrittura è una delle attività umane più ottimistiche e, per certi aspetti, folle, proprio a causa della sua intrinseca, obbligatoria speranza di un altro ben disposto verso di noi, pronto ad ascoltarci. Forse nessun altro mestiere, nessuna professione presuppone un “rischio d’impresa” così alto, come tu sai bene (pensiamo, per esempio, a certi racconti della tua esperienza di “ricerca di un editore”).
Posta così, allora, la questione rivela una cosa, innanzitutto: che mentre desideriamo edificare la comunità avvenire, in realtà la stiamo già costruendo, modificando con queste nostre parole quella nella quale ora ci troviamo, e lo stiamo facendo insieme, donandoci il frutto delle nostre idee e delle nostre riflessioni in materia. Pertanto, consentici di dire una cosa in via preliminare. È sbagliato affermare, come fai tu, che secondo noi “l’attività dello scrittore non sarebbe del tutto legittimata senza la presenza di una comunità”, perché noi, invece, diciamo una cosa molto più radicale: che l’attività di uno scrittore oggi è DEL TUTTO ILLEGITTIMA se la comunità nella quale ricade è una comunità disgregata, apatica, teledipendente o mediatordipendente, e in definitiva non è una vera comunità. In questo senso dicevamo, seguendo, se leggi bene, le argomentazioni di Benedetti, che la questione è anche politica. Non nel banale senso dell'”impegno” – del quale, se vuoi, possiamo anche parlare, ma non qui, dove non c’entra assolutamente niente. Mica noi siamo Prodi e D’Alema, e tu sei Berlusconi!
Noi, quindi, non stiamo qui parlando delle tue opere o di quelle di Montanari. E sappiamo bene che un uomo si giudica dalla sue opere e non da un intervento in un forum magari non meditato a dovere. Le opere hanno un’enorme importanza e quanto più grande è l’opera tanto più complessa e variegata e ricettiva è la comunità nella quale essa ricade. No, no, non abbiamo mai “sottovalutato le opere rispetto al contesto” né ci siamo dati una tabella di marcia, stabilendo due tempi, uno per le opere e uno per la comunità (ma dove le hai lette queste cose?). Perdonaci, ma dobbiamo pur dirtelo che sei lontano molte miglia dal comprendere quello che volevamo dire. Eppure, tutta la discussione sul ‘munus’ e sulla ‘communitas’ doveva almeno aver gettato una luce sulle idee in discussione. Inoltre, accusarci di logiche “padronali”, “prussiane” o “bolsceviche” (ancora una volta, scovate chissà dove) ci sembra così assurdo da farci sorridere, in un primo momento, ma poi da costringerci a un esame di coscienza: “Siamo stati forse noi così arroganti e superbi da aver dato l’impressione di voler, come dire, monopolizzare il dibattito, sopraffacendo gli altri?”. Se è accaduto questo, ce ne scusiamo con tutti i nostri interlocutori; forse però un motivo c’è, ed è da ricercare nel nostro timore che alcune ragioni di natura elementare fossero misconosciute, mistificate e passate sotto silenzio, il che ci ha indotto a pensare – sempre sulle ali di un entusiasmo disinteressato, mai con calcolo o frode – che una maggior forza nel sostenerle avrebbe dato ad esse più chances di essere sottoposte a verifica dagli altri. Il che finora non è accaduto, caro Moresco, purtroppo, e anzi il tuo intervento, per certi aspetti, ci dà conferma che i nostri timori non erano infondati.
Ma in fondo, che cosa abbiamo detto noialtri? Abbiamo proposto una discussione sulla comunità avvenire, abbiamo detto che di essa comunità tutti quanti abbiamo bisogno, non a prescindere dalle opere, ma oltre le opere, che sono nate nascono e nasceranno comunque, anche alle falde dell’arido Vesuvio e della opaca Milano. Le opere ci importano, eccome, esse fanno parte del passato e costituiscono la nostra identità presente. Ma noi oggi vogliamo intuire l’opera del futuro e per far questo abbiamo bisogno di intuire anche il contesto nel quale quell’opera ricadrà, appunto la comunità avvenire. L’opera futura e il contesto futuro sono oggi privi di ogni contorno, nessuno sa che cosa avverrà, se i meccanismi attuali di controllo e selezione dell’immaginario letterario saranno più efficaci di oggi oppure più blandi, se vivremo in una comunità più disgregata e più vulnerabile di quella attuale oppure se la situazione odierna avrà un altro esito. Tutto questo con la politica, con l’impegno politico in senso stretto non ha nulla a che vedere, né qualcuno di noi ti ha mai chiesto un simile impegno. Ti abbiamo chiesto, invece, un impegno comunitario, che si espleta nel dibattito su che cosa fare per “creare un allargamento di spazio”, per dirla con le tue parole, in una società che riduce sempre più i luoghi della comune discussione. Il tuo ultimo intervento, ad esempio, è già un contributo valido a questo fine, sebbene sia inficiato da una fondamentale incomprensione delle nostre idee. Incomprensione, poi, rispecchiata per intero anche quando dici che certamente con le nostre parole non avremmo convinto Leopardi. Ma dimentichi che la solitudine di Leopardi è il frutto di una costrizione, non di una libera scelta. E che fu la società della Restaurazione, il “secol superbo e sciocco”, cioè la comunità mancante o disgregante, che lo costrinse in quello stato di solitudine; e se Leopardi ci diede le grandi opere che ci ha dato, ciò accadde perché, a dispetto della sua solitudine, coltivò sempre l’amicizia e il gusto per le relazioni umane: basti leggere l’Epistolario, che è uno dei più ricchi e belli della nostra letteratura per numero e qualità degli interlocutori, ma anche per l’aura comunitaria che lo pervade, per il continuo cercare solidarietà intellettuale, amicizia e profondità di pensiero nei luoghi più impensati, più impervi. Leopardi fu animato per tutta la vita da una grande utopia comunitaria, quella espressa proprio nella “Ginestra” che tu citi, nella quale puoi trovare non la solitudine, ma il DONO che Leopardi, “nobil natura”, fa DELLA PROPRIA SOLITUDINE agli altri, a noi, quando immagina l’unico riparo agli uomini contro la potente natura:
“Costei chiama inimica; e incontro a questa
congiunta esser pensando,
siccome è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia,
tutti fra se confederati estima
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor…”
(vv. 126-132)
Tutti dovremmo ospitare questa “utopia”, per dar luogo poi all'”onesto e retto conversar cittadino” che Leopardi auspicava, e che noi oggi stiamo riproponendo in questi pubblici conversari. Guarda meglio, Moresco, e ti accorgi che questa già non è più utopia, ma realtà che si concretizza nelle nostre mutue parole, che noi ci doniamo al di là di ogni logica mercantile, di ogni convenienza spicciola. Questa è la comunità che noi ogni giorno vogliamo costruire e irrobustire, allargandola sempre di più, fino a tessere una rete di relazioni infinita – rete di scambi anche di opere, perché no? – in cui non il cicaleccio abbia la meglio, o l’esibizione ironica, ma l’espressione vitale di questo essere minuscolo che si aggira per l’universo, che chiamiamo uomo.
Né devi pensare che intendiamo porci a capo di queste relazioni, egemonizzandole (non siamo D’Alema…), o che intendiamo forzarle con conciliazioni artefatte. Sbaglieresti di grosso. Oltre a non essere dei politicanti, non siamo nemmeno dei santoni né dei preti, siamo solo due amici abituati a prendere sul serio gli altri e animati dalla ferma intenzione di mettere in pratica alcune idee, e nel farlo riconosciamo un unico mediatore: la comunità avvenire. Che, se sarà buona o meno buona, dipende anche da noi. Pertanto, qui stiamo innanzitutto (ancora) considerando soltanto la possibilità di fondare le basi di una comunità che discuta civilmente e senza interessi meschini o calcoli opportunistici relativi al ‘proprio’. Tali basi consistono nel rispetto (da parte di tutti, e verso tutti) e nella comprensione delle ragioni di chi è diverso da noi: senza queste cose, senza, quindi, come diceva Benedetti, prendersi sul serio, non è possibile andare insieme da nessuna parte. Per questo si tratta, per certi versi, di un discorso ancora tutto da cominciare.
Noi abbiamo anche qualche idea “concreta” e operativa, lo avevamo accennato a Carla Benedetti in una lettera privata. Pensiamo a un convegno, magari da qui a un anno, di persone che, come voi e come noi, stanno facendo lo sforzo di immaginarsi nuovi modi di stare insieme, di ricerca e di elaborazione artistica (non solo in rete), innalzando le prime fondamenta di una comunità virtuosa. Certamente non ci sono solo “Nazione Indiana” e “Zibaldoni e altre meraviglie”, devono per forza esistere da altre parti altre analoghe esperienze. Noi pensiamo che si potrebbe provare a metterle insieme, almeno a discutere e a confrontarsi, ad ascoltarsi, creando quelle famose “sinergie” di cui parlava Dario Voltolini, che ci convincono molto. Potrebbe essere un convegno che potrebbe intitolarsi benissimo: “La comunità che manca”, e prendere l’avvio dai temi di queste discussioni estive. Dovrebbe parteciparvi gente quanto più diversa è possibile: artisti di ogni tipo, ma anche “mediatori culturali”, editors, filosofi e, perché no?, politici, se ce ne sono (ma dove sono!?) in grado di capire queste cose. A patto che sia gente interessata al tema della “comunità mancante” e alle “basi” di cui parlavamo sopra: rispetto reciproco, come dici tu, e, soprattutto, sforzo di attenzione e comprensione per le ragioni degli altri che ti stanno a fianco o di fronte – comunque sulla stessa barca, non dimenticarlo. Noi dubitiamo che si possa mai arrivare a costruire alcunché di felice e di serio, senza tali fondamentali presupposti.
Un’ultima cosa, caro Moresco, ti chiederemmo, scusandoci in anticipo dell’impudenza (ma la nostra “franca lingua” ce lo impone): per cortesia, evita di aprire e chiudere le tue lettere con espressioni del tipo “non disturberò più per un pezzo” e simili. Dai l’impressione di essere intervenuto non per il piacere di farlo, ma perché costretto, perché dovevi difenderti o difendere e attaccare qualcuno. Non è questo che lo spirito comunitario richiede. Intervieni pure quando ti pare, con leggerezza o pesantezza, magari dicendoci: “questi non sono cazzi vostri”; ma non farlo con l’aria di chi compie un dovere al quale si sarebbe volentieri sottratto. Il nostro più forte desiderio è che tu sia ‘communis’, non ‘immunis'”.
*
Il 4 settembre chiediamo a Montanari di pronunciarsi esplicitamente sui temi in questione:
“Ci diresti adesso “che cosa è” per te la comunità?
Ti sembrerà ozioso e pedante il fatto che noi insistiamo su una questione del genere. In realtà essa è per noi di capitale importanza, per due motivi: 1) Perché la nostra rivista si propone innanzitutto di fondare una comunità aperta di artisti, scrittori e lettori; 2) Perché la fondazione di una tale comunità è la condizione essenziale per la discussione ulteriore su qualsiasi altro tema che ci sta a cuore: la guerra, la scuola, il mondo dei bambini, quello della cultura, e quant’altro. Se non c’è comunità dialogante, sostanziale, non solo ufficiale, che si scambia idee e riflessioni come fossero doni, per noi non c’è nulla. E tu che cosa ne pensi?”
*
Il 5 settembre ci risponde Montanari:
“Temo che la ‘communitas’ come la intendete e proponete voi sia principalmente un ideale normativo.
Kant dice: un ideale può essere raggiungibile e concreto; oppure può essere irraggiungibile in partenza, come per esempio la perfetta imitatio Christi che si propone il vero credente. Un ideale di questo secondo tipo dev’essere abbandonato a favore degli ideali concreti? No, perché indica una direzione lungo la quale camminare. Questo è un ideale “normativo”: suggerisce una norma, cioè un senso e una direzione, anche se il suo nucleo rimane inattingibile. Io posso camminare verso il sole anche se so che certamente non raggiungerò il sole, ma andando in questa direzione probabilmente passerò, o potrò fermarmi, in luoghi dove la natura è meno ostile di quella che nasce nell’ombra e nel freddo.
Quindi, tutto il rispetto possibile per la direzione che indicate. Quello che è successo qui, in questi commenti, e anche in altre situazioni di dialettica del web che ho incontrato in passato, conferma un certo pessimismo di partenza sulla natura umana e soprattutto sulla psicologia dei gruppi e sulle dinamiche che si creano quando c’è l’immunitas.
L’uomo è una strana bestia. Non c’è quasi nessun uomo che, visto da vicino o conosciuto intimamente, non sia affascinante. Una mia vecchia amica, Daria Bignardi (adesso giù con l’ironia sull’ex conduttrice del Grande Fratello, mi raccomando… non dico voi due, ovviamente), mi disse una frase memorabile, qualche anno fa. Aveva appena cominciato a camminare nel mondo pseudoVip, e si stupiva di incontrare da vicino persone che viste in tv o lette sui giornali le avevano fatto orrore, mentre ascoltate o “annusate” da vicino rivelavano una complessità, una tenerezza, un’umanità inattese. Daria mi disse: “Forse bisognerebbe restare chiusi in casa e odiare”. Conservare, cioè, la purezza del sentimento che un uomo ti ispira con le sue idee e il suo comportamento finché ti è lontano, perché la sim-patia che ti può suscitare da vicino corrompe la purezza di questo sentimento, ti confonde le idee. Questo non vale per le situazioni di gruppo, in cui si innescano fenomeni noti alla psicologia sociale, che si sintetizzano nel concetto di “responsabilità diffusa” (qualunque atto io compia è meno grave, perché non sono l’unico a compierlo). Studenti universitari americani hanno inflitto scariche elettriche a soggetti umani, perché gli era stato chiesto di farlo e soprattutto perché avevano visto altri farlo. Per fortuna le scariche elettriche erano fasulle, e i soggetti urlanti erano attori. Altri esperimenti hanno visto persone normalissime trasformarsi in carcerieri, aguzzini, torturatori. Ogni giorno sulle strade c’è un uomo con le gambe rotte che chiede aiuto, ma le automobili continuano a correre via, nella stessa direzione presa da quella che lo ha investito.
C’è un fondo orribile che aspetta solo di salire in superficie, e lo fa più facilmente quando a picchiare si è in tanti. Un intero popolo, quello tedesco, si è trasformato in una massa organizzata di assassini e conniventi di assassini, e questo è successo solo mezzo secolo fa, e non si trattava di conflitti tribali ma di un popolo che aveva dato forse i massimi contributi al costituirsi di una civiltà europea moderna. I meccanismi erano gli stessi: conformismo di massa, perdita del senso di identificazione (io non ti infliggo dolore perché non vorrei fosse inflitto a me), espulsione all’esterno della comunità di elementi di tensione interna e loro identificazione come nemico.
Poi, sorprendentemente, c’è la bellezza. Ci sono gli atti di pietà, quelli di moralità, di generosità gratuita, e ce ne sono tanti. Ci sono anche i libri, le parole, le immagini.
I fiori nel deserto, o le ginestre, se preferite. Ma nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono atti individuali. Mescolandosi con i gesti dettati dal conformismo di massa, e soprattutto mescolandosi con quel tran tran quotidiano, meccanico, che costituisce il 99% delle nostre vite e si sottrae alla nostra attenzione, questi gesti grandi e piccoli di bellezza e di miseria fanno la vita di una comunità così come essa è ora. La costruzione della comunità a venire è un compito nobile, un ideale normativo necessario, e ciascuno è giusto che dia del suo. Mi pare sia più o meno quello che stanno facendo quelli che sono qui dentro per il gusto di dire ciò in cui credono, e fare quella che io preferisco chiamare dialettica – ma davvero qui è solo questione di termini”.
*
Il 6 settembre è la volta di Andrea Inglese:
“Non mi sono letto tutti i commenti scatenati dal pezzo di Montanari e da quello di Moresco. Sono troppi, spesso prolissi e ridondanti, e a volte inutili. Ma mi hanno anche affascinato molte cose. E altre le ho imparate. Se Moresco ha parlato tre volte con Montanari, io gli ho parlato una volta sola. Eppure sono ammirato per l’energia che ha profuso nel rispondere fino alla fine a tutti questi interventi. Inoltre, da alcune sue risposte emerge, quasi incidentalmente, il mestiere dello scrittore. E dico mestiere nell’accezione più seria del termine. (Basta che non mi facciate cavar fuori delle etimologie! Comunque, la discussione sull’etimologia di “comunità” è un perfetto esempio di come ci si possa istruire – parlo a nome della mia cavernosa ignoranza – divertendosi. Se vi obbligassero a ripeterla altrettanto brillantemente, non ci riuscireste.)
Ma vengo subito al dunque. Moresco ha centrato il punto fondamentale. E lo dico, perché si tratta di una delle poche cose che mi sembra di aver capito a proposito dell’attività letteraria. Non c’è necessariamente sincronia tra la nascita di un’opera e l’esistenza di una comunità dialogante. Ma non si tratta di un’ipotesi. Questo è un fatto. La possibile sincronia è probabilmente auspicabile, ma molto spesso non si è affatto realizzata. E anche se si fosse realizzata, questo conta solo relativamente per il destino dell’opera e delle comunità che ne saranno eredi, in tempi successivi. Il testo letterario, per sua stessa natura, non può che liberare progressivamente, e secondo gli imprevedibili itinerari degli incontri, le sue potenzialità semantiche. E anche questo è un fatto assodato.

L’immagine è le lettera “D” della serie Frammentato abbecedario di un viaggio, di Raffaella Garavini.
Come è del tutto ovvio che un autore e la sua opera si nutrano di comunità esistenti, ma anche solo sognate. E molto spesso le opere (grandi o piccole), nascono nel vuoto di comunità, in società che si stanno disgregando o che già sono disgregate. La letteratura è una roba strana. Possiamo immaginarla come un gran servizio che alcuni fanno al progresso dell’uomo, ma a volte è solo un purissimo veleno, e semmai funziona come antidoto contro le forze distruttive dell’uomo. Veleno che cura veleno. Non è una visione romantica, mi sembra semmai realistica. Prendiamo tre poeti sullo scaffale, a caso. Celan, Eluard, Hughes. Se uno li legge senza schermi, sono ordigni. Spesso, possiamo starne certi, le parole dello scrittore sono dirette contro qualcuno, contro una certa società. Insomma, non voglio farla lunga. Ma io non capisco questa pretesa di porre la scrittura sotto la condizione di una comunità realizzata (gli amici di Zibaldone). Mi verrebbe da dire: gli individui cerchino di fare comunità, come possono. E nessuno aspetti l’opera. Questa si farà o non si farà. (“L’uomo senza qualità” di Musil non ha impedito l’ascesa di Hitler e il nazismo.) E aggiungo, pensando alla poesia, ciò che diceva Fortini: “la poesia ha sempre un carattere conservatore”.
La comunità non è un postulato. Quindi in un blog come NI il lettore può incontrarsi o meno con quanto trova scritto. Può reagire o meno. Ed eventualmente creare altre reazioni. Quindi un dialogo. E magari un incontro. (E qui dirò una potentissima banalità: io non posso vivere una comunità senza carne. Il dialogo telematico alla lunga mi lascia con la mia enorme fame di carne: di nasi, indumenti, timbri vocali, fiati, espressioni facciali, bicchieri, piatti, ecc. E non è poco.
Ho già detto come la penso sugli scrittori in rete. Non hanno per me privilegi catechizzanti, di avanguardie o altro. Si mettono in gioco con la loro specifica pratica della scrittura, la loro intelligenza non pedante, e con tutte le loro idiosincrasie e fragilità. Però se non hanno patenti per catechizzare, nemmeno hanno l’obbligo di prestarsi al dialogo infinito, presentandosi sempre freschi a coloro che li interpellano. Gli incontri possono nascere o non nascere (se vogliamo fare la comunità). Altrimenti siamo società, istituzioni o servizi sociali (che è un’altra cosa): dietro lo sportello dalle 8 alle 18. Per questo gli Zibaldoni percepiscono con precisione la fatica e la riluttanza di Moresco. L’opera ha spesso una sua teleologia più evidente (e tirannica) di qualsiasi discussione tra conoscenti od amici. C’è una questione di economia delle energie. Non si può discutere sempre, comunque e di tutto. Anche per le discussioni ci sono occasioni. E non tutte si equivalgono, come le cacofonie della rete mi sembra dimostrino”.
*
Il 7 settembre Helena Janeczek pubblica in Nazione Indiana il testo Piccoli indiani in cerca d’autore:
“Mentre leggevo il romanzo dell’estate di Nazione Indiana che si è sviluppato prima in coda al pezzo di Raul Montanari per poi passare alle lettere di Moresco, ho avuto la sensazione che non solo i testi si sono persi di vista quasi subito, ma che nelle varie derive tematiche l’unico tratto continuativo fosse la trasformazione dei due autori in personaggi. Niente di strano, così come non è poi strano che il botta e risposta del blog porti a parlare di altro e ancora d’altro. (…) E’ la società dello spettacolo, bellezza, e tu non ci puoi far niente. (…). Oggi regna un tipo di immagine non più rivoluzionaria, un’immagine che, semplificandolo, fissa il presente e gli preclude ogni futuro. Crea personaggi grossolani, ma assolutamente efficaci. Berlusconi, per fare l’esempio più noto… (…) A questo punto mi chiedo pure fino a che punto sia il mezzo a strutturare il messaggio. Non credo che sarebbe stato altrettanto facile dare del servo in faccia a Montanari o riempire Moresco di buoni consigli con lui di fronte. Non solo perché ci sarebbe voluto più coraggio, ma perché cambia tutto quando al personaggio immaginario si sostituisce la persona in carne e ossa.
La solitudine e il senso di libertà della comunicazione in rete rendono molto più facile perdere il contatto col fatto che ci si sta rivolgendo a qualcuno di realmente esistente e di realmente sconosciuto, non a un parto della propria immaginazione. Ma se gli altri con cui scambio i miei post rischiano di ridursi a miei personaggi, la comunicazione non si riduce forse a una specie di monologo drammatizzato a più voci? E per tornare brevemente sulla questione dei nicknames, a che cosa mi serve il mio nuovo nome, se con questo nome non mi invento una nuova identità – perché il concetto stesso di identità è un’invenzione recente e a mio avviso insostenibile- bensì solo un io-narrante, un personaggio nuovo? Il che è un’operazione letteraria perfettamente legittima, ma non concede una libertà maggiore di quanto non imponga le sue regole. Colui che scrive deve infatti conformarsi al proprio personaggio e forse questo, alla lunga, crea un condizionamento in più alla persona reale, al posto di renderla più libera. Ma questo, a dire il vero, non è un problema che si crea solo scrivendo sotto uno pseudonimo.
Di uno scrittore dovrebbe contare ciò che scrive, ma vedo che anche altrove non è così. Apro il nuovo dizionario della letteratura mondiale Larousse-Rizzoli e mi accorgo che degli scrittori italiani che hanno cominciato a pubblicare intorno alla seconda metà degli anni ottanta non è incluso praticamente nessuno, salvo quelli di grande successo. Quelli ci sono tutti, proprio tutti tutti, bravi e pessimi, aggiornati fino a Faletti e Agnello Hornby.
Sembra che il successo sia rimasto l’unico criterio di discernimento con cui scremare la letteratura contemporanea, ma a ben guardare non si tratta nemmeno di questo. Alcuni di quelli scrittori hanno in realtà venduto assai meno di altri esclusi, ma evidentemente i compilatori non si sono potuti basare sui dati di vendita di tutte le case editrici italiane. Si sono semplicemente basati sulla loro immagine di successo.
Una recente bibbia approvata dalla CEI traduce così la parte che ci interessa del primo comandamento: “Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sottoterra” (…)”.
*
Interviene Montanari l’8 settembre:
“(…) Può darsi che il mondo editoriale e massmediale in genere sia potente e raffinato (magari! Chi ci lavora dentro sa benissimo che la definizione più esatta è quella che diede anni fa un mio amico: “Le case editrici sono tutte delle baracche”).
Ma in questo mondo, tranne in piccole realtà pressoché militarizzate, non esiste niente di monolitico. In Mondadori lavorano fior di comunisti, anarchici, liberali di sinistra, gente che ha una sua idea forte del mondo e che cerca di applicarla ogni giorno… e ci riesce! La Mondadori non pubblica solo libri di regime, e neanche falsi libri di controregime come certi parti strazianti di ex compagni in vena di fare del patetico. E’ tutto molto più complicato, molto più complesso. Ci sono spinte e controspinte, tendenze e reazioni; c’è la famosa dialettica, e c’è una notevole autonomia politica degli editor. Gli editor, in qualunque casa editrice, sono molto più coinvolti nella battaglia contro gli amministrativi, i signori dei numeri e dei dati, che contro le veline politiche, spesso inesistenti. Potrei farle esempi al limite del comico. Ci sono enclave non solo di sinistra, o comunque di pensiero “contro”, ma anche semplicemente di pensiero “forte” (in termini estetici) nei luoghi più impensati, per esempio al “Giornale”. E’ difficile immaginare un quotidiano politicamente più sputtanato del “Giornale”, o perlomeno diciamo che con “Libero” è una bella lotta. La differenza è che al “Giornale” ci sono pagine culturali interessanti, redatte da gente che sa di cosa parla. Faccio un esempio personale. Il “Giornale” ha potuto pubblicare, due anni fa, una recensione ultrapositiva del più politico dei miei romanzi, “Che cosa hai fatto”, un libro in cui la presenza di quello che lei chiama il signor B. è talmente opprimente, pervasiva, portata all’estremo in una Milano invasa da carri armati e torturatori, che contemporaneamente all’uscita di quella recensione ne appariva una sul Manifesto, a firma di Aldo Busi, che definiva il protagonista del libro “il perfetto nuovo fascista berlusconiano”. Scusate davvero l’esempio personale: le cose che ci riguardano le conosciamo meglio. Vogliamo parlare dei TG? E’ ovvio che ci sono due TG targati Mediaset che rientrano tranquillamente nella definizione di realtà militarizzate. E’ altrettanto ovvio che il TG5 è, nell’ambito di quello che può dare un notiziario borghese che deve comunque fare i conti con le pastoie e le banalizzazioni del linguaggio televisivo, un TG che spesso ha assunto posizioni critiche. Il TG5 apre con dati disastrosi sull’economia mentre il TG4, Studio aperto e i due TG RAI in mano alla maggioranza si accalorano a spiegarci che in fondo tutto va bene. Io non ho nessuna particolare simpatia per i conduttori del TG5 (ho anzi un’antipatia coltivata da anni verso vippetti alla Sposini e Bonamici) né per il tono veloce e leggero con cui porgono le notizie, per non parlare degli ultimi escamotage neoedonistici tipo la rubrica “Gusto”, annunciata alle 13 e 25 di ogni giorno con evidente sollievo dal mezzobusto di turno dopo aver snocciolato notizie sconfortanti; però la scelta delle cose da dire, dei contenuti, e dell’ordine in cui esporli è un atto politico, e devo constatare che questa gente, che “prende lo stipendio dal signor B.”, dimostra una decenza rispettabile nello svolgere il proprio lavoro. Da un punto di vista di critica estrema, è evidente che anche loro vanno dritti nel calderone; se staccandosi dall’assoluto platonico si ha voglia di fare qualche distinzione rimestando aristotelicamente nella fogna, le differenze si notano.
Quindi, senza polemizzare ma con la sola intenzione di puntualizzare, ad Ant Mart e a molti che vedono il mondo dei media e dell’editoria dall’esterno e lo percepiscono meglio organizzato (in senso nazista o anche semplicemente pratico) di come è, vorrei dire che le cose non stanno così. Là dentro, come altrove, ci stanno teste, voci, opinioni, casino, e nella maggior parte dei casi quel poco o quel tanto di libertà che si percepisce nelle scelte degli editor(i) non deriva affatto da una calcolata concessione dall’alto, ma semplicemente dalla battaglia di idee che si svolge quotidianamente, orizzontalmente, fra compromessi e impennate di onestà, come in ogni azienda.(…)”.
*
A Montanari risponde Gabrielli il 9 settembre:
“(….) Chiunque abbia mai messo piede in una casa editrice sa quanto ciò che lei scrive sia esatto. Le case editrici sono così assolutamente artigianali e abitate da figure anomale (dal folle all’incompetente, dal visionario al maniaco, dal ragioniere al manager rampante) che qualunque visione monolitica e dietrologa è a dir poco fuorviante. Le cose sono molto più semplici e assurde di quel che si può credere dall’esterno. È quindi vero che dall’interno si può condurre una battaglia seria affinché qualcosa di nuovo e semplicemente di serio possa accadere nel “mercato editoriale”. Nella letteratura, invece, come si sa, le cose accadono indipendentemente da noi, editor o consulenti: Kafka docet. Ma è proprio qui che trovo che quel che lei dice mal risponda alle critiche mosse alla Janeczek. Cerco di spiegarmi. Helena Janeczek tiene a distinguere tra autore e personaggio, accusando i lettori di NI di cadere in una profonda confusione tra le due figure. E sia: l’autore è una persona, il personaggio la sua caricatura fantasmatica. Ma la questione è: chi è davvero l’autore? L’autore – e in particolare l’autore che scrive su NI – non è esattamente la somma del suo apparire pubblico? Un autore non è il responsabile di ogni sua singola parola, di ogni suo scritto (anche il più piccolo – anzi, a maggior ragione proprio del più piccolo e marginale)? Un autore non si distingue da un qualunque scribacchino proprio perché ogni sua parola pubblica è soggetta alla sua auctoritas? E non dovrebbe quindi rispondere di tutto quel che scrive e dice? Paradossalmente un autore non vota la sua vita alla trasparenza, alla necessità di dover rispondere di tutta la propria esistenza davanti alla giuria dei propri lettori? E, insisto, a maggior ragione un autore che decide di non dedicarsi esclusivamente alla sua opera ma di divenir un personaggio pubblico (come accade qui in NI) non può poi dire che la vita privata non c’entra, aggiungendo che i lettori dovrebbe riferirsi solamente all’opera. Mi sembra una questione prettamente logica: se voglio essere giudicato solo per i miei libri, devo limitarmi a quelli; se voglio parlare della società italiana, del ruolo che gli intellettuali giocano in essa, dei sistemi di potere, allora devo accettare e saper rispondere a tutte le critiche che concernono la mia persona, di autore, riguardo a questi temi, non ai miei soli libri. E, allora, in questo caso, si ha perfettamente ragione a chiedere conto da chi viene pagato chi parla contro il padrone. Si ha ragione perché la questione non è più personale, ma pubblica; non riguarda la persona, ma l’autore, colui le cui parole hanno un peso differente. E, in questo, concorderà con me che la situazione tra una persona che non ha alternative e lavora per la Bracco e uno scrittore che lavora per il “nemico” è sicuramente diversa: di nuovo si pone la differenza tra la responsabilità infinita di un autore e quella limitata di una persona privata, oltre probabilmente alla differente possibilità economica. Dunque, la difesa del “chi è senza peccato, scagli la prima pietra”, è un po’ debole e facile per un intellettuale. Qui, davvero, come ricordava lei a diversi lettori questa estate, si può e si deve fare di più. Non so, forse sbaglio, ma io credo che negli attacchi che vi sono rivolti, sia in gioco qualcosa che concerne la vostra funzione di autori (singoli e in comunità); e credo che le persone che vi criticano lo fanno, non per cattiveria o invidia, ma pensando che la vostra funzione sia importante e che a volte voi la prendiate con troppa leggerezza (è credo questo che ha scatenato la reazione al suo pezzo su Glamour, per il luogo in cui è stato pubblicato e perché veniva appena dopo un articolo della “comunità di NI” in cui si criticava esattamente il tono e lo stile del suo articolo, ironico e “leggero”.) Con simpatia (secondo l’etimo della parola). G.”.
*
A Gabrielli risponde Montanari il 13 settembre:
“(…) Il suo ragionamento è appassionato, ma la conclusione non mi convince affatto. Non riesco a capire perché uno scrittore “vota la sua vita alla trasparenza, alla necessità di dover rispondere di tutta la propria esistenza davanti alla giuria dei propri lettori”.
Se fosse così, staremmo freschi! Non mi metto nemmeno a fare l’elenco delle miserie, delle meschinità, delle opinioni politiche inaccettabili, dei comportamenti criminosi che troviamo nelle biografie della maggior parte degli scrittori che ammiriamo e che hanno arricchito la nostra testa e la nostra esistenza con le loro pagine. Lo scrittore anzitutto scrive, altrimenti dobbiamo chiamarlo con un altro nome. Questa “trasparenza” non la chiedono più nemmeno ai santi, figuriamoci agli scrittori. Giustamente è stato detto che nessun grand’uomo è tale per il suo cameriere: guarda da vicino il grande artista e ci troverai le stesse piccolezze che sono comuni alla natura umana, le stesse scoregge dell’anima e del culo. Se si parte con questo principio, confondendo autore e opera, a cosa serve leggere i libri? Leggiamo le biografie degli autori, ci basteranno. Se ci danno il buon esempio, bene. Se ce lo danno cattivo, cancelliamoli. Si rende conto di quanto è stravagante questa logica? Fra un grande scrittore che come uomo è detestabile e uno scrittore mediocre, che è una brava persona e si comporta bene verso la sua famiglia, quale ci interessa come scrittore? Magari come condomino vorremmo il secondo; ma cosa ce ne frega di leggere quello che ha da dire, se da dire ha poco e lo dice pure male?
Lo scrittore risponde di ciò che scrive, e basta; se, non essendo ricco di famiglia, è costretto a lavorare, lavora. E può darsi benissimo che si trovi a lavorare in un mondo, quello editoriale, in cui trovare presidenti sgraditi è altrettanto facile quanto nel mondo aziendale in tutto il suo complesso.(…)”.
*
Rivolgendosi a Dario Voltolini, che lamentava certe “contraddizioni” in alcuni commenti, il 14 settembre Ant. Mart. afferma:
“Caro Voltolini, emotivamente siamo molto più vicini di quanto tu pensi. Io qui sto impersonando, come direbbe la Janeczeck, la contraddizione di chi vive in tempo reale la scrittura scrivendo in un blog, di chi mentre dice A, allo stesso tempo può facilmente dire B, con disinvoltura e, soprattutto, senza che nessuno se ne accorga o faccia riflessione o eserciti una sana memoria. Scrivere in queste condizioni – in blog “liberi”, forum o che altro – è esattamente tutto questo messo insieme, magari condito con anonimato e un pizzico di mistero. Scrivere in queste condizioni – ti domando allora – è ancora scrivere? E parlare in questo modo “improvviso”, irriflessivo, immunizzato, serve ancora a qualcuno o a qualcosa? Sono, da un lato, molto dispiaciuto della tua ingenuità, che ancora si accanisce sugli aspetti contenutistici dei miei testi, frutto chiaramente di sbalzi d’umore (scrivo sempre di getto la risposta a quello che leggo, senza pensaci su nemmeno un secondo), e trascura gli aspetti di “posizione”, come dice Carla Benedetti, del soggetto parlante; dall’altro, però, mi torni molto simpatico e stimabile, perché l’ingenuità è segno di grandezza d’animo. Ma, come dicevo, la questione è un’altra, e sta piuttosto nelle domande che pone Montanari, e che io riprendevo a modo mio: quale etica è ancora possibile in queste condizioni di dialogo immunizzato? Chi esercita il controllo morale giusto, se tutti possiamo dire tutto di tutti, e, allo stesso tempo, anche l’esatto contrario, e, soprattutto, se non esiste da nessuna parte una idea di comunità di riferimento? Se, in poche parole, tutto diventa verbigerazione folle, e anzi, appena un argomento serio si appropinqua all’orizzonte, la prima regola è banalizzarlo, con una battuta veloce, un frizzo, un lazzo, una scostumatezza? Prendiamo proprio il nostro caso. Montanari, ad esempio, ti invita a discutere delle sue domande e di quelle che hanno posto altri insieme a lui, ma tu preferisci rispondere a me, che parlo come un umore impazzito. Ti sembra un caso? A me no, perché so che questa è la logica perversa del blog, perché il blog attira, per le cause che ho accennato sopra, come un vortice, e dà l’illusione dell’immediatezza e, quindi, dell’attimo pienamente goduto e compreso. Ma solo l’illusione, bada bene, solo l’illusione della verità, caro amico che vieni stordito da me che parlo a vanvera e così ti distrai dalle domande serie. Io non lo so, però mi pare che è in questa melma umorale che siamo impelagati tutti quando diventiamo scrittori di interventi in un blog, melma dalla quale, ripeto, forse Scarpa ha già deciso di “immunizzarsi” [Tiziano Scarpa, mentre si svolgeva questa discussione in NI, ha chiuso le finestre di commento ai suoi pezzi, impedendo quindi ai lettori di intervenire, ndr]: non risolvendo nulla per la comunità con la sua censura, ma forse risolvendo almeno i suoi problemi di “scrittore” che deve continuare a fare i fatti suoi, cioè a scrivere”.
*
Interviene il 15 settembre Montanari in polemica con Ant. Mart.:
“(…) Lei continua a chiedere agli altri di dire la loro sulla communitas, lo chiede a Moresco, a Helena, a Voltolini, ma questa benedetta communitas non è anzitutto il reciproco riconoscimento di un metodo di discussione? La communitas non è anzitutto comunicazione? Cosa dovrebbe fare Voltolini? Scrivere un breve trattato sulla communitas? Cosa ha fatto Moresco, che è stato rimproverato in una maniera per me incomprensibile? Moresco ha preso molto sul serio le opinioni di De Vivo e Virgilio, ha risposto, ha proposto una visione dinamica del rapporto fra comunità e opere, dicendo che non gli sembrava che la costituzione di una comunità dovesse per forza precedere le opere, che le due operazioni storicamente hanno sempre proceduto di pari passo. Stranamente, e lo dico senza ironia: stranamente, incomprensibilmente, questa sua presa di posizione è stata giudicata “elusiva”, “tardoromantica”, “superficiale”. A me sembra che Moresco abbia detto la sua, eccome! E mi sembra che questa opinione sia un contributo alla communitas, come lo è stata l’interpretazione del dibattito estivo proposta da Helena, come lo è lo spirito “illuminista” di Voltolini, che chiede, interroga, cerca letteralmente di fare luce e chiarezza.(…) La cosa banale è che, come diceva Bacone, credo, noi siamo più vecchi degli antichi, perché abbiamo più anni di loro, più secoli di storia e di pensiero su cui riflettere. Noi siamo in piedi sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto; siamo nani, ma, appunto, essendo in piedi sulle loro spalle, alla fine siamo più alti di loro. Può darsi benissimo che in termini di valore letterario e potenza di pensiero Scarpa sia alto un centimetro e Leopardi sia alto un chilometro; però Scarpa scrive adesso, dopo aver assimilato e messo in circolo, dentro di sé, l’opera di Leopardi; sta seduto sopra Leopardi, vede un centimetro (per me più di un centimetro, è chiaro…) più lontano di quanto poteva vedere Leopardi, per il semplice fatto che vede il contemporaneo e può parlarci della televisione, dell’elettronica, di internet, dei MacDonald, della trasformazione antropologica che stiamo subendo in questo momento, di cose che non c’erano al tempo di Leopardi. Cosa ci lascia Leopardi? La bellezza di ciò che ha scritto, e una riflessione profondissima sulla natura umana che in parte tocca il SUO contemporaneo (comportamenti, costumi, schemi relazionali che per noi possono avere solo valore storico), in parte invece abbraccia una serie di costanti, di invarianti di questa natura e di questo agire umano (comportamenti, costumi, schemi relazionali che hanno TUTTORA un valore conoscitivo enorme per tutti noi).
Cosa non può lasciarci Leopardi, essendo stato fornito di ogni dote possibile ma non dell’ubiquità temporale o dell’onniveggenza (se non in senso metaforico)? La descrizione del NOSTRO contemporaneo, del nostro tempo. È banale, ma va ricordato. Il centimetro di Scarpa ha un valore incalcolabile, perché coglie contenuti e modalità che Leopardi, per forza di cose non poteva cogliere; che nemmeno Pasolini, in realtà, poteva cogliere interamente, e parlo di un autore cronologicamente molto più vicino a noi, che ci ha lasciato sul nascente mondo della massificazione televisiva una testimonianza di pensiero straordinaria. Ricordiamoci che quelli che adesso ascoltano Mozart e ridono di Stockhausen o di Arvo Part sono, in ispirito, gli stessi che all’epoca di Mozart non capivano Mozart, lo chiamavano “nasone” e “cacciatore di dissonanze”, e l’hanno fatto crepare a 36 anni in un modo indegno, squattrinato, alcolizzato, amareggiato, distrutto. L’atteggiamento era lo stesso: la svalutazione del contemporaneo, il rifugio nella “buona musica” e nelle “buone letture”, solide, sicure, gustose, confortanti (…)”.
*
Dario Voltolini, rivolgendosi il 15 settembre a Ant. Mart., scrive:
“Basta così. È ora di un’autocritica. All’inizio di questa colonna c’è un testo di Helena nel quale è scritto che “nelle varie derive tematiche l’unico tratto continuativo” (nei commenti) è “la trasformazione degli autori in personaggi”. Questo era il punto di partenza, e naturalmente questo è il punto da cui, di deriva in deriva, ci si è allontanati. L’autocritica comincia qui. Io infatti ho dato per scontato che, poi ho trovato dove ho voluto conferme che, e in seguito mi sono assolutamente convinto che, l’autore della deriva fosse Ant. Mart. Ma è del tutto evidente che lo sono anche io. Precisamente perché ho di Ant. Mart. la visione e la percezione che si ha di un personaggio. Me lo immagino, credo di sapere cosa pensa, e così via. In verità quello che io credo di sapere di lui me lo sono fabbricato io e l’ho oggettivizzato con una mossa del tutto mia privata, del pensiero e dell’immaginazione. In altre parole: non ho che dei pregiudizi. Se rifletto, mi rendo conto che non solo non so nulla di lui, ma addirittura è probabile che creda il falso. Dico infatti “lui”, ma se fosse una “lei”? Chi mi ha mai detto se Ant. Mart. è maschio o femmina? Lo (la?) credo italiano(a), ma perché mai? Me lo (la) immagino piuttosto giovane, ma su quali basi? C’era in giro in rete, e forse ancora c’è, un sito accedendo al quale si riceveva in omaggio un grazioso testo narrativo postmoderno, scritto per l’occasione e per il navigatore di turno. Era un software, che scriveva il testo. Non era NESSUNO: era un software. Lì il gioco era palese e l’idea era quella di ironizzare sulle poetiche postmoderne, o su alcune loro epigonali derivazioni. Ma insomma, senza il paratesto che informava dello scherzo, avrebbe anche potuto trarre in inganno qualcuno. Bene, finisce qui la mia autocritica. Saluto Ant. Mart., maschio o femmina che sia, vecchia o giovane che sia, umana o sintetico che sia. E’ stato comunque un interessante test di Turing: se l’intelligenza di Ant. Mart. (come continuo a credere) è umana, bene così; se è artificiale, complimenti al software engineer (…)”.
*
Risponde il 16 settembre Ant. Mart.:
La Janecz. aveva ragione, ma aveva anche torto. Voltolini ha ragione, ma ha anche torto. Montanari aveva ragione, ma ha anche torto. Soltanto io ho sempre e solo ragione! Vi sembrerà strano, ma è così. Ora proverò a introdurvi alla dimostrazione di tale assunto (solo introdurvi, però, la dimostrazione tutta intera ci vuole ben più tempo e spazio).
Allora. La Janeczek ha ragione quando dice che si tratta solo di una gigantesca messinscena, ma sbaglia quando comincia a chiamarsi fuori, lei e i suoi amici, da questa messinscena, nella quale lei è personaggio come me e tutti gli altri. Da questo preciso istante, comincia la fetta di ragione di Voltolini, che questa cosa l’ha capita, ma sbaglia, anche lui, quando comincia a chiamarsi fuori da questa faccenda per andare a fare altre cose (presumibilmente più importanti). A questo punto, entra in scena (sic!) Montanari. Che ha ragione quando dice che quello che resta sono le opere, ma non si rende conto che lui qui dentro sta costruendo un’alta opera, l’opera al nero del suo fallimento come scrittore che infine si è autodeclassato a blogger. Il blogger, infine, sono io, soltanto io, il teppista della rete, che vi impedisce di parlare di cose serie con pose serie, ma vi fa sentire tutto il peso del vostro esser niente altro che esseri umani accalappiati da una rete. Molto piacere di avervi conosciuti, il mio nome è Umberto Eco”.
*
Reagisce Montanari il 16 settembre:
“Scusate, ma dopo quest’ultima capriola di Ant. Mart. io mi ritiro e vado a fallire come scrittore altrove, portandomi dietro l’impressione un po’ sconfortante di avere sopravvalutato il mio interlocutore. Non scriverò più una sillaba su questa colonna di commenti, che ormai è un cadavere. Ciao a tutti, ci si legge da qualche altra parte”.
(I – continua)

 Per la comunità avvenire - Redazione
Per la comunità avvenire - Redazione Media e mediatori - Carla Benedetti
Media e mediatori - Carla Benedetti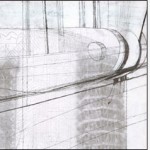 La Politica nella letteratura - Redazione
La Politica nella letteratura - Redazione Di necessità virtù - Redazione
Di necessità virtù - Redazione Giocattolo, museo, vita, morte
Giocattolo, museo, vita, morte Alla ricerca di una scrittura che non conosciamo
Alla ricerca di una scrittura che non conosciamo Il crogiolo magico svelatore/ 2
Il crogiolo magico svelatore/ 2 Se Dio non è morto
Se Dio non è morto





















