
L’abito verde
La mia natura è composta così, che a sentire il lutto portato dalle campane non si riesce più a continuare e sono costretto a lasciar perdere tutti i servizi, caricare gli attrezzi sul motore e riprendere la via di casa. Ci sono certe giornate, quando fa le secche di gennaio e la tramontana pulisce l’aria, che i colpi del morto si spingono fino a mare, allora è lungo attraversare la piana fino al paese, e mentre torno viene naturale il pensiero di chi è toccato, ma non insisto, siamo tutti vecchi da queste parti. Però se mi torna di rivedere quando è toccato a me, di essere vicino al trapasso, resto ancora colpito dal miracolo che ha tenuto insieme la mia corda.
Quando arrivo in casa non viene nemmeno il pensiero di mangiare, ma dopo le ore sulla terra devo mettere qualcosa nello stomaco, almeno una frisa bagnata, e qualche pomodoro con l’olio. Solo il vino lo butto giù volentieri. Poi mi lavo pulito, mi cambio e vado a portare il saluto. Vado sempre, anche se non sono in confidenza col morto. Èun riguardo che ho imparato da mio padre.
Potevano essere le contrade più sperdute, i Cappaddari, i Beddi, la Bardagola, però a sentire i colpi lunghi e ripetuti che arrivavano lenti dalla chiesa del paese, mio padre subito diceva di preparare l’asino, caricava e ci riportava a casa, me e mio fratello. Ci metteva qualcosa in bocca, ma prima dovevamo andare alla tinozza per le mani, le braccia e la faccia, e mentre controllava passava il pettine. Uscivamo con la camicia bianca, per andare alla visita.
Prima ancora di arrivare alla casa del morto, lungo le strade vicine, l’odore di lutto galleggiava nel silenzio rotto dai lamenti. Erano donne che mi spaventavano, questo coro di lacrime e urla, abiti neri, le mosse delle mani a stringere fazzoletti bianchi e braccia alzate nell’aria. Io non capivo quest’arte del pianto, girare il rosario con le dita veloci per tutta la veglia della notte, e le pose del lutto. Le prime volte tremavo di paura. Ma dopo ho imparato che tutto è naturale, la visita al morto, la notte seduti intorno alla cassa, e lasciare aperta la strada ai ricordi. Anch’io alla fine voglio andarmene dal mondo in grazia con tutti, accompagnato dal saluto degli amici, anche dei conoscenti lontani, mentre riposo l’ultima volta tra le mura di casa.
Non vorrei mai finire come succede in città. Mi hanno detto che i morti, nelle città, vengono lasciati soli, quasi nascosti, e nessuno fa visita. Li mettono negli ospedali, le ultime ore della vita, abbandonati come un vaso rotto, ma nessuno sa com’è la vita in quei momenti, nessuno torna a lamentarsi e allora ci vuole riguardo. Dopo il passaggio, portano il morto in piccole stanze, nelle città, vicino ai cimiteri, dove rimane in prestito dietro una porta, senza la gentilezza delle parole che accompagnano.
I morti hanno bisogno di sentire ancora l’alito della vita, come bambini da seguire nei primi passi. Cacciare via il morto senza il tempo per abituarlo al viaggio e godere un’ultima volta gli odori della casa, senza lo scricchiolio delle porte che si aprono piano e lasciano entrare la voce bassa degli amici, è come scaricare un peso dalle spalle col rancore sordo della fatica.
Io non ho mai detto di no a quello che la vita presenta, e ho visto tante cose coi miei occhi. Mai maledetta la fatica, anche il lamento per la stanchezza del respiro è stato leggero, anche al tempo della mietitura, sotto il sole di luglio, mentre si lavorava con la falce e le piaghe nelle mani senza asciugare il sudore.
Ho sempre avuto un pensiero, fin dagli anni giovanili, e se era possibile il miracolo di tornare indietro, allora io dico che volevo fare il musicista e seminare nel vento il suono dorato della tromba. Questo era il mio desiderio, girare con la banda nelle sagre, tutte le feste dei santi paesani, San Rocco, San Pietro, la Madonna del Carmine, l’Assunta, suonare a Diso, Ortelle, Poggiardo, anche Ruffano e portare le arie della Traviata, del Barbiere di Siviglia.
Vedo ancora adesso gli occhi della premura dolce di mia madre, quando mi voltavo verso di lei e poi tornavo a guardare le divise da suonatore d’orchestra, pulite, luccicanti, e le file sottili dei leggii, sotto la volta delle luminarie. Salivano su in cielo e mettevano a giorno la notte delle serate patronali.
Ma ho dovuto dimenticare la vocazione musicale e rinunciare al caldo che cercavo nella gonna di mia madre. Se n’è andata presto, nemmeno nove anni facevo, e mi è toccato prendere subito la via della campagna. E’ morta con le mani da bambina, senza calli, la pelle ancora liscia, che la terra rossa dei campi non aveva fatto in tempo a scavare.
Si è ammalata mentre scendevano le piogge d’autunno. Sapevo che era grave. La notte, prima di scappare nel sonno, stavo in ascolto, lottavo con la stanchezza per sentire il respiro che veniva dalla stanza vicina, e si faceva aspro. Lo sforzo era cercare l’aria da offrire ai polmoni e toglieva fiato anche a me, alle mie speranze. Ma non è durato a lungo il tormento. La polmonite le ha preso la vita in venti giorni.
Per il lavoro non c’è stato altrimenti. Qualche terra nostra, il fondo del padrone, e la fatica ha iniziato a stringere le mie ossa di bambino, stringeva già nell’ora che il sole galleggia sulle acque del mare.
Il tempo da piangere è stato poco, come per le disgrazie successe dopo. Ma a vederla morire ho pianto molto, perché nove anni è ancora un’età per piangere, anche se quando è spirata m’era già arrivato il dono del giudizio.
C’era il nonno dietro di lei, a tenerla un po’ sollevata, come seduta sul letto. Noi eravamo nell’altra stanza. Poi lei ci ha fatto entrare uno a uno per il saluto. Prima mio padre, poi io e dopo mia sorella. Quando è stato il momento di mio fratello aveva gli occhi già chiusi. Ha fatto bene a lasciarlo per ultimo, era piccolo e non poteva capire. Ricordo che all’inizio, se gli dicevo che la mamma non c’era più, lui rispondeva che allora bisognava chiedere al cielo di mandarne un’altra.
È stato un funerale povero, pochi fiori, le parole del prete, nemmeno i soldi per pagare la banda, ma nelle case non era rimasto nessuno, tutto il paese seguiva il carro funebre. La cosa più bella che ricordo è il suo abito verde, la mamma sembrava coricata in un prato lieve di germogli primaverili, un vestito bellissimo che per me era l’abito di una sposa. La sposa del Signore, dicevano le zie per consolarmi, e io non dovevo piangere se l’aveva chiamata in cielo. Lei era lassù, al suo cospetto, di sicuro contenta.
Io rimanevo zitto, non potevo alzare la parola contro le zie, e non sapevo nemmeno cos’era il cospetto, però non volevo credere a quello che dicevano, altrimenti mi toccava pensare che il Signore era malvagio a portarmi via la madre, e anche lei, se era contenta di essere lontana.
Il giorno del funerale, dopo la sepoltura, abbiamo fatto visita alla nonna, che stava a letto malata da due mesi, sapeva che la mamma soffriva, erano due settimane che non la vedeva, e sono lunghe per una madre malata che sente il passo della morte, che vuole specchiarsi le ultime volte negli occhi dei figli. Ma nessuno le aveva detto bene le cose, la malattia che correva, il peggio che veniva, e adesso nessuno riusciva a dirle che era uscito l’ultimo fiato.
Ma quel giorno d’autunno, dopo il funerale, quando siamo andati, lei ha chiesto proprio a me, e io ho dovuto girare la testa dicendo che la mamma stava meglio. Respira bene, dicevo, ma guardavo fuori della finestra. Il sole in quel momento sembrava coperto dalle nuvole, mentre poi, quando le zie mi hanno detto di uscire fuori, ho visto il cielo limpido, come un’estate che vuole ricominciare, e gli occhi si sono un po’ asciugati. Sentivo anch’io che c’era da tenere tutto nascosto, perché è un dolore contro natura, il pensiero di una madre che sopravvive ai suoi figli. Ma anche la mia era una ferita contro natura.
Poi sono tornato dentro, il bene della nonna mi tirava da lei, e guardare la sua faccia piena di rughe mi levava un po’ il male di dosso. È lì che ho fatto in tempo a sentire questa cosa strana che poi non ho più dimenticato tutta la vita, e l’ho sentita dalle parole precise della nonna.
Quello stesso giorno, alle prime ore del pomeriggio, si era addormentata, ma a un certo punto l’ha accarezzata un alito d’aria e l’ha svegliata all’improvviso. Allora, nella debole luce della stanza ha visto un’ombra, lassù in alto, vicino alla volta del soffitto. Era un abito verde che si muoveva come una foglia portata dal levante. La nonna ha detto che non sapeva, forse era un sogno, ma poi quell’ombra si è avvicinata al letto e lei ha riconosciuto che era sua figlia, con un’espressione che non poteva riconoscere se triste o felice.
Così, per tutta la mia età di bambino, io ho avuto il pensiero che mia madre, prima di andarsene per sempre, aveva fatto visita alla nonna, ma non ho mai creduto che l’espressione era incerta, la nonna s’era per forza sbagliata, come s’erano sbagliate le zie a dire che era felice in cielo.
Da allora, per anni, stando chino a zappare, ho avuto dei momenti con l’impulso di alzare la testa verso le cime degli ulivi, mi sembrava di avere dietro mia madre, là sulle fronde più alte, e mi guardava lavorare. Sentivo sopra di me i suoi occhi, la stessa premura che mi vegliava felice quando rimanevo immobile davanti alla banda dei suonatori. Ero sicuro che era diventata un angelo sorridente, contenta della forza che avevo nelle braccia. Ancora oggi succede qualche volta che mi giro di scatto a frugare con gli occhi tra le fronde d’ulivo, ma non trovo nessun abito verde e vedo solo l’azzurro del cielo sconfinato.
L’arsenale
Le giornate di pioggia passano lente per noi che abbiamo l’abitudine alla vita negli spazi aperti e bruciati dal sole. È un’abitudine che affonda con gli anni, e alla fine sembra naturale svegliarsi nel buio e sentire il piacere di uscire in mezzo al silenzio delle strade. Solo qualche motore che si accende lontano e il canto del gallo. Poi arrivare sui campi mentre il disco dorato del sole s’innalza dalla parte del mare.
Sono grandi fatiche, tutte queste nostre esistenze piegate verso il basso della terra sassosa. Dove con gli anni le ossa dell’uomo prendono le forme torte degli ulivi centenari, che da vicino, a vederli con la fantasia dei bambini, sembrano impediti a buttare in altezza la forza che hanno e salire dritti, come bloccati da una mano potente che li preme verso la terra, li costringe al giro di una vite.
Eppure, col tempo che scava l’abitudine, nessuno vuole smettere questo lavoro della campagna, nessuno rinuncia, anche se il sole arrosta la pelle, che diventa dura, lucida come il cuoio delle sacare. Il peso degli anni può arrivare fino al midollo e due braccia non bastare più a caricare i sacchi di olive, ma chi ha passato tutta la vita in questi spazi aperti non smette mai di sentire la rara dolcezza che si spreme dai frutti appena colti, o il sapore del pane tagliato all’ombra delle carrube.
Non è la povertà che dicono, a spingere verso la terra. Parlano per tener fede agli anni del passato, continuare a vedere le cose com’erano, quando mancava l’abbondanza.
È come rimanere fermi agli anni giovanili, quando le impressioni marchiano a fuoco la memoria. Oggi la pensione basterebbe a vivere, ma è stare chiusi dentro una casa, girare come anime dannate, che non è vita.
Eppure quando arrivano le giornate di acqua, per me sono benvenute lo stesso, anche se costringono negli spazi chiusi delle case, perché quando arrivano so come porre il rimedio. Io vado lassù, se piove, dove il tempo si regola sullo stesso scorrere della natura e la sera cala alla medesima ora. Vado lassù dove raccolgo ogni cosa, tutto quello che tiene dentro anche solo un grammo del lavoro dell’uomo, e che un giorno potrò usare ancora.
L’avevo iniziata per il figlio grande, questa casa attaccata alla mia, vent’anni fa, quando voleva andare sposo e vivere vicino a noi. Erano quattro sedili di terra che avevamo a giardino con limoni e aranci. Abbiamo tirato su il rustico, due piani, e la scala che porta al terrazzo. Poi è uscita l’occasione, diceva, e lui è partito al Nord. L’opera è stata abbandonata.È ancora com’era vent’anni fa, nemmeno l’intonaco, e le tracce delle condotte elettriche scavate nei pezzi di tufo. Anche la porta che mette sulla strada è fatta di quattro assi inchiodate. Anche i ferri dell’armatura si sono stancati dell’attesa e cominciano a uscir fuori facendosi largo nel cemento.
Ma quando faccio passare la calce sul muro della mia vecchia casa, a vedere la vecchia casa così bella e nuova, e bianca, e la nuova così vecchia e cadente, mi torna la voglia di finire il rustico. Penso a un dovere lasciato a metà, per pigrizia. Disturba una vecchia casa bianca e pulita, di fianco a pareti di pietra grigia, tagliata male, col cemento scrostato tra un pezzo e l’altro.
Non potevo saperlo, ma questo rustico è diventato il posto che preferisco quando piove, il deposito della mia vita. Raccolgo tutto, là dentro, anche piccole cose, anche le viti e i chiodi che metto in una valigia di legno con le cerniere arrugginite. L’ho avuta in dote dalla Marina Militare Italiana, quando ho prestato il servizio quarant’anni fa.
Io dimentico dove va a finire questa valigia, so solo che sta da qualche parte in quelle stanze, forse vicino al recinto delle galline, o forse di fronte, dove tengo i quintali di grano e orzo chiusi nei bidoni. Ci sono anche la casse delle noci, lassù, le pendule dei pomodori d’inverno appese alle pareti, le trecce d’aglio, i mazzi di peperossi, gli scaffali con la salsa e la conserva amara.
Se devo trovare un chiodo lungo, che mi serve per tirare una corda nei campi, devo cercare quella valigia, ma non sapere dove l’ho messa, di preciso, mi fa contento, certi giorni. Girare per quelle stanze a cercarla. Fa rifiorire la mia memoria appassita, come le zine che prendono l’acqua, perché ogni cosa che vedo spolvera il ricordo. La cerco e vedo le reti arrugginite del primo letto di matrimonio, il 1955, l’anno che il paese s’era allagato. E il miele dei ricordi si scioglie in bocca.
E se non la trovo, continuo a cercare in mezzo ai teli rotti delle olive, che uso a coprire la vigna d’estate, quando il sole asciuga ogni pozza e la siccità spinge la razza della picalò a dissetarsi negli acini succosi.
E se non la trovo ancora, la cerco vicino al vecchio Motom, che non ho mai voluto vendere, neanche quando Padaro Michele mi voleva dare una bicicletta nuova in cambio, perché sul quel Motom per anni abbiamo camminato in quattro, io e mia moglie coi figli maschi, e sento la soddisfazione anche solo a guardarlo.
Non importa se dimentico e se ci metto del tempo a trovare la valigia. Non fa niente, perché a cercarla lassù, a camminare in mezzo all’arsenale che ho raccolto, mi dà il piacere di riconoscere le cose, e ricordare come ci sono finite, proprio il momento, anche l’anta di una porta o le camere d’aria bucate, che taglio quando ho bisogno di elastici.
Mio figlio più giovane dice che c’è disordine e bisogna mettere a posto. Anche mia moglie, se viene qualche forestiero, non vuole farlo salire lassù. Mi lancia una voce per farmi scendere, urlando dal giardino, ma io di solito non sento, e anche se anche mi arriva bene, anche se posso interrompere i miei lavori, rimango dove sono.
Allora quando piove e non è tempo per andare nelle campagne, il mio posto è quello. Mi piace così com’è, in tutto quel mescolamento disordinato. Entro, faccio un giro all’inizio, per vedere cosa c’è da fare, butto l’occhio da una parte all’altra, vedo se casomai conviene tagliare qualche stozzo di legna, o lavare una damigiana vuota, o pulire i cannizzi del tabacco, e mi metto all’opera. Sempre con la lentezza di un uomo libero.
Poi faccio un altro giro, su e giù per le scale. Anche le stanze di sotto, dove tengo gli attrezzi di campagna, e cammino contento, pure a guardare le scarpe vecchie, quelle che mandano i figli. Per loro, in un anno sono già consumate, e camminano solo sugli asfalti. Per me sono come nuove, e quando le consumo veramente, a girare coi secchi pieni sulle terre sassose, quando si aprono di sotto, io rifaccio la suola, oppure aggiusto un tacco. Non concepisco gettare le scarpe con la tomaia ancora buona. Prendo il martello ricurvo e sottile, l’incudine da scarparo, i chiodi, la colla, e i giorni che piove passo un’ora intera a lavorare, come facevo a dodici anni, dopo che era morta mia madre e dovevo imparare a farmi le scarpe da solo. Non belle, non dico, ma duravano anche un anno sui cuti pizzuti del Mito.
Ho un piacere che non so proprio dire a stare lassù, c’è la mia soddisfazione per le cose raccolte, in quelle case che sembrano un rudere, senza finestre e senza porte, solo buchi rattoppati con le pietre, che i gatti attraversano di giorno e di notte. Sbucano da un punto e ne fuggono con una testa di pesce rostito in bocca. Si arrampicano sui muri e soffiano se da qualche parte hanno fatto la tana per partorire, magari in mezzo ai vecchi materassi o tra i fisculi del frantoio. Quando sento miagolare, appena entro, e poi subito dopo, mentre cammino, smettere di colpo il miagolamento di richiamo, mi chiedo come fanno i cuccioli a imparare il silenzio per la paura dei passi.
Dicono che perdo tempo lassù, ma se piove ci sto anche un giorno intero, a spostare cisterne, pulire zinni di olio con la soda caustica, battere zappe, o ripassare con la lima le punte della sega per la monnatura. Esco solo per mangiare, perché vado piano e i lavori vanno fatti precisi, come il taglio della zappetta, che deve essere un rasoio per levare la gramigna. Lo tiro a colpi di martello, uno speciale da fabbro che aveva già mio padre, e potrei usarlo veramente per la mia vecchia barba.
Vado lassù non appena il cielo è nero di nuvole e l’acqua aspetta ancora per scendere, e ci sto rintanato come il topo. Se a metà mattina mi sento chiamare, non rispondo anche perché sono contento se vengono loro a vedere il mio museo, e vedo che poi vengono volentieri, perché piace a tutti stare lì. Arrivano, si siedono su un ceppo di legno, una sedia rotta, buttano il granoturco alle galline, guardano beccare, prendono in mano l’ascia, provano la lama mentre cominciano a parlare. Vengono fuori i discorsi, lassù. Cominciano loro, oppure io, non importa, e stiamo anche ore a parlare. Tornano fuori le cose degli anni giovanili, nei giorni di pioggia.
Andiamo in mezzo alla memoria lontana, e ci prendiamo il tempo, perché il periodo che si faticava a giornata è ormai finito per noi.
Poi stare a parlare in mezzo a quei quintali di grano asciutto riempie il cuore. Qui abbiamo da mangiare per dieci anni, e non c’è esagerazione, dieci anni se c’è bisogno, anche di più, che se occorre si può tornare a mietere col falcetto, e poi le galline e i conigli. Per il resto pane, olio, pomodori e vino, e chili di fagioli, ciceri, lenticchie e piselli, tutte cose nostre. Ce n’è tanta di quella roba, da campare anni senza passare al negozio dei generi alimentari.
Io non riesco abituarmi a cacciare con la lira. Non mi sono mai abituato a mangiare coi soldi, mi viene su qualcosa, da dentro, che mi indurisce i nervi. Mettere mano al portafogli per le cose da cucinare, non so dire, forse perché quello che faccio io so cos’è, nelle mie terre. Non uso medicine in campagna, nemmeno pompare le piante contro gli insetti, niente, e se le pesche sono piccole non importa, vale il sapore, e se c’è la punta della farfalla, vuol dire che era dolce anche per loro.
Se non fosse per quei vagabondi che vanno a rubare, terrei anche un vitello in campagna, un maialino, da tirare su con tutte le ghiande del querceto, le pere e le mele, che rimangono sugli alberi, tante sono. Quintali che poi cadono intorno quando arriva la stagione. Un vitellino si fa grande e ci sarebbe carne per tutti.
Invece questi figli di Giuda che vengono di notte, spaccano tutto, lasciano bottiglie rotte sparse nei campi, senza un perché. Allora rinuncio. Un anno hanno aperto la porta del mio rustico in campagna e hanno preso venti litri di benzina agricola, tutta la tanica. Non c’era altro da prendere, perché la pompa dell’acqua la porto sempre a casa. Carico la mattina, sull’ape, arrivo in campagna e scarico, poi di sera ricarico ancora sull’ape, e torno a casa a scaricare. Vedo che cresce questo sistema, di venire la notte a dare un danno inutile, com’è successo quando ho trovato le teste dei carciofi tagliate per dispetto, le piante spezzate, sparse a terra e pestate, e non per fame. Mi chiedo a cosa serve tutta questa malvagità, ma inutilmente, sono destinato a non capire più il mondo.
È per questo che galline e conigli stanno qui, nel mio rustico, dove vado quando piove.
Poi sono anche contento se la campagna si rinfresca, quando piove, finisce che si rinfresca anche la memoria, quando viene qualcuno a fare visita, i giorni di pioggia. Un cugino di Ortelle, o mio cognato Cosimo, oppure mio fratello Pazio, che quando arriva ha il gusto di rimanere ore nel fiume dei discorsi. Saltano fuori anche dei nomi antichi, per caso, che nemmeno uno sforzo farebbe più ricordare, come l’altro giorno quando mio fratello Pazio è entrato, ha messo un mazzo di finocchi sulla panca, ha guardato la bicicletta arrugginita che mi aveva lasciato mio padre, e gli è venuta in mente Massafra Lucia.
Era tanto che non pensavo a quel nome.È venuto fuori come un fulmine.
Ti ricordi quando andavamo al cimitero la domenica sera, con questa bicicletta, a vedere se c’era Massafra Lucia? Così ha detto mio fratello.
Allora ho rivisto tutto, lei che stava inginocchiata sulla tomba, noi che facevamo un cenno di saluto, e poi gli anni prima, quando eravamo bambini e la vedevamo uscire da scuola mentre tornavamo dalla campagna tirando la corda dell’asino carico d’erba.
Ma questa è una storia lunga e ha bisogno di un fiato che adesso non ho più.

 Il sacchetto - Ivan Levrini
Il sacchetto - Ivan Levrini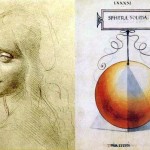 Il 25 aprile - Ivan Levrini
Il 25 aprile - Ivan Levrini In ascolto del destino - Daniele Benati
In ascolto del destino - Daniele Benati La moglie di Nietzsche
La moglie di Nietzsche Dante Alighieri
Dante Alighieri





















